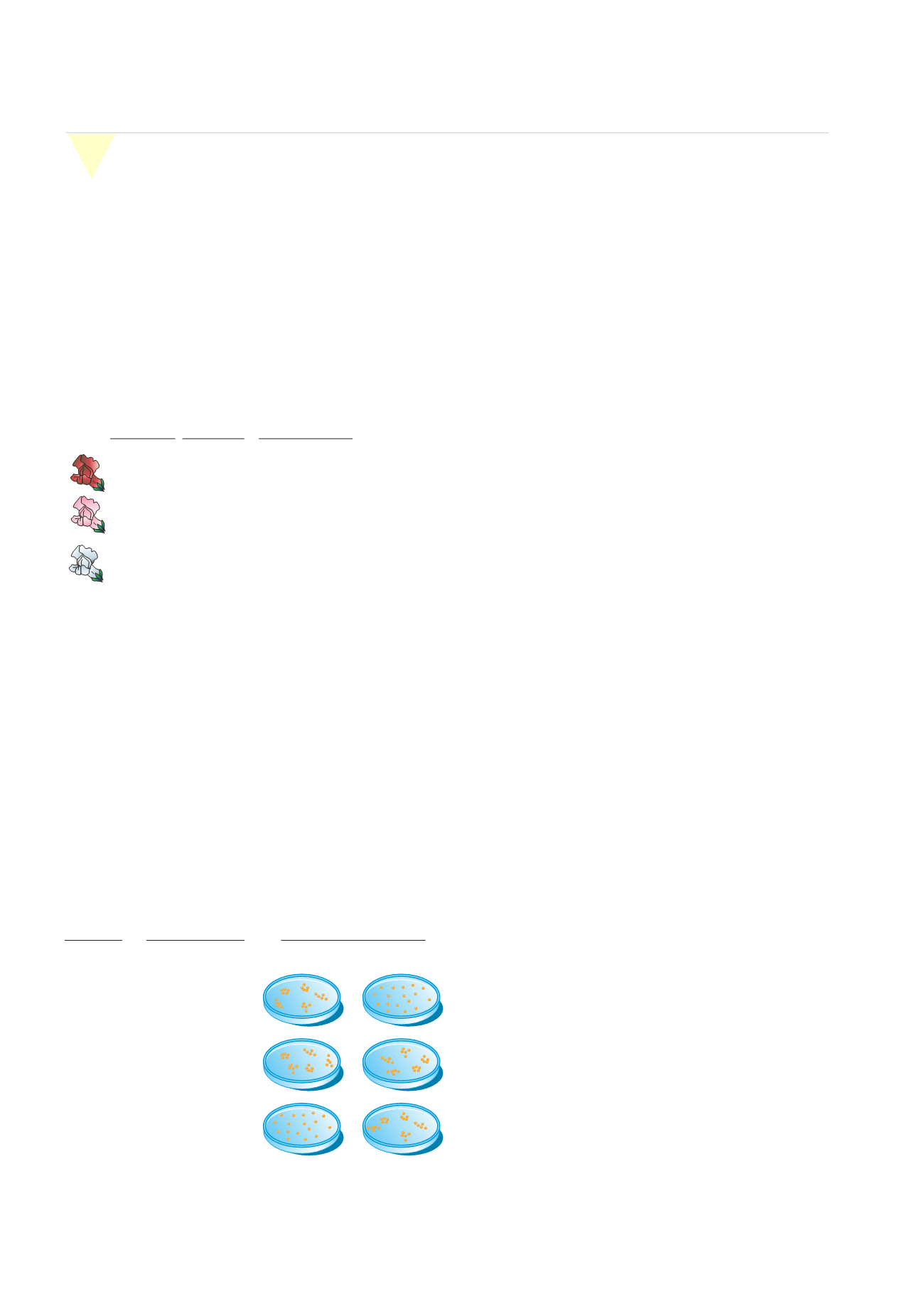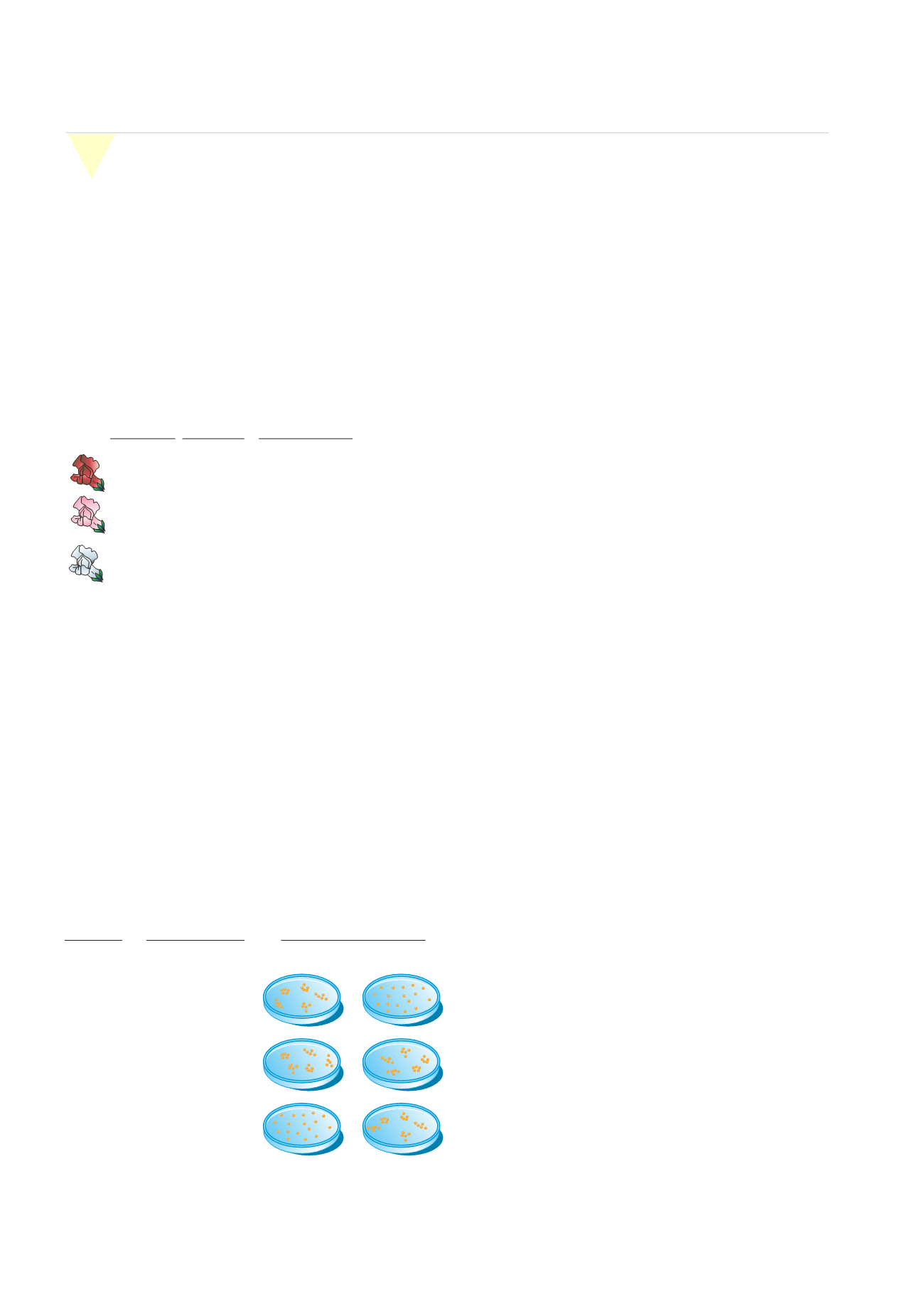
64
Capitolo 4
Estensioni del mendelismo
Gli esperimenti di Mendel stabilirono che i geni po-
tevano esistere in forme alternative. Per ognuno dei
sette caratteri studiati
2
colore e forma dei semi, al-
tezza della pianta, colore e posizione dei fiori, forma
e colore del baccello
2
Mendel identificò due alleli, uno dominante e l’altro recessivo. La
sua scoperta suggerì una semplice dicotomia funzionale tra alleli: sembrava che un allele
non contribuisse per nulla e l’altro fosse completamente responsabile della determinazione
del fenotipo. La ricerca all’inizio del ventesimo secolo, tuttavia, dimostrò che quest’idea
era una marcata semplificazione. I geni, infatti, possono esistere in più di due stati allelici
e ciascun allele, inoltre, può avere un differente effetto sul fenotipo.
DOMINANZA INCOMPLETA E CODOMINANZA
Un allele è dominante se ha lo stesso effetto fenotipico nell’eterozigote
e nell’omozigote
2
in pratica, se i genotipi
Aa
ed
AA
sono fenotipica-
mente indistinguibili. A volte, l’eterozigote ha un fenotipo diverso da
quello dei suoi omozigoti corrispondenti, come succede, ad esempio,
per il colore dei fiori in
Antirrhinum majus
, o bocca di leone. Varietà
bianche e rosse sono omozigoti per alleli differenti di un gene che de-
termina il colore; quando sono incrociate, producono eterozigoti che
hanno fiori rosa. L’allele per il colore rosso (
W
) è quindi detto
incom-
pletamente
o
parzialmente dominante
rispetto a quello per il colore
bianco (
w
). La spiegazione più probabile è che l’intensità della pigmen-
tazione in questa specie dipenda dalla quantità di un prodotto sintetiz-
zato dal gene del colore (
j
Figura 4.1
). Se l’allele
W
lo produce, mentre
l’allele
w
non lo fa, gli omozigoti
WW
avranno una quantità di prodotto
doppia rispetto a quella degli eterozigoti
Ww
e, quindi, mostreranno
un colore più marcato. L’allele parzialmente dominante è descritto a
volte come
semidominante
(dalla parola latina che significa “metà”), se
il fenotipo dell’eterozigote è intermedio tra il fenotipo dei due omozigoti, come nel caso
appena descritto.
Un’altra eccezione al principio della dominanza semplice si verifica quando un etero-
zigote mostra caratteristiche osservabili in ognuno degli omozigoti. Questo si verifica nel
caso dei gruppi sanguigni umani, identificabili con un esame per rilevare speciali prodotti
cellulari chiamati
antigeni
. Un antigene è identificato in base alla sua capacità di reagire
con fattori ottenuti dalla porzione sierica del sangue. Questi fattori, che sono prodotti dal
sistema immunitario, riconoscono gli antigeni in maniera molto specifica. Per esempio,
un siero, chiamato anti-M, riconosce solo gli antigeni M dei globuli rossi; un altro siero,
chiamato anti-N, riconosce solo gli antigeni N su queste cellule (
j
Figura 4.2
). Quando
uno di questi sieri identifica il suo specifico antigene in
un test di tipizzazione del sangue, i globuli si saldano tra
loro, in una reazione chiamata
agglutinazione
. Un tecnico
biosanitario può quindi identificare, mediante un esame
per l’agglutinazione con diversi sieri, quali antigeni siano
presenti e determinare quindi il gruppo sanguigno.
La capacità di produrre antigeni M ed N è determi-
nata da un gene con due alleli. Un allele permette che sia
prodotto l’antigene M; l’altro permette che sia prodotto
l’antigene N. Gli omozigoti per l’allele M producono solo
antigeni M e gli omozigoti per l’allele N producono solo
quelli N; gli eterozigoti per questi due alleli producono
entrambi i tipi di antigeni. Dato che gli alleli sembrano
contribuire egualmente al fenotipo degli eterozigoti, essi
sono detti
codominanti
. La codominanza implica che c’è
un’indipendenza della funzione allelica. Nessuno degli al-
leli è dominante o parzialmente dominante sugli altri. Sa-
rebbe, quindi, inappropriato distinguere questi alleli me-
Le diverse forme alleliche dei geni
influenzano i fenotipi in modi differenti.
Variabilità allelica e funzione genica
Fenotipo Genotipo
Quantità di
prodotto genico
Rosso
Rosa
Bianco
WW
Ww
ww
2
x
x
0
j
FIGURA 4.1
Base genetica del colore del fiore
nella bocca di leone. L’allele
W
è parzialmente
dominante su
w
. Differenze tra i fenotipi pos-
sono essere dovute a differenze nella quantità di
prodotto specificato dall’allele
W
.
Gruppo sanguigno
(antigeni presenti)
Genotipo
M
(M)
M N
(M e N)
N
(N)
L
M
L
M
L
M
L
N
L
N
L
N
Siero anti-M
Reazioni con l’antisiero
Siero anti-N
j
FIGURA 4.2
Rilevamento degli antigeni M ed N su cellule del
sangue mediante agglutinazione con specifici antisieri. Con i
sieri anti-M e anti-N possono essere identificati tre gruppi san-
guigni.