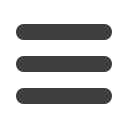
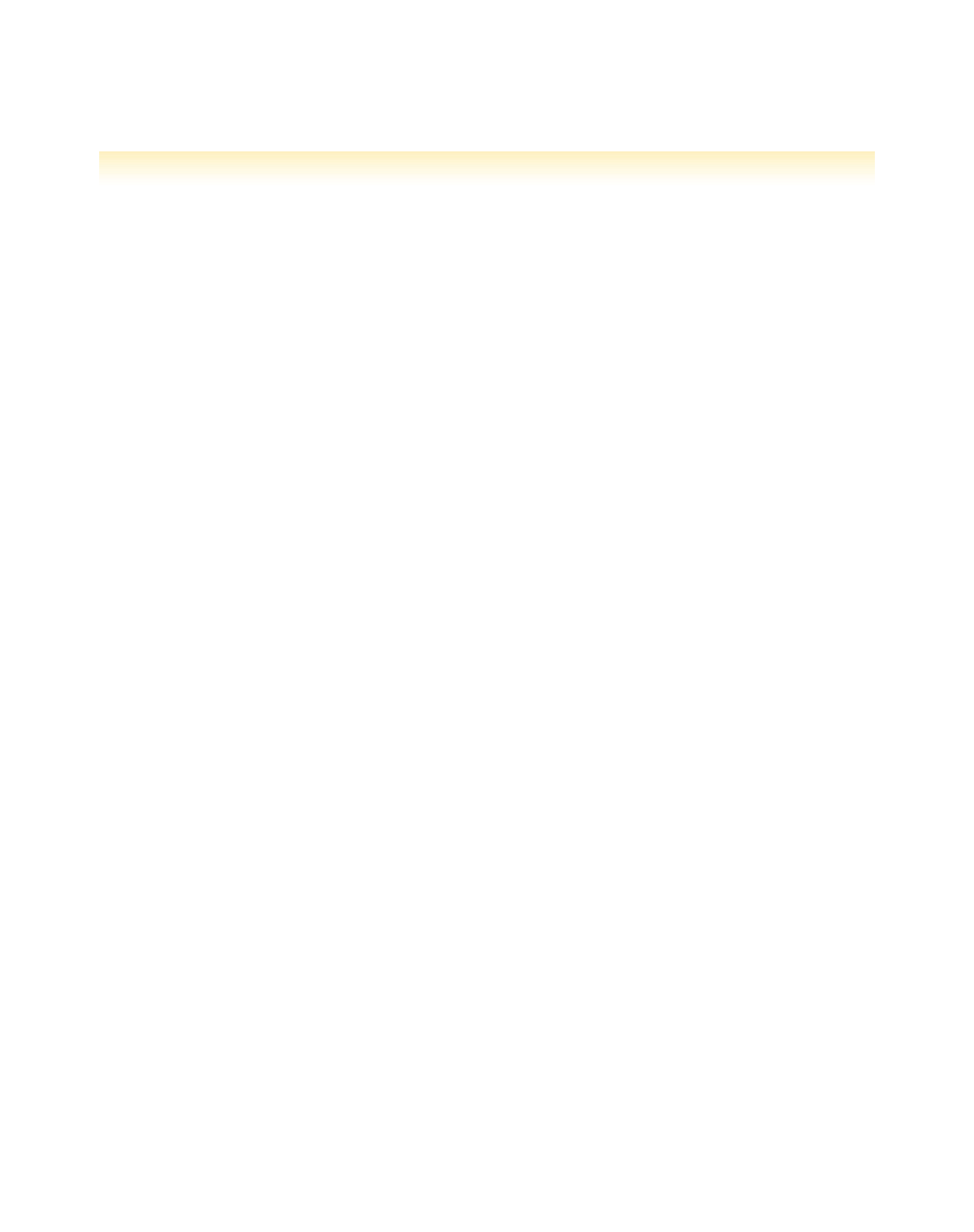
100
C A P I T O L O 4
Conduttori. Dielettrici. Energia elettrostatica
4.1
Che differenza c’è tra la carica netta presente su un con-
duttore carico e la carica libera interna allo stesso?
4.2
Un conduttore ha elettroni liberi solo se ha un eccesso di
carica negativa?
4.3
Un conduttore ha una carica
q
= 1.6 · 10
–9
C. Quanti elet-
troni ha ceduto nel processo di carica? Quanta massa ha
ceduto?
4.4
Una sferetta conduttrice appesa ad un filo di seta è so-
spesa in un campo elettrostatico
E
. Quanto vale il campo
elettrostatico
E
all’interno della sferetta? Varia la risposta
se la sferetta è carica?
4.5
Due conduttori con carica di segno opposto vengono po-
sti a contatto. Perché all’equilibrio la carica sui due con-
duttori non può essere di segno opposto?
4.6
Due sfere conduttrici di raggi
R
1
e
R
2
, con
R
1
>
R
2
, sono
collegate da un filo conduttore. Su quale sfera la carica è
maggiore? Quale sfera ha densità di carica
σ
maggiore?
Su quale sfera il campo elettrostatico
E
è maggiore?
4.7
Se il potenziale elettrostatico di una persona posta su un
supporto isolante aumenta di 10000 V che cosa succede
alla persona? Perché alla persona si rizzano i capelli?
4.8
Perché spesso uscendo dalla macchina e chiudendo la
portiera scocca una scintilla tra la mano e la maniglia?
4.9
Spiegare l’origine del bagliore che si osserva talvolta sulle
linee elettriche ad alta tensione.
4.10
Se si comunica una carica ad un conduttore di forma cu-
bica: a) dove sarà maggiore la densità di carica
σ
e b)
dove sarà maggiore il campo elettrostatico?
4.11
Perché bisogna evitare le punte e i bordi spigolosi nelle
apparecchiature ad alta tensione?
4.12
Il campo elettrostatico
E
int
all’interno di una sfera condut-
trice cava è nullo. Come varia
E
int
se il conduttore ha forma
irregolare? Come è il potenziale elettrostatico all’interno?
4.13
Un conduttore cavo possiede una carica netta
q
. Una sfe-
retta metallica con carica –
q
viene calata nell’interno at-
traverso un’apertura praticata sulla parte superiore e
mantenuta sospesa (pozzo di Farad). La carica netta sul
conduttore cavo è variata? La carica netta sulla superficie
esterna è variata? Se si estrae la sferetta le condizioni ini-
ziali sono ripristinate?
4.14
Due conduttori cilindrici, sottili, montati su due supporti
isolanti, sono posti in contatto per un estremo. Una bac-
chetta di plexiglass carica viene posta davanti ad un cilin-
dro e quindi, sempre con la presenza della bacchetta, i
due cilindri vengono separati. Allontanata la bacchetta
cosa si può dire della carica netta sui due cilindri?
4.15
Un conduttore cavo a forma conica è montato su un sup-
porto isolante. Si introduce all’interno una bacchetta di
ebanite carica, senza toccare il conduttore, e simultanea-
mente si tocca con un dito il conduttore dall’esterno.
Quando si estrae la bacchetta il conduttore rimane ca-
rico? Dove si distribuisce la carica? Dov’è maggiore la
densità di carica?
4.16
Una pallina caricata sospesa ad una corda viene attratta
quando la si pone vicino ad un piano conduttore. Perché
accade ciò? Si può dire qualcosa sul segno della carica
della pallina?
4.17
Una sfera conduttrice viene avvicinata ad una sfera con-
duttrice carica. Perché la sfera viene attratta anche se non
ha carica?
4.18
Una sferetta conduttrice che possiede una piccola carica
q
viene avvicinata ad una sfera avente una carica
Q
>>
q
dello stesso segno. Perché la sferetta viene attratta pur
avendo carica dello stesso segno?
4.19
Come si può schermare un laboratorio o un circuito dai
campi elettrici dispersi?
4.20
Perché i parafulmini sono fatti a punta?
4.21
Gli abitanti di un grattacielo con pilastri d’acciaio sono
più al sicuro di quelli di una casa di legno durante un
temporale?
4.22
La capacità di un condensatore dipende dalla carica e/o
dalla differenza di potenziale?
4.23
Perché ai bordi di un condensatore piano ideale è neces-
saria la presenza del campo elettrostatico
E
disperso?
4.24
Un condensatore piano ha le armature di area
Σ
distanti
h
. Come varia la capacità se: a) la distanza tra le armature
diventa 2
h
, b) se la distanza tra le armature diventa
h
/2 e
c) se le due armature vengono fatte scorrere finché l’area
delle superficie sovrapposte è
Σ
/2.
4.25
Tra le armature di un condensatore piano distanti
h
viene
inserita una lastra di materiale conduttore di spessore
s
=
h
/2. Come varia la capacità del condensatore? Se il
conduttore è carico ed è isolato, aumenta o diminuisce
l’energia elettrostratica
U
e
immagazzinata?
4.26
Un condensatore piano carico è montato su un supporto
isolante con le due armature collegate ad un elettrosco-
pio. Quando si inserisce all’interno una lastra di ebanite
le foglioline dell’elettroscopio si chiudono, per ritornare
alla condizione iniziale quando la lastra viene estratta.
Date una spiegazione di questo esperimento.
4.27
Tra le armature di un condensatore distanti
h
viene inse-
rita una lastra di materiale dielettrico di costante dielet-
trica relativa
κ
. Come varia la capacità del condensatore?
Se il condensatore è carico ed è isolato aumenta o dimi-
nuisce l’energia elettrostatica
U
e
immagazzinata?
4.28
Se la differenza di potenziale
V
tra le armature di un con-
densatore piano viene raddoppiata come varia l’energia
elettrostatica
U
e
immagazzinata?
4.29
Le armature di un condensatore piano carico isolato ven-
gono allontanate in modo da raddoppiare la distanza. Di
quanto varia l’energia elettrostatica
U
e
immagazzinata?
4.30
Una coppia di condensatori può essere collegata in serie
e in parallelo e il sistema così ottenuto collegato ad un ge-
neratore che fornisce una differenza di potenziale
V
. In
quale dei due sistemi si immagazzina più energia elettro-
statica
U
e
?
4.31
Perché non si può caricare un isolante per induzione elet-
trostatica con lo stesso metodo seguito con i conduttori?
4.32
Un leggero cilindretto di sambuco (dielettrico) è sospeso
ad un filo di seta. Se ad esso viene avvicinata una bacchetta
di plexiglass carica il cilindretto tende a portarsi a contatto
con la bacchetta, seguendo i suoi movimenti. Se avviene il
contatto il cilindretto viene respinto. Dare la spiegazione di
entrambe le fasi, precisando in particolare: perché il cilin-
Q
UESITI
















