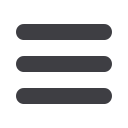
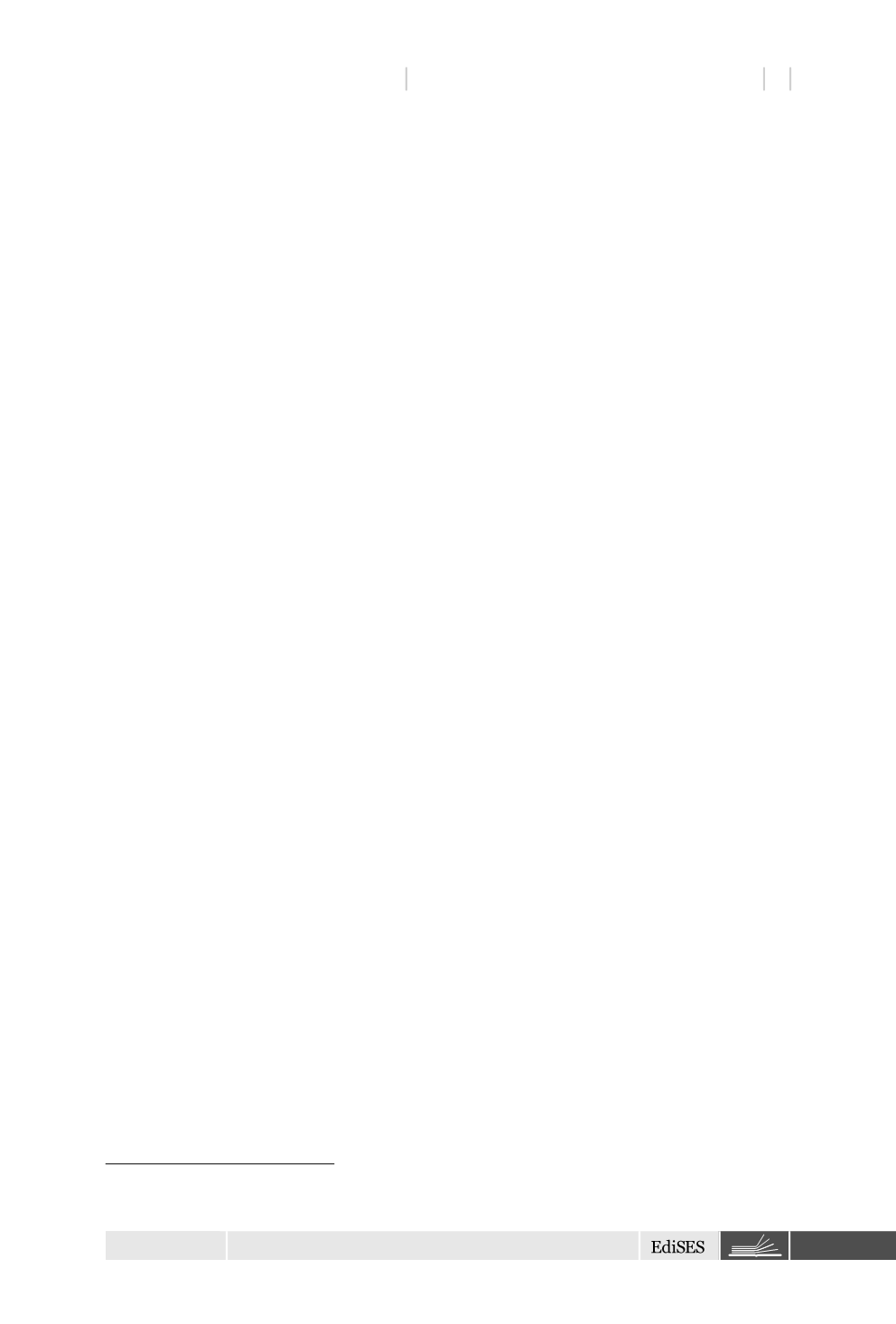
www.
edises
.it
L’insegnamento della geografia nella scuola italiana
9
modelli utilizzati per descrivere le dinamiche funzionali, la Geografia ha potuto
dare un contributo alla pianificazione territoriale e intervenire operativamente
nella gestione del territorio.
Le nuove correnti geografiche che si sono sviluppate dal secondo dopoguerra
in avanti – la geografia funzionale, quantitativa e strutturalista, la geografia
culturale, la geografia sociale – hanno operato il passaggio dal tradizionale
approccio idiografico descrittivo a quello nomotetico e interpretativo. L’affer-
marsi dei concetti di struttura e di gravitazione applicati allo studio delle aree
di polarizzazione di attività industriali e del terziario ha rappresentato la base
del “funzionalismo geografico”.
I
modelli funzionalisti
, sincronici, a partire dagli anni Settanta hanno eviden-
ziato i loro limiti a causa della loro staticità. Le moderne dinamiche territoriali,
in rapida evoluzione, richiedevano nuove soluzioni ai problemi e sollecitava-
no lo sviluppo di nuovi strumenti di indagine. Lo strutturalismo funzionale è
stato quindi integrato e superato dalla
teoria sistemica
: un nuovo paradigma
secondo il quale le proprietà essenziali di un organismo o di un sistema vivente
sono superiori alla somma delle singole parti di cui sono costituiti. Il sistema si
sviluppa grazie alle interazioni e alle relazioni tra le parti; tali proprietà olistiche
si perdono quando si isolano i singoli elementi
15
.
La Geografia ritrova, in tal modo, un ruolo competitivo nei confronti delle altre
aree del pensiero scientifico. Superata la fase della fiducia assoluta nell’indagine
quantitativa a seguito del fallimento dei modelli dell’economia pianificata, si è
giunti ad una riflessione che ha portato a nuove forme di convergenza discipli-
nare, che attribuiscono maggiore attenzione ai problemi sociali. Il paesaggio
viene quindi letto in chiave storico-culturale oltre che funzionale, utilizzando
alcuni schemi di riferimento – come il rapporto centro-periferia o la salvaguardia
ambientale – capaci di unificare le diverse metodologie di approccio.
Ripercorriamo ora brevemente le tappe evolutive del pensiero geografico.
La geografia quantitativa (strutturalista) e lo spazio funzionale.
Lo struttura-
lismo è quella corrente di pensiero che vede la realtà come un complesso di
elementi che interagiscono tra loro, usa dati oggettivi e misurabili per esaminare
il territorio nell’insieme degli elementi che lo costituiscono, utilizza dunque la
metodologia quantitativa.
La geografia quantitativa si contrappone a quella tradizionale per l’impiego di
metodi matematici avanzati e l’applicazione di modelli agli studi delle dinamiche
antropiche sul territorio. Sostituisce all’approccio induttivo quello deduttivo,
definendo, con le parole del geografo Paul Claval, una “nuova geografia”.
La geografia quantitativa introduce i concetti di “centralità” e “polarizzazione”,
che superano il dualismo natura-uomo dei precedenti paradigmi geografici.
15
C. Ruggieri, “I sistemi territoriali tra crescita e sviluppo”,
Geografia dello sviluppo
, Uniroma,
2004-2005.


















