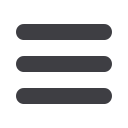

www.
edises
.it
12
Premessa
decision-making, della costruzione di mappe mentali. Parte importante del set-
tore è anche lo studio delle rappresentazioni spaziali e territoriali, la percezione
del rischio territoriale e i comportamenti umani su “microscala geografica”. Il
nome deriva da
behaviourismo
(in italiano,
comportamentismo
), paradigma domi-
nante in psicologia negli anni Sessanta e Settanta.
La geografia culturale.
Il geografo Adalberto Vallega
17
sostiene che la geografia
culturale può essere definita una scienza-ponte che dialoga con molte discipline:
la semiotica, la poetica, la sociologia, l’estetica e altre ancora.
Principale esponente della geografia culturale è
Paul Claval
(1932), autore de
La géographie culturelle
. La geografia culturale legge il territorio attraverso la fitta
rete di segni che vi sono inscritti e per decodificarli si avvale di prospettive che
rispecchiano i diversi indirizzi. Ad esempio, studiando la popolazione di un
dato territorio si analizzano fattori oggettivi quali la lingua, la religione e le loro
interdipendenze secondo l’impostazione strutturalista; si evidenzia come questa
popolazione abbia rappresentato il territorio dove risiede attraverso la pittura e la
musica, secondo la corrente semiotica; si leggono quindi i simboli attribuiti dalla
popolazione alla natura e alla trascendenza, secondo la corrente spiritualista.
A sintetizzare
i principi del moderno approccio geografico nell’opera
L’organiz-
zazione sociale ed economica degli spazi terrestri
è stato
Pierre George
(1909-2006),
che si è occupato di geografia umana, economica e sociale. Geografo, è stato
direttore dell’Institut de Démographie dell’Università di Parigi I, professore
all’Institut d’Études politiques, redattore capo del
Dictionnaire de la géographie
e
condirettore della rivista
Annales de Géographie
.
Secondo George, la superficie terrestre viene rimodellata da una nuova “cro-
sta tecnica” che si sostituisce ai paesaggi tradizionali che l’uomo ha costruito
nei secoli. Anche là dove la natura apparentemente mantiene i suoi normali
avvicendamenti, si impone la presenza umana: con interventi diretti, come nel
caso delle aree recuperate all’agricoltura in ambiente subdesertico (tecniche
di aridocoltura) o in quello della segregazione artificiale alla quale certe aree
naturali vengono sottoposte perché fungano da riserva per la conservazione di
specie animali e vegetali in via di estinzione (i parchi naturali).
Nessun elemento della superficie terrestre sfugge all’influenza umana, che im-
pone nuovi ruoli e nuove funzioni al territorio. Le categorie tradizionali che il
geografo impiegava per interpretare i fenomeni terrestri non sono più utilizzabili:
si modifica lo stesso rapporto psicologico tra l’uomo e il suo ambiente. George
si pone il problema del bilancio degli effetti “costruttivi” e di quelli “distruttivi”
dell’era delle tecniche.
La geografia postmoderna e il nuovo paradigma geografico: lo sviluppo sosteni-
bile.
La breve rassegna delle tappe evolutive del pensiero geografico si conclude
con alcune riflessioni sul nuovo paradigma geografico: lo sviluppo sostenibile.
17
A. Vallega,
La regione, sistema territoriale sostenibile: compendio di geografia regionale sistematica
,
Mursia, 1995; A. Vallega,
Geografia umana
, Mursia, 1989.


















