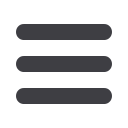

10
Scienze e tecnologie informatiche
a memorizzare gli elementi più importanti?”, “Tendo a distrarmi?”, “Come mai
non riesco a comprendere questo argomento? Forse ho tralasciato di studiare
qualcosa che mi avrebbe aiutato a capire” ecc. In generale, l’applicazione delle
tecniche metacognitive alla didattica ha riguardato soprattutto l’attenzione, la
memoria, la lettura e la scrittura. Le ricerche in questi ambiti hanno confer-
mato che le prestazioni degli studenti che hanno una buona consapevolezza
metacognitiva sono generalmente migliori poiché il compito viene affrontato
con maggior coinvolgimento personale.
La variabile emotivo-motivazionale appare, quindi, avere un ruolo fondamen-
tale, in quanto motore dello “stile di funzionamento” della persona. Tale va-
riabile si poggia direttamente sulla fiducia nelle proprie capacità di portare a
termine con successo un’attività, ossia sull’
autoefficacia
.
La percezione che si ha della propria autoefficacia (che si struttura in base
ai successi e agli insuccessi e alla causa che attribuiamo all’uno e all’altro) in-
fluenza il comportamento che si può avere di fronte ad un compito. Ad esem-
pio: in un qualsiasi evento, gli ostacoli o le difficoltà che possono presentarsi,
sono percepiti come stimolo per un maggior impegno nel superarli da chi ha
un alto grado di autoefficacia (cioè si sente competente), mentre sono perce-
piti veramente difficoltosi, spesso con la conseguenza di un abbandono del
compito o comunque di un successo, da chi ha un basso grado di autoefficacia.
La percezione che si ha della propria autoefficacia può cambiare nel tempo;
ciò avviene grazie ai rinforzi che si ricevono, alle persone che dimostrano di
credere nelle abilità dell’altro, ai precedenti successi: l’importante è attribuire
(e imparare ad attribuire) ai successi la propria competenza. Quindi, la meta-
cognizione e la motivazione si influenzano a vicenda influenzando a loro volta
i processi di apprendimento. È perciò importante nell’insegnamento di queste
tecniche il modo con cui l’insegnante (o un “operatore” in generale) trasmette
questi concetti.
Non bisogna solo essere dei “trasmettitori di sapere”, ma è vitale riuscire a trasmet-
tere il valore che riveste per se stesso e per gli altri.
I benefici derivanti da una collaborazione didattica tra gli
strumenti informatici
e
l’insegnante sono molteplici. In primo luogo, la tecnologia informatica (software
specifici per la didattica, computer, scanner, proiettori ecc.) esercita un forte
potere attrattivo sugli alunni grazie alla combinazione multimediale di testi, im-
magini e suoni. È opportuno considerare poi che i ragazzi percepiscono i com-
puter come strumenti usati dagli adulti e questo non può che stimolare la loro
curiosità e la voglia di utilizzarli. Attraverso la progettazione di percorsi formativi
ben strutturati e adattabili alle specifiche esigenze della classe si mette in moto
un processo di apprendimento non meccanico e passivo ma vissuto e partecipa-
to, grazie all’adozione di software didattici non ripetitivi e rigidi e dotati di inter-
faccia grafica accattivante. Gli insegnanti, attraverso l’uso di appositi programmi
che gestiscono i percorsi di apprendimento, possono inoltre
monitorare
più effi-
cacemente il percorso formativo degli alunni e valutare se apportare modifiche
e diversificarlo in base alle differenti capacità. Un uso corretto ed efficace della


















