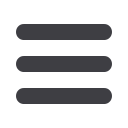

Premessa
Didattica oggi e didattica dell’informatica
7
di una mente aperta. Le ricerche in questi ambiti hanno confermato che le
prestazioni degli studenti che hanno una buona consapevolezza metacognitiva
sono tendenzialmente migliori poiché il compito viene affrontato con maggior
coinvolgimento personale
.
È
importante, quindi, che il docente sappia capire e dare risposte, esaudire le
richieste e trovare spiegazioni, prendere decisioni e contenere le ansie, riu
scendo a costituire un rapporto con lo studente che lo ponga come un vero e
proprio punto di riferimento.
Tutte le volte in cui l’insegnante è più preoccupato di promuovere capacità di
apprendere piuttosto che apprendimenti specifici, cioè tutte le volte che si oc-
cupa di far sì che un ragazzo apprenda per apprendere piuttosto che apprenda
il dato X o l’informazione Y, si trova in un’ottica metacognitiva.
Tutte le volte in cui l’insegnante sottolinea
allo studente l’esigenza di riflettere
sui propri pensieri, su come opera la sua mente e così via, anche se magari in
modo disorganizzato, sta sviluppando una proposta metacognitiva. D’altra par-
te l’insegnante è un
tecnico dell’apprendimento
, quindi dovrebbe essere capace di
riconoscere cosa sta avvenendo nella testa del ragazzo e come può facilitare sia
la capacità di apprendimento sia l’apprendimento stesso.
È necessario, quindi, rendere un ragazzo metacognitivo ma, contestualmente,
rendere anche l’insegnante più metacognitivo.
Un docente deve operare un’importante trasmissione: quella del sapere, azio-
ne tutt’altro che semplice. Per operare un adeguato trasferimento della cono-
scenza non occorrono solo la parola, il libro, una LIM o un computer. Tutti
questi mezzi devono essere affiancati da una profonda azione didattica caratte-
rizzata da professionalità, approccio carismatico, metodologia. Affinché queste
potenzialità intrinseche possano trovare un efficace riscontro sul terreno didat-
tico è necessario che l’operatore della “trasmissione del sapere”, riguardo al
suo interlocutore (ossia allo studente), faccia inizialmente una distinzione tra
metacognizione
come consapevolezza e riflessione sul proprio operare cognitivo
e
strategie cognitive
che si mettono in atto conseguentemente: un esempio della
prima è “rendersi conto che non si riesce a seguire un’istruzione che è data
oralmente”, mentre un esempio della seconda è “cercare di schematizzare per
iscritto in punti la sequenza delle istruzioni ascoltate”. Le due fasi devono es-
sere accuratamente omogeneizzate ed assemblate da un approccio strategico-
didattico valido ed efficace.
La metacognizione rappresenta, comunque, il punto di partenza sia per l’ope-
rato del docente sia per l’apprendimento da parte dello studente. Lo studente
che “usa” bene la metacognizione è quello che riesce a porsi tre domande fon-
damentali durante l’esecuzione di qualsiasi attività di problem solving:
>
>
cosa sto facendo?
>
>
per quale motivo sto facendo questa determinata cosa?
>
>
come posso fare perché tale processo sia massimamente efficace?
Per raggiungere tali risultati, bisogna che le persone siano informate sulla
struttura generale dei diversi tipi di memoria, bisogna conoscere i modi con


















