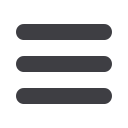

www.
edises
.it
Unità di Apprendimento 8
Revisione dell’immagine positivistica della scienza
279
Dal punto di vista scientifico hanno grande rilevanza alcune fonda-
mentali rivoluzioni concettuali.
A questo punto dell’unità sarebbe auspicabile l’intervento dei do-
centi di fisica, matematica e scienze, che potrebbero illustrare in
maniera sintetica ma puntuale almeno alcune di queste rivoluzio-
ni. Qui si danno delle indicazioni sommarie.
>
>
L’introduzione delle geometrie non euclidee, sistemi dotati di
perfetta coerenza e dimostrabilità interna, e che pure negano
il quinto postulato di Euclide, per il quale per un punto può
passare una sola parallela a una retta data, e mettono in dubbio
il carattere assoluto e oggettivo dello spazio euclideo.
>
>
Il rinnovamento dei fondamenti della matematica, il cui ambito
viene a scindersi in correnti e partiti antagonisti e alternativi (il
logicismo, che risolve la matematica nella logica, il formalismo,
che le attribuisce solo i caratteri formali di un sistema simboli-
co, l’intuizionismo, che ne fa procedere lo svolgimento da alcu-
ne specifiche intuizioni originarie).
>
>
L’ipotesi del “quanto” di luce: l’energia non si propagherebbe in
modo continuo, ma avrebbe struttura discreta.
>
>
Le teorie della relatività ristretta e generale: la massa di un cor-
po, la relazione temporale di due eventi e la loro distanza, ven-
gono a dipendere e variare a seconda dello stato di quiete o di
moto di corpi o eventi, stato a sua volta identificato a partire
dalle coordinate, anch’esse mobili, di un osservatore esterno.
>
>
I teoremi fisici di indeterminazione e di complementarietà.
Per il primo, non è mai possibile conoscere con precisione as-
soluta velocità e posizione di una particella, perché incrementi
di esattezza nella stima della prima coordinata si risolvono in
perdite nella stima della seconda: vi è, insomma, una soglia di
errore globale al di sotto della quale non si può scendere; se-
condo l’iniziale interpretazione dello scopritore del principio,
Werner Heisenberg, ciò sarebbe dovuto al fatto che l’osserva-
zione, ovvero il suo strumento, diventano parte dell’osservato
e lo alterano, in una misura che non è possibile precisare a
priori. Per il secondo teorema, un medesimo oggetto può rive-
lare una natura, ovvero essere sottoposto ad una descrizione
corpuscolare ma anche altrettanto bene ad una ondulatoria,
nature e descrizioni che di per sé si escluderebbero a vicenda.
















