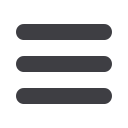
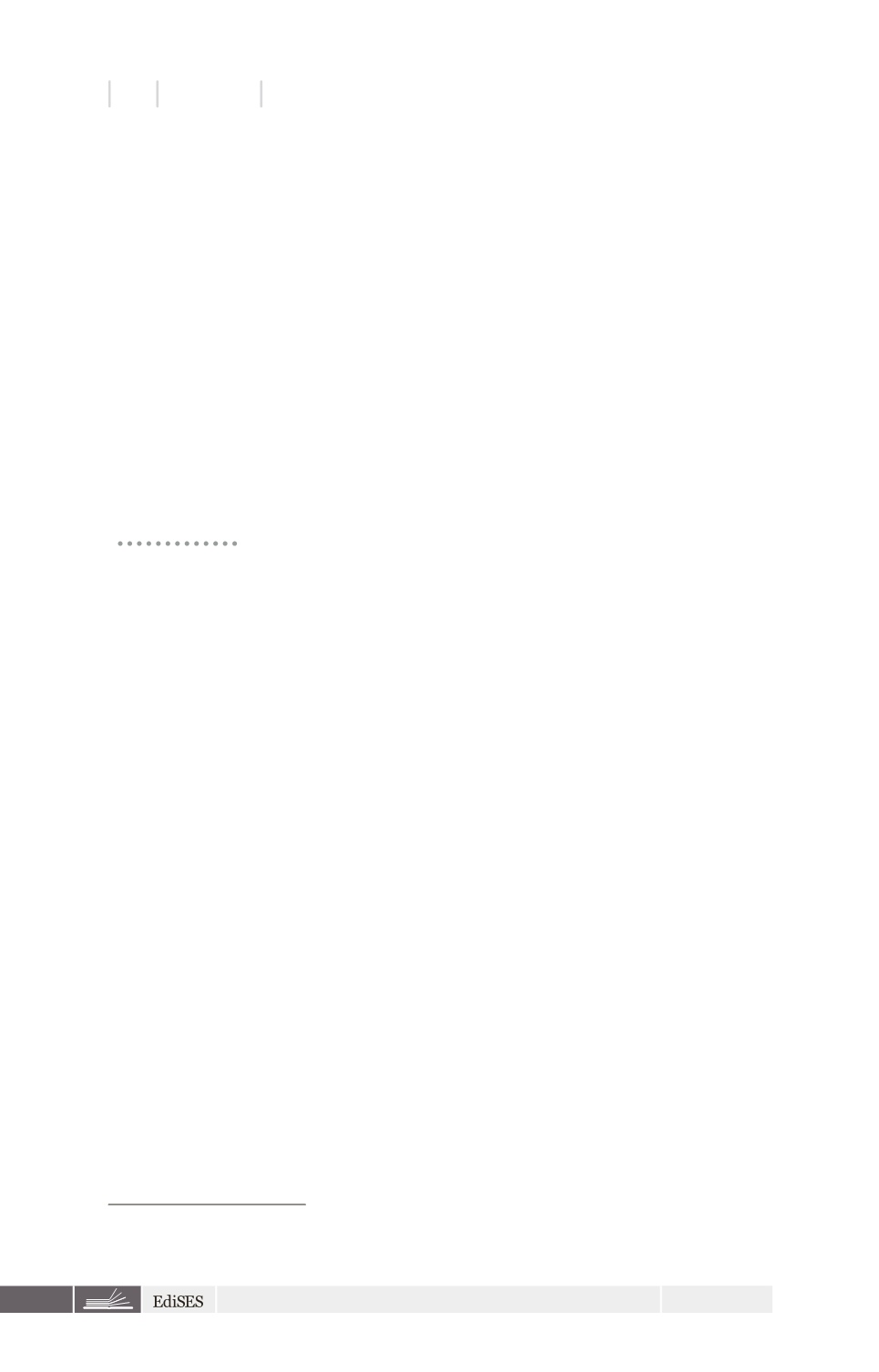
www.
edises
.it
282
Parte Terza
Esempi di Unità di Apprendimento
Per inciso, a questo punto anche una oggettiva distinzione fra
enunciati, o protocolli, d’esperienza ed enunciati teorici diventa
problematica.
Tutta l’attività di ricerca e di scoperta dello scienziato, l’identifica-
zione, la selezione, la descrizione dei fatti, la formulazione delle
ipotesi, la costruzione e la verifica delle teorie è orientata dai suoi
paradigmi: postulati, o presupposti, che gli provengono dalla sua
formazione culturale, dalla scuola scientifica cui ha aderito, dalla
comunità intellettuale cui fa riferimento, dall’ambiente di studio e
di lavoro in cui è immerso.
Il docente può introdurre ora il pensiero di Thomas Kuhn, parten-
do da qualche passo del suo testo più importante,
La struttura delle
rivoluzioni scientifiche
.
Documento 2
3
Alcuni esempi di prassi scientifica riconosciuti come validi – esempi che
comprendono globalmente leggi, teorie, applicazioni e strumenti – forni
scono modelli che danno origine a particolari tradizioni di ricerca scientifica
con una loro coerenza. Queste sono le tradizioni che lo storico descrive con
etichette quali “astronomia tolemaica” (o “copernicana”), “dinamica aristo
telica” (o “newtoniana”), “ottica corpuscolare” (o “ottica ondulatoria”). (…)
Per gli aristotelici, che credevano che un corpo pesante si muovesse per sua
natura da una posizione più elevata verso uno stato di quiete in una posi
zione più bassa, un corpo oscillante era semplicemente un corpo che cade
va con difficoltà. Vincolato dalla catena, esso poteva raggiungere lo stato
di quiete nel suo punto più basso soltanto dopo un movimento tortuoso e
un considerevole periodo di tempo. Galileo invece quando guardò un corpo
oscillante vide un pendolo, ossia un corpo che quasi riusciva a ripetere lo
stesso movimento più e più volte all’infinito. Dopo aver osservato atten
tamente il fenomeno, Galileo notò anche molte altre caratteristiche del
pendolo (...) notò ad esempio che il periodo del pendolo era indipendente
dall’ampiezza per ampiezze di 90° (...) egli vide tutti questi fenomeni natu
rali in maniera diversa da come erano stati visti prima. (...) Si può pensare
che la genialità di Galileo consiste nel modo in cui egli utilizzò le possibilità
percettive che gli venivano fornite da un paradigma tardomedievale, quel
lo dell’
impetus
... che sosteneva che il movimento continuo di un corpo pe
sante era dovuto ad una forza interna che vi era stata impressa dall’agente
che, lanciandolo, l’aveva messo in movimento. (...) Fino a che non fu creato
3
T. Kuhn,
La struttura delle rivoluzioni scientifiche
, Einaudi, Torino 1969,
pp. 30-31, 148-149.
















