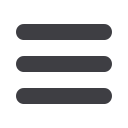
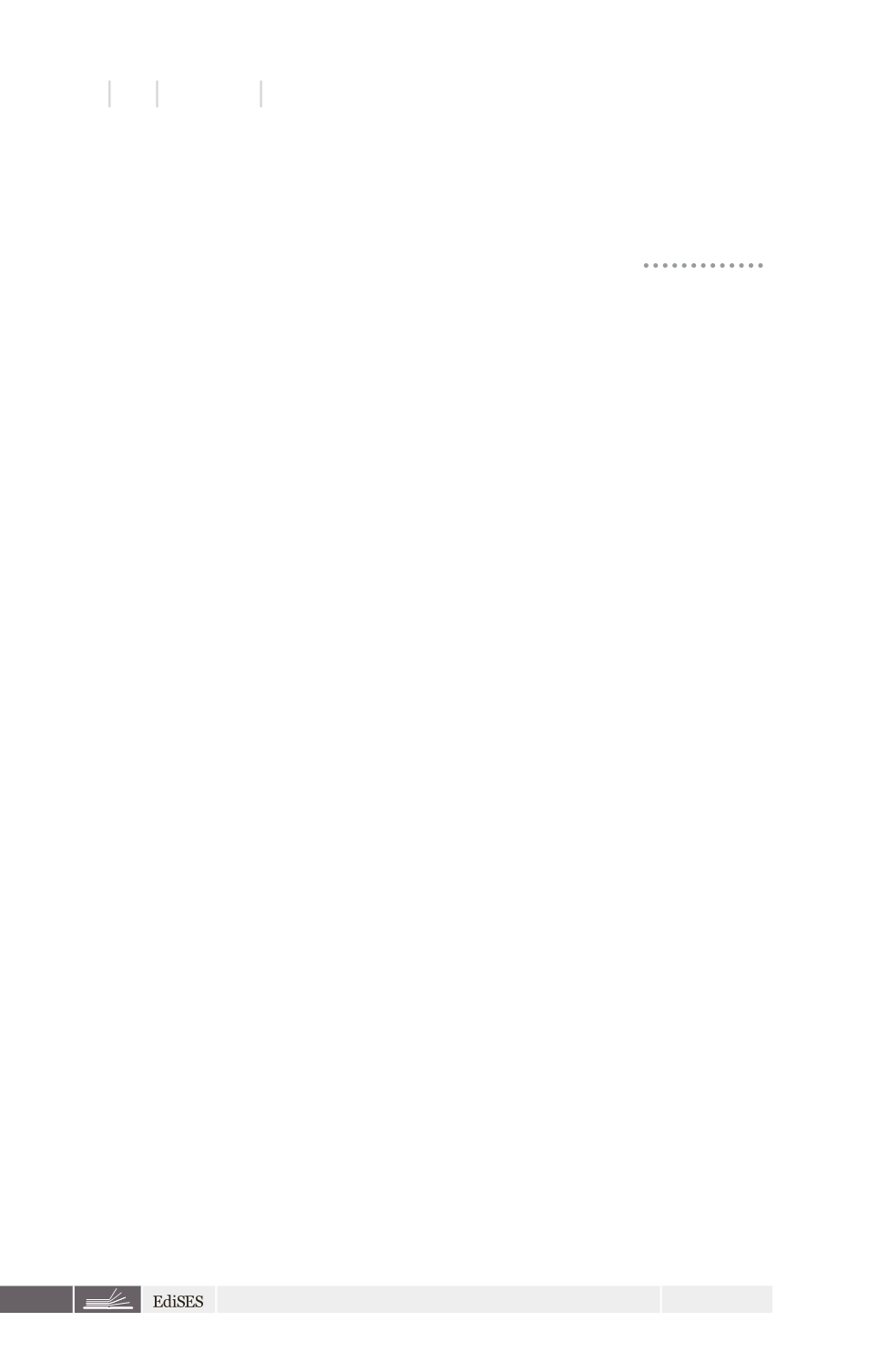
www.
edises
.it
284
Parte Terza
Esempi di Unità di Apprendimento
tivi di conficcare più a fondo le palafitte non significa che abbiamo trovato
un terreno solido. Semplicemente, ci fermiamo quando siamo soddisfatti e
riteniamo che almeno per il momento i sostegni siano abbastanza stabili da
sorreggere la struttura.
Per Kuhn parlare di progresso nel corso della storia della scienza è
ancora più difficile: per lui, se di progresso si può parlare, se ne può
parlare solo a proposito della scienza “normale”, quella che si rico-
nosce in un paradigma (ad esempio, l’evoluzionismo darwiniano)
e procede all’interno di esso, accumulando dati e risolvendo rom-
picapi (come l’accordo della teoria di Darwin con le leggi di Men-
del). Questa scienza conosce dunque i propri punti di partenza, vi
raffronta gli esiti successivi della ricerca e ne stabilisce la distanza e
perciò il progresso rispetto ai punti di partenza (non per questo si
attribuisce, o crede di vedere, una meta finale). È il paradigma co-
mune fra partenza ed esiti che consente di commensurarli e di defi-
nire e misurare il progresso. La scienza rivoluzionaria (ad esempio,
la fisica galileiana rispetto a quella aristotelica) invece fa terra bru-
ciata dietro di sé, cancella i vecchi paradigmi e ne produce di nuovi;
con ciò diventa incommensurabile rispetto alla vecchia scienza che
confuta. Proprio questa distinzione fra scienza normale e scienza ri-
voluzionaria viene presa di mira da Feyerabend, cancellando quella
pur debole
imago
di progresso che Kuhn ci aveva ancora prospet-
tato. Attraverso una puntigliosa disamina degli argomenti e delle
esemplificazioni di Kuhn, Feyerabend giunge a ritenere impossibi-
le il demarcare una scienza normale: tutte le teorie e tutti i periodi
possono in qualche modo essere ritenuti rivoluzionari rispetto ai
precedenti, tanta è la forza della componente storica e soggetti-
va che racchiudono in sé. E questo non solo nel momento della
formulazione originaria, cioè nel contesto della scoperta, ma an-
che nella fase della giustificazione, cioè della successiva convalida
e dell’inserimento in un quadro concettuale più generale. Mentre
per Popper è ancora pensabile che un’osservazione, o un opportu-
no corredo di osservazioni, siano in grado – per quanto i loro enun-
ciati linguistici risentano dei presupposti teorici – di confermare
o invalidare una teoria in un contesto perfettamente razionale e
controllabile, per Feyerabend nessun esperimento di per sé ne è
in grado. Per lui l’apparato linguistico di una teoria non risponde
a criteri di cartesiana razionalità, ma è intessuto di elementi fanta-
















