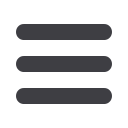
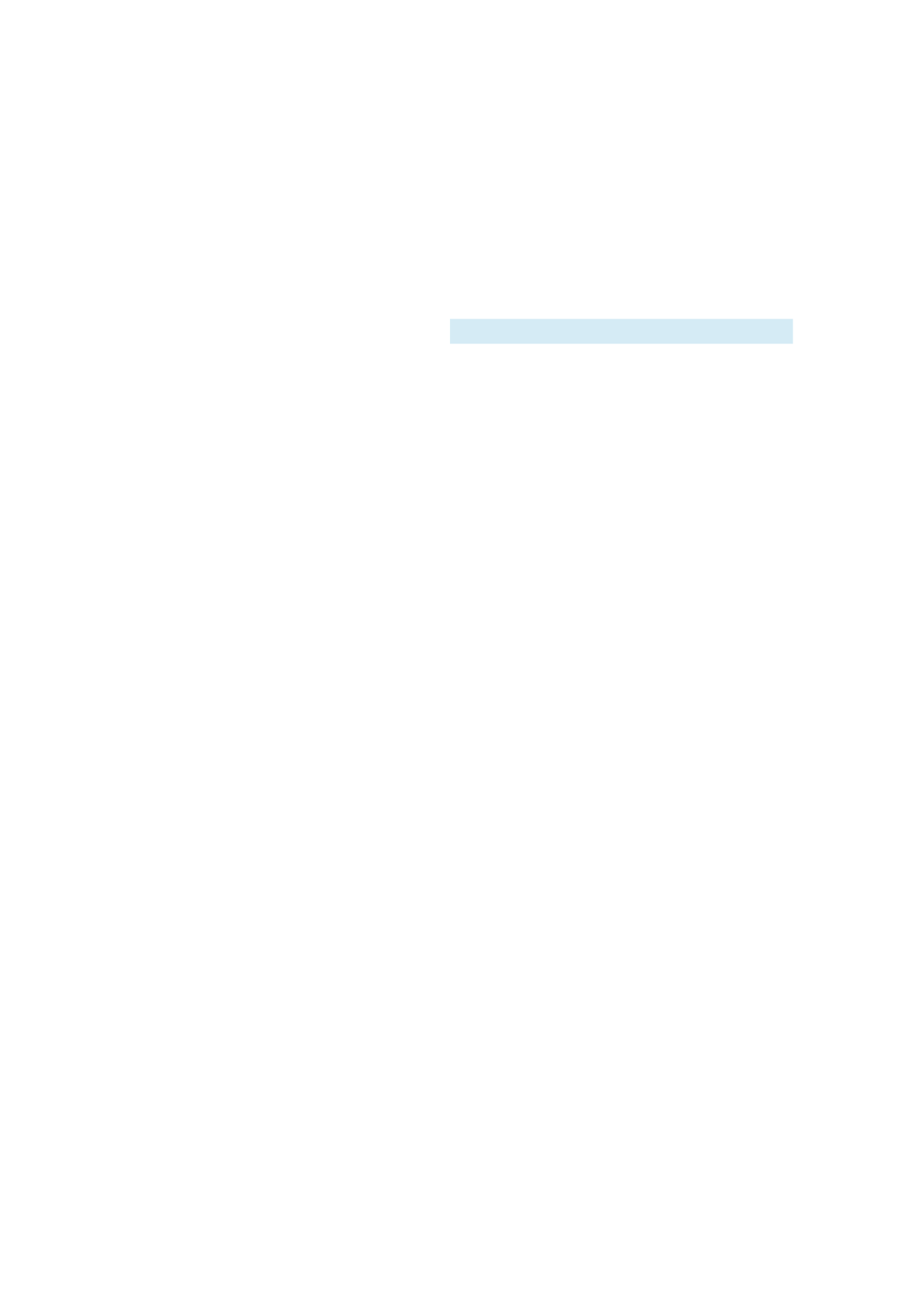
14.6.4 Profarmaci come mezzo per ridurre la
solubilità in acqua
262
14.6.5 Profarmaci come mezzo per migliorare la
solubilità in acqua
262
Riquadro 14.5 Profarmaci come mezzo per
migliorare la solubilità in acqua
263
14.6.6 Profarmaci usati per il direzionamento
dei farmaci
263
14.6.7 Profarmaci come mezzo per migliorare
la stabilità chimica
264
14.6.8 Profarmaci attivati da fattori esterni
(farmaci dormienti)
264
14.7
Associazioni di farmaci
264
14.7.1 Farmaci ‘sentinella’
265
14.7.2 Connamento dell’attività di un farmaco
in un’area specica
265
14.7.3 Potenziamento dell’assorbimento
265
14.8
Composti endogeni come farmaci
266
14.8.1 Neurotrasmettitori
266
14.8.2 Ormoni, peptidi e proteine naturali come
farmaci
266
14.8.3 Anticorpi come farmaci
268
14.9
Peptidi e peptidomimetici nella progettazione
dei farmaci
269
14.9.1 Peptidomimetici
269
14.9.2 Farmaci peptidici
271
14.10
Oligonucleotidi come farmaci
271
15 L’introduzione dei farmaci sul mercato
275
15.1
Saggi preclinici e clinici
275
15.1.1 Saggi di tossicità
275
15.1.2 Studi sul metabolismo dei farmaci
277
Riquadro 15.1 Studi sul metabolismo nella
progettazione dei farmaci
277
15.1.3 Saggi farmacologici, di formulazione e di
stabilità
278
15.1.4 Saggi clinici
279
15.2
La brevettazione e le norme regolatorie
282
15.2.1 I brevetti
282
15.2.2 Norme regolatorie
284
15.3
Lo sviluppo chimico e di processo
287
15.3.1 Lo sviluppo chimico
287
15.3.2 Lo sviluppo di processo
288
15.3.3 La scelta del farmaco candidato
per l’immissione sul mercato
288
15.3.4 I prodotti naturali
288
Riquadro 15.2 La sintesi dell’ebalzotano
289
Riquadro 15.3 Sintesi dell’ICI D7114
289
Q
Esempio applicativo 2: La progettazione
di ACE-inibitori
293
Q
Esempio applicativo 3: Artemisinina e farmaci
antimalarici correlati
301
Q
Esempio applicativo 4: La progettazione della
oxamnichina
307
PARTE D Metodi nella chimica farmaceutica
16 Sintesi combinatoriale e sintesi in parallelo 317
16.1
La sintesi combinatoriale e la sintesi in parallelo
nella chimica farmaceutica
317
16.2
Tecniche di sintesi in fase solida
317
16.2.1 Il supporto solido
318
16.2.2 Il gruppo di ancoraggio (‘linker’)
319
16.2.3 Esempi di sintesi in fase solida
321
16.3
Piani!cazione e progettazione di una libreria
di composti
322
16.3.1 ‘Nuclei centrali’ (‘scaold’) a forma di ragno 322
16.3.2 Progettazione di molecole farmaco-simili
(‘drug-like’)
322
16.3.3 Sintesi dei ‘nuclei centrali’ (‘scaold’)
323
16.3.4 Variazione dei sostituenti
323
16.3.5 Progettazione di librerie di composti
per l’ottimizzazione del composto guida
323
16.3.6 Librerie progettate al computer
323
16.4
Valutazione dell’attività
323
16.4.1 Screening ad alta ecienza
323
Riquadro 16.1 Esempi di ‘nuclei centrali’
(‘scaold’)
324
16.4.2 Saggio ‘su pallina’ o ‘fuori dalla pallina’
di resina
325
16.5
Sintesi in parallelo
326
16.5.1 Estrazione in fase solida
326
16.5.2 Uso di resine nella sintesi organica in
soluzione (‘solution phase organic synthesis’
,
SPOS)
328
16.5.3 Reagenti su supporto solido: l’approccio
‘cattura e rilascia’ (‘catch and release’)
328
16.5.4 Tecnologia basata sull’impiego di microonde 330
16.5.5 Microuidi nella sintesi in parallelo
330
16.6 Sintesi combinatoriale
332
16.6.1 Metodo ‘combina e suddividi’ (‘mix and split’)
nella sintesi combinatoriale
332
16.6.2 Determinazione della struttura dei composti
attivi
333
16.6.3 Sintesi combinatoriale dinamica
335
Riquadro 16.2 Sintesi combinatoriale dinamica
di dimeri della vancomicina
338
XVI
Indice generale
















