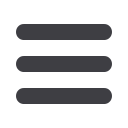

Indice generale
XV
13.1.12 Ruolo di altri gruppi funzionali
nell’interazione con il bersaglio
223
13.1.13 Ruolo dei gruppi alchilici e dello
scheletro carbonioso nell’interazione
con il bersaglio
223
13.1.14 Ruolo degli eterocicli nell’interazione
con il bersaglio
224
13.1.15 Isosteri
225
13.1.16 Saggi biologici
226
13.1.17 SAR nell’ottimizzazione dei farmaci
226
13.2
Identi!cazione di un farmacoforo
227
13.3
Ottimizzazione dei farmaci: strategie adottate
nella
progettazione
228
13.3.1 Variazione dei sostituenti
228
13.3.2 Estensione della struttura
231
13.3.3 Allungamento/accorciamento di catene
231
13.3.4 Espansione/contrazione di cicli
231
Riquadro 13.1 Convertire un substrato enzimatico
in un inibitore attraverso l’estensione
della struttura
232
13.3.5 Variazione della natura dei cicli
233
13.3.6 Fusione di cicli
234
13.3.7 Isosteri e bioisosteri
234
13.3.8 Semplicazioni strutturali
236
Riquadro 13.2 Semplicazione
237
13.3.9 Irrigidimento della struttura
239
Riquadro 13.3 Tattiche di irrigidimento nella
progettazione dei farmaci
240
13.3.10 Gruppi in grado di operare un blocco
conformazionale
241
13.3.11 Progettazione dei farmaci basata sulla
struttura del sito d’interazione e modellistica
molecolare
241
Riquadro 13.4 Progettazione basata sulla struttura
del farmaco crizotinib
242
13.3.12 Progettazione dei farmaci mediante
spettroscopia NMR
243
13.3.13 Il contributo di fortuna e intuito
243
13.3.14 Progettare farmaci che interagiscono con più
di un bersaglio
243
14 Progettazione dei farmaci: ottimizzazione
dell’accesso al bersaglio
248
14.1
Ottimizzazione delle proprietà
idro!liche/idrofobiche
248
14.1.1 Mascherare gruppi funzionali polari per
diminuire la polarità
249
14.1.2 Aggiungere o rimuovere gruppi funzionali
polari per modicare la polarità
249
14.1.3 Variare sostituenti idrofobici per modicare
la polarità
250
14.1.4 Variazione dei sostituenti
N
-alchilici per
modicare il p
K
a
250
14.1.5 Variazione dei sostituenti aromatici per
modicare il p
K
a
250
14.1.6 Bioisosteri dei gruppi polari
250
Riquadro 14.1 Uso dei bioisosteri per favorire
l’assorbimento
251
14.2
Rendere i farmaci più resistenti alla degradazione
chimica ed enzimatica
251
14.2.1 Scudi sterici
251
14.2.2 Eetti elettronici dei bioisosteri
252
14.2.3 Modicazioni stereoelettroniche
252
14.2.4 Sostituenti che bloccano il metabolismo:
‘metabolic blockers’
252
14.2.5 Rimozione o sostituzione di gruppi sensibili
al metabolismo
253
14.2.6 Spostamento di gruppi
253
14.2.7 Variazione di anelli e di sostituenti sugli
anelli
254
14.3
Rendere i farmaci meno resistenti
al metabolismo
255
14.3.1 Introduzione di gruppi suscettibili
al metabolismo
255
Riquadro 14.2 Riduzione del tempo di vita
di un farmaco
256
14.3.2 Farmaci che si autodistruggono
256
14.4
Direzionamento dei farmaci
256
14.4.1 Direzionamento verso le cellule tumorali:
farmaci ‘cerca e distruggi’
257
14.4.2 Direzionamento verso le infezioni
gastroenteriche
257
14.4.3 Direzionamento verso regioni periferiche
rispetto al sistema nervoso centrale
257
14.4.4 Direzionamento attraverso ancoraggi di
membrana
257
14.5
Riduzione della tossicità
258
14.6
Profarmaci
259
14.6.1 Profarmaci come mezzo per migliorare la
permeabilità di membrana
259
Riquadro 14.3 Variazione dei gruppi esterei nei
profarmaci
260
14.6.2 Profarmaci come mezzo per prolungare
la durata d’azione
260
14.6.3 Profarmaci come mezzo per mascherare
la tossicità e gli eetti collaterali dei farmaci
261
Riquadro 14.4 Profarmaci come mezzo per mascherare
tossicità ed eetti collaterali
262
















