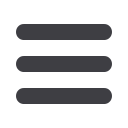

XII
Indice generale
6.1.5 Polimorsmo genetico e medicina
personalizzata
76
6.2
Acido ribonucleico e sintesi proteica
76
6.2.1 Struttura dell’RNA
76
6.2.2 Trascrizione e traduzione
77
6.2.3 Piccoli RNA nucleari
79
6.3
Malattie genetiche
79
6.4
Biologia molecolare e ingegneria genetica
81
PARTE B Farmacodinamica
e farmacocinetica
7 Enzimi come bersagli di farmaci
87
7.1
Inibitori che agiscono a livello del sito attivo
di un enzima
87
7.1.1 Inibitori reversibili
87
Riquadro 7.1 Una cura per l’avvelenamento
da antigelo
88
7.1.2 Inibitori irreversibili
89
7.2
Inibitori che agiscono a livello di siti di legame
allosterici
89
Riquadro 7.2 Inibizione irreversibile per il
trattamento dell’obesità
90
7.3
Inibitori incompetitivi e non competitivi
90
7.4
Analoghi dello stato di transizione: inibitori
della renina
90
7.5
Substrati suicidi
92
7.6
Inibitori isozima-selettivi
93
7.7
Usi terapeutici degli inibitori enzimatici
93
7.7.1 Inibitori enzimatici usati contro
microrganismi
93
Riquadro 7.3 Substrati suicidi
94
7.7.2 Inibitori enzimatici usati contro virus
95
7.7.3 Inibitori usati contro enzimi propri
del nostro organismo
95
Riquadro 7.4 Progettare farmaci selettivi per
isozimi
95
Riquadro 7.5 Azione di tossine su enzimi
96
7.8
Cinetica enzimatica
97
7.8.1 Graci di Lineweaver-Burk
97
7.8.2 Confronto di inibitori
99
8 Recettori come bersagli di farmaci
102
8.1
Introduzione
102
8.2
La progettazione di agonisti
102
8.2.1 I gruppi di legame
102
8.2.2 Posizione dei gruppi di legame
104
8.2.3 Dimensione e forma
105
8.2.4 Altre strategie di progettazione
105
4.7.4 Dimerizzazione di recettori accoppiati a
proteine G
53
4.8
Recettori associati a chinasi
53
4.8.1 Principi generali
53
4.8.2 Struttura dei recettori tirosina chinasici
54
4.8.3 Meccanismo di attivazione dei recettori
tirosina chinasici
54
4.8.4 Recettori associati a tirosina chinasi
54
4.9
Recettori intracellulari
55
4.10
Regolazione dell’attività recettoriale
56
4.11
Polimor!smo genetico e recettori
56
5 Recettori e trasduzione del segnale
58
5.1
Vie di trasduzione del segnale per recettori
accoppiati a proteine G
58
5.1.1 Interazione del complesso ligando-recettore
con proteine G
58
5.1.2 Vie di trasduzione del segnale
che coinvolgono la subunità α
59
5.2
Trasduzione del segnale che coinvolge proteine
G e adenilato ciclasi
60
5.2.1 Attivazione dell’adenilato ciclasi da parte
della subunità α
S
60
5.2.2 Attivazione della proteina chinasi A
60
5.2.3 Proteine G
i
62
5.2.4 Aspetti generali della cascata di segnalazione
che coinvolge l’AMP ciclico
62
5.2.5 Ruolo del dimero βγ
63
5.2.6 Fosforilazione
63
5.3
Trasduzione del segnale che coinvolge proteine G
e fosfolipasi C
64
5.3.1 Eetto della proteina G sulla fosfolipasi C
64
5.3.2 Azione del secondo messaggero diacilglicerolo 65
5.3.3 Azione del secondo messaggero inositolo
trisfosfato
65
5.3.4 Resintesi di fosfatidilinositolo bisfosfato
65
5.4
Trasduzione del segnale che coinvolge recettori
associati a chinasi
66
5.4.1 Attivazione di proteine di segnalazione
ed enzimi
66
5.4.2 Piccole proteine G
67
5.4.3 Attivazione della guanilato ciclasi da parte
di recettori chinasici
68
6 Acidi nucleici: struttura e funzione
71
6.1
Struttura del DNA
71
6.1.1 Struttura primaria del DNA
71
6.1.2 Struttura secondaria del DNA
71
6.1.3 Struttura terziaria del DNA
74
6.1.4 Cromatine
76
















