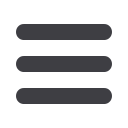
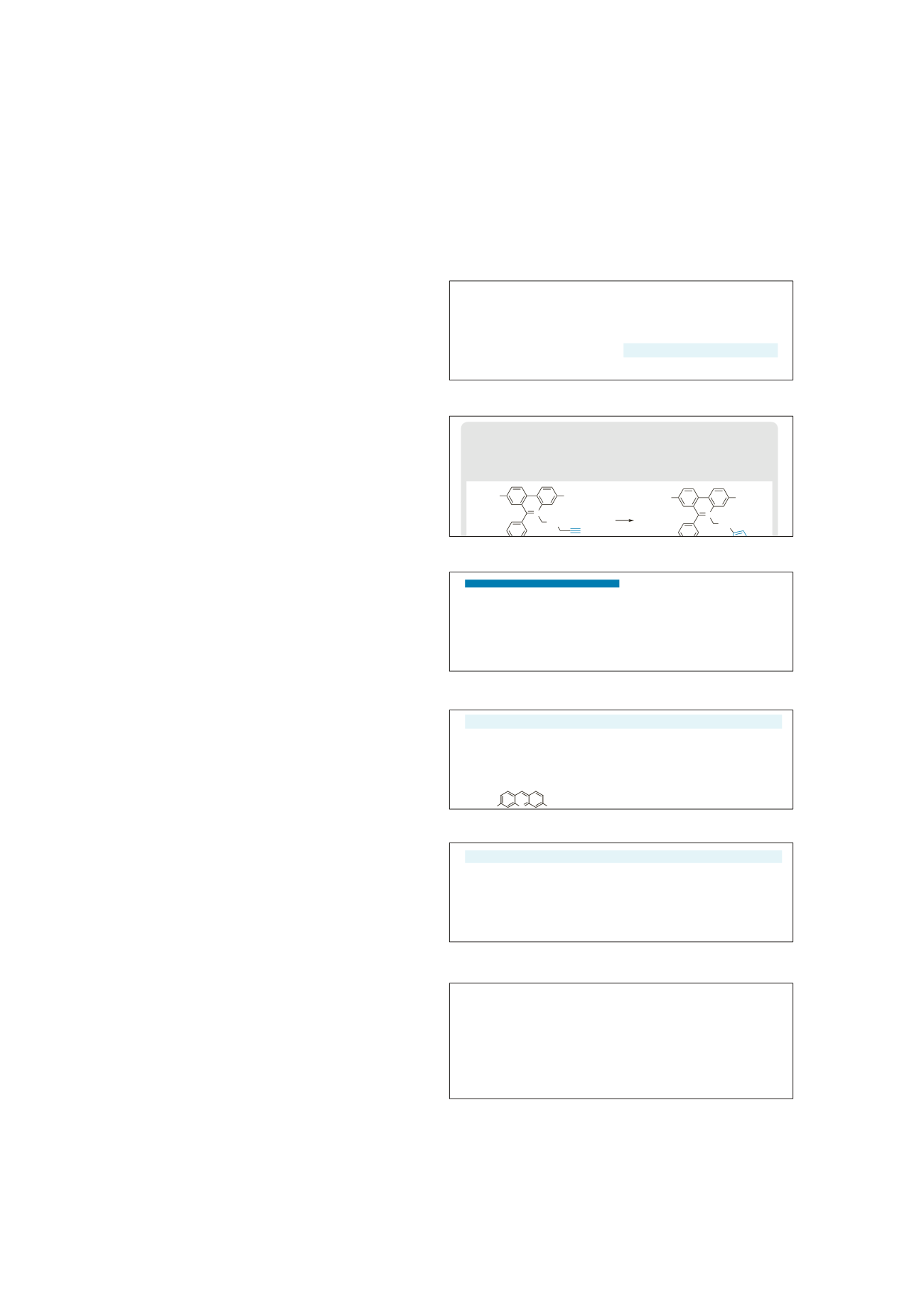
La nuova edizione di
Chimica Farmaceutica
o%re allo studente molti strumenti didattici. Questa sezione ne illustra
i contenuti e spiega come possono essere convenientemente utilizzati per comprendere meglio questa a%ascinante
disciplina.
I docenti che utilizzano il testo a scopo didattico possono scaricare dal sito
www.edises.it, previa registrazione all’area
docenti, le immagini del libro in formato PowerPoint.
Parole chiave in grassetto
La terminologia specica è stampata in grassetto e de-
nita in un Glossario, in fondo al libro. Il Glossario aiuterà
ad acquisire familiarità con il linguaggio della chimica
farmaceutica.
Riquadri
I Riquadri sono usati per presentare in dettaglio alcuni
argomenti selezionati, e per mostrare come concetti di
chimica farmaceutica siano applicati nella pratica.
Concetti chiave
Alla ne dei paragra principali, dei rapidi sommari sot-
tolineano i concetti più importanti e forniscono un utile
strumento di ripasso.
Domande
Alla ne di ogni capitolo, una serie di domande aiuterà
a valutare il grado di comprensione e di apprendimento
dei concetti presentati nel capitolo.
Letture consigliate
Una lista di letture consigliate aiuterà ad approfondire
argomenti di particolare interesse.
Appendici
Alla ne del testo sono presenti varie Appendici ed un
ricco Glossario per una rapida consultazione.
Guida per gli studenti
Supporti per i docenti
mente alla macromolecola, con una forza di legame circa
200-400 kJ mol
-1
. La gran parte di essi, però, interagisce
attraverso legami non covalenti, più deboli. Queste for-
me di interazioni sono solitamente descritte come lega-
mi
intermolecolari
e comprendono legami elettrostatici
(o ionici), legami ad idrogeno, interazioni dipolo-dipolo
e interazioni idrofobiche. (Occorre osservare che lo stes-
so tipo di interazioni possono stabilirsi all’interno della
stessamolecola,ed inquestocasosonode$nite
interazio-
ni intramolecolari
; vedi ad esempio la loro importanza
nella struttura delle proteine, paragra$ 2.2 e 2.3). Nessu-
no di questi legami è forte quanto un legame covalente,
di legame
.Lo studiodi come i farmaci interagiscono con
i loro bersagli macromolecolari attraverso le interazioni
di legame viene de$nito
farmacodinamica
. Consideria-
mo ora un po’ più in dettaglio i vari tipi di interazioni
intermolecolari.
1.3
Forze di legame intermolecolari
Esistono diversi tipo di interazioni di legame intermole-
colari che si di+erenziano per la forza di legame. Il nu-
mero ed il tipo di legami che si instaurano in una certa
RIQUADRO 12.8
La “click chemistry”
in situ
Dall’assemblaggiodi frammentiall’internodel sitoattivodell’en-
zima acetilcolinesterasi è stato ottenuto un inibitore femtomo-
lare dell’enzima stesso. Uno dei due frammenti contiene un
gruppo azidico, mentre l’altro un gruppo acetilenico terminale.
In presenza dell’enzima, entrambi i frammenti si legano al sito
attivo inposizioneopportunaperdar luogoadunacicloaddizione
1,3dipolare irreversibile, formando in talmodo
insitu
l’inibitore.
Tale reazioneè stata indicatacome“clickchemistry
in situ
”.
H
2
N
N
NH
2
(CH
2
)
4
alchino
N
H
2
N
N
NH
2
(CH
2
)
5
cicloaddizione
CONCETTI CHIAVE
•
Le strategie volte aldirezionamentodei farmaci versodetermi-
nati tessuti o celluleportano, conbuonaprobabilità, a farmaci
più sicuri perché caratterizzati da minori effetti collaterali.
•
I farmaci possono essere legati ad amminoacidi o alle basi
degli acidi nucleici per essere direzionati verso le cellule in
stato di rapida riproduzione e crescita.
•
L’azione dei farmaci può essere confinata al tratto gastroin-
testinale progettandone varianti completamente ionizzate o
altamente polari; in questa forma non riescono ad attraver-
sare la parete intestinale.
dellaprogettazionedeiprofarmaci,è importanteassicurarsi
che essi siano e&cacemente convertiti nelle corrispondenti
forme attive dopo l’assorbimento nel torrente circolatorio
ed è anche importante assicurarsi che tutti i prodotti deri-
vantidall’attivazionenon siano tossici.
14.6.1
I profarmaci come mezzo per
migliorare la permeabilità di membrana
14.6.1.1
Esteri come profarmaci
I profarmaci si sono dimostrati utilissimi per mascherare
1.
La proflavina è un agente antibatterico topico che si
intercala nel DNA batterico e fu usata per trattare soldati
feriti in Estremo Oriente durante la Seconda Guerra
Mondiale. Quale è il ruolo (se ce n’è uno) dell’anello
triciclico e dei gruppi amminici primari? Il farmaco non
può essere usato per via sistemica. Suggerisci perché.
N
H
2
N
NH
2
Proflavina
nell’evoluzione della vita, quando l’atmosfera della Terra
consisteva di gas quali acido cianidrico e metano. È anche
stato possibile sintetizzare l’adenina dall’acido cianidrico.
Considera la struttura dell’adenina e identifica in che modo
molecole di acido cianidrico possono fungere da blocchi
costitutivi di questa molecola
4.
Il codice genetico implica che tre basi codifichino per un
singolo amminoacido (il codice a triplette). Perciò, una
mutazione in una particolare tripletta dovrebbe dare come
DOMANDE
LETTURE CONSIGLIATE
Berg, C., Neumeyer, K., and Kirkpatrick, P. (2003)
Teriparatide.
Nature Reviews Drug Discovery,
2
, 257–258.
Burke, M. (2002) Pharmas market.
Chemistry in Britain
, June,
30–32 (antibodies).
Duncan, R. (2003) The dawning era of polymer therapeutics.
Nature Reviews Drug Discovery,
2
, 347–360.
Ezzell, C. (2001) Magic bullets fly again.
Scientific American
,
October, 28–35 (antibodies).
Ganellin, C. R., and Roberts, S. M. (eds.) (1994) Fluconazole,
Matthews, T.,
et al.
(2004) Enfuvirtide: the first therapy to
inhibit the entry of HIV-1 into host CD4 lymphocytes.
Nature
Reviews Drug Discovery,
3
, 215–225.
Moreland, L., Bate, G., and Kirkpatrick, P. (2006) Abatacept
Nature Reviews Drug Discovery
,
5
, 185–186.
Opalinska, J. B., and Gewirtz, A. M. (2002) Nucleic-acid
therapeutics: basic principles and recent applications.
Nature Reviews Drug Discovery,
1
, 503–514.
Pardridge, W. M. (2002) Drug and gene targeting to the
Per illustrare come alcuni parametri statistici quali
r
,
s
e
F
sono derivati ed impiegati, faremo uso del seguente esempio
numerico. Lo studio comprende 6 composti (
n
= 6). Y
exp
è il
logaritmodell’attivitàbiologicaosservataper ciascun compo-
sto eX èunparametro chimico-#sico.
èY
exp
-Y
calc
(Fig.A3.1).Questadi%erenza è elevata alquadrato
per ciascun composto e i valori così ottenuti sono sommati a
dare la “sommadeiquadrati” (sumof squares,SS
calc
)
SS
mean
èunamisuradiquanto l’attività sperimentaledi%eri-
sce dalla media di tutte le attività sperimentali, e rappresenta
Appendice 3
Trattamenti statistici impiegati nelle QSAR
















