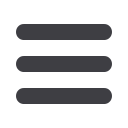

11.8
Dosaggio dei farmaci
171
11.8.1 Emivita di un farmaco
172
11.8.2 Concentrazione allo stato stazionario
172
11.8.3 Tolleranza al farmaco
173
11.8.4 Biodisponibilità
173
11.9
Formulazione
173
11.10
Veicolazione dei farmaci
174
Q
Esempio applicativo 1: Le statine
178
PARTE C Scoperta, progettazione
e sviluppo dei farmaci
12 Scoperta dei farmaci: identi!cazione
di un prototipo
189
12.1
La scelta della malattia
189
12.2
La scelta del bersaglio
189
12.2.1 I bersagli dei farmaci
189
12.2.2 La scoperta dei bersagli dei farmaci
189
Riquadro 12.1 Bersagli scoperti negli ultimi anni:
le caspasi
190
12.2.3 Specicità verso il bersaglio e selettività
tra le specie
191
12.2.4 Specicità verso il bersaglio e selettività
nell’organismo umano
191
12.2.5 Selettività dei farmaci nei confronti di organi
e tessuti specici
192
12.2.6 Le insidie
192
Riquadro 12.2 Le insidie connesse con la scelta
di determinati bersagli
192
12.2.7 Farmaci multibersaglio
193
Riquadro 12.3 Indagini iniziali per valutare
la potenziale tossicità
193
12.3
L’identi!cazione del saggio biologico
195
12.3.1 La scelta del saggio biologico
195
12.3.2 Saggi
in vitro
195
12.3.3 Saggi
in vivo
195
12.3.4 Validità dei saggi
196
12.3.5 Screening ad alta produttività
196
12.3.6 Screening basato sulla risonanza magnetica
nucleare (NMR)
197
12.3.7 Screening di anità
197
12.3.8 Risonanza plasmonica di supercie
197
12.3.9 Test di scintillazione per prossimità
198
12.3.10 Calorimetria isotermica di titolazione
198
12.3.11 Screening virtuale
199
12.4
L’identi!cazione di un prototipo
199
12.4.1 Screening di sostanze di origine naturale
199
12.4.2 Medicina popolare
202
12.4.3 Screening di ‘librerie’ di prodotti di sintesi
202
12.4.4 Farmaci già esistenti
203
12.4.5 Progettazione di farmaci a partire da ligandi
o modulatori naturali
204
Riquadro 12.4 Ottimizzazione selettiva degli eetti
collaterali (SOSA)
205
Riquadro 12.5 Prototipi da ligandi naturali
206
12.4.6 Sintesi combinatoriale e sintesi in
parallelo
207
12.4.7 Progettazione di prototipi assistita dal
computer
207
12.4.8 La serendipità e la mente preparata
207
Riquadro 12.6 Esempi di casi fortuiti
(serendipità)
207
12.4.9 Ricerca assistita da computer in banche
dati strutturali
209
12.4.10 La scoperta di prototipi attraverso l’uso di
frammenti molecolari
209
Riquadro 12.7 L’uso della spettroscopia NMR
per la ricerca di prototipi
209
Riquadro 12.8 La ‘click chemistry’
in situ
211
12.4.11 Proprietà dei prototipi
211
12.5
Isolamento e puri!cazione
212
12.6
Determinazione della struttura
212
12.7
Medicamenti erboristici
212
13 Progettazione dei farmaci:
ottimizzazione delle interazioni
con il bersaglio
215
13.1
Relazioni struttura-attività
215
13.1.1 Ruolo dei gruppi alcolici e fenolici
nell’interazione con il bersaglio
216
13.1.2 Ruolo degli anelli aromatici nell’interazione
con il bersaglio
217
13.1.3 Ruolo degli alcheni nell’interazione
con il bersaglio
218
13.1.4 Ruolo dei chetoni e delle aldeidi
nell’interazione con il bersaglio
218
13.1.5 Ruolo delle ammine nell’interazione
con il bersaglio
218
13.1.6 Ruolo delle ammidi nell’interazione
con il bersaglio
219
13.1.7 Ruolo dei sali di ammonio quaternari
nell’interazione con il bersaglio
221
13.1.8 Ruolo degli acidi carbossilici nell’interazione
con il bersaglio
221
13.1.9 Ruolo degli esteri nell’interazione
con il bersaglio
222
13.1.10 Ruolo degli alogenuri alchilici e arilici
nell’interazione con il bersaglio
222
13.1.11 Ruolo dei tioli e degli eteri nell’interazione
con il bersaglio
223
XIV
Indice generale
















