
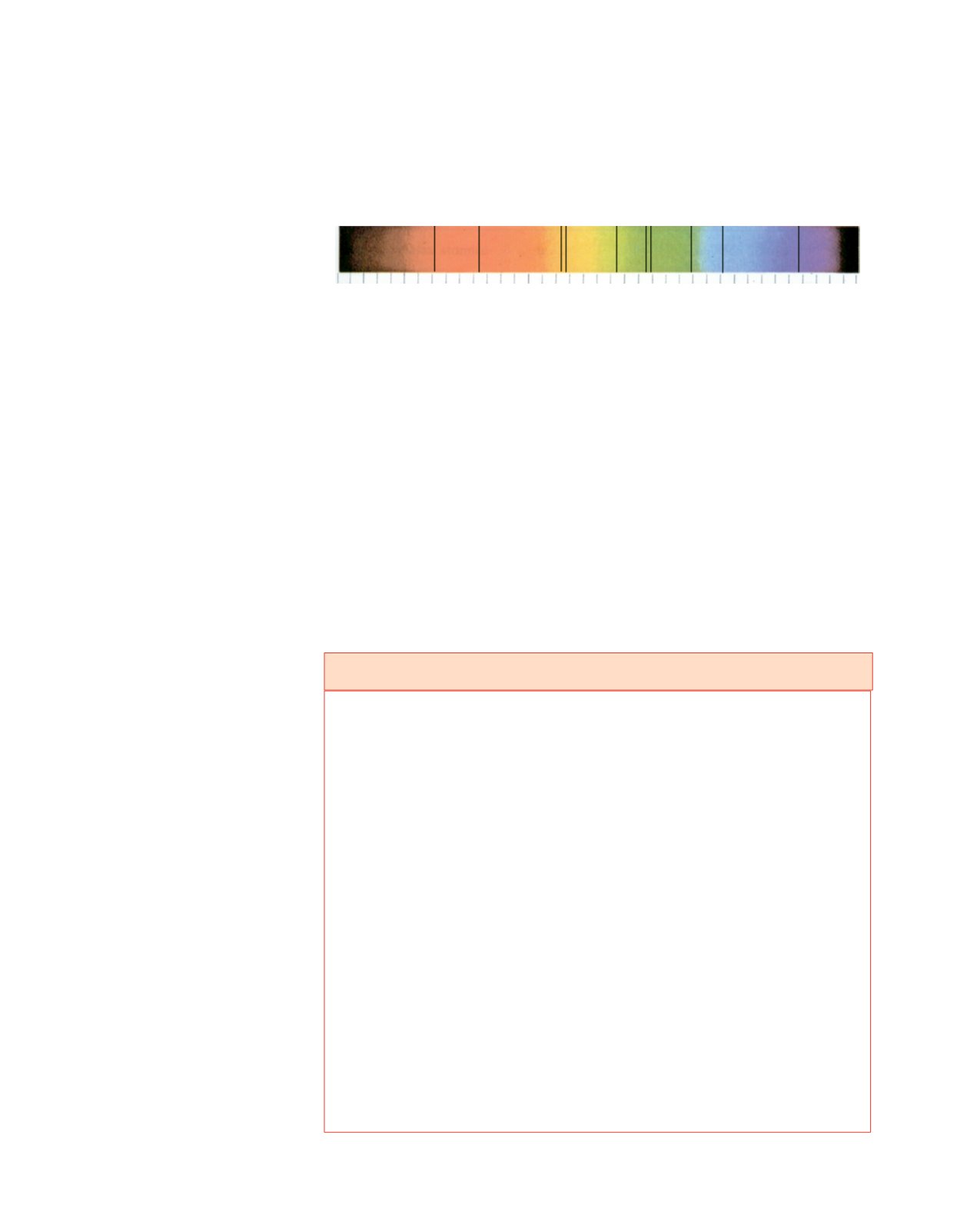
650
Diffrazione
Anche l’assorbimento è dovuto agli atomi e allemolecole della sostanza interposta
e di nuovo gli spettri sono rispettivamente a righe e a bande. Nella figura 16.31 si osser-
va una corrispondenza tra righe di assorbimento e righe di emissione e a questo propo-
sito vale la
regola di Kirchhoff
, giustificata nel capitolo 18, secondo cui ogni sostanza
è in grado di assorbire le radiazioni che, nelle stesse condizioni, è capace di emettere.
La figura 16.32 mostra lo spettro solare: in esso si osservano un gran numero di
righe nere (
righe di Fraunhofer
) che rappresentano lo spettro di assorbimento
dell’insieme degli elementi presenti sulla superficie solare (
cromosfera
) su un
fondo continuo che corrisponde all’emissione di un corpo alla temperatura
T
6000 K. Anche gli spettri di assorbimento possono quindi essere utilizzati per il
riconoscimento degli elementi.
La radiazione assorbita dagli atomi della sostanza interposta viene da questi dif-
fusa in tutte le direzioni, indipendentemente dalla direzione di propagazione della
luce incidente (possiamo riferirci al meccanismo descritto nel paragrafo 13.6). Lo si
verifica facilmente analizzando ad esempio la luce diffusa dai vapori di sodio prima
citati, nella quale si ritrovano principalmente le due lunghezze d’onda corrispon-
denti alle righe di assorbimento.
Regola di Kirchhoff
H
a
D
1
D
2
H
b
750
700 650
600 550
500 450
400 nm
Figura 16.32
Tra le righe di Fraunhofer sono indicate in particolare due righe dell’idro-
geno e due del sodio.
Nota. Larghezza delle righe spettrali
Abbiamo già detto nel paragrafo 12.10 che l’emissione luminosa da parte di un atomo
può essere rappresentata con un pacchetto d’onde di durata
D
t
10
–8
s nel quale sono
necessariamente presenti molte lunghezze d’onda in un intervallo
Dl
centrato intorno al
valor medio
l
, con
Dl
/
l
10
–7
. L’argomento classico è confermato dalla trattazione
quantistica, che porta ai valori suddetti.
Ad un certo intervallo
Dl
è associata, in base a (16.11), una variazione
Dq
l
dell’angolo
q
l
al quale si osserva il massimo di ordine
m
e in prima approssimazione, se gli angoli
sono piccoli, possiamo porre
m
Dq
l
–––
Dl
.
d
Confrontiamo questa
larghezza
Dq
l
, che è
intrinseca della riga
e si può chiamare
lar-
ghezza naturale
della riga, con la
larghezza strumentale
(16.12) introdotta dal reticolo:
Dq
l
m Nd
1
Dl
–––– = –––
Dl
–––– =
m N
––– –––– =
m N
0.5 · 10
–7
.
Dq
d
2
l
2
l
In un reticolo con
N
= 10
4
e all’ordine
m
= 2
Dq
l
/
Dq
= 10
–3
: la larghezza naturale è
trascurabile rispetto alla larghezza strumentale, ovvero la larghezza osservata è esclusi-
vamente quella strumentale.
Osserviamo anche che il suddetto reticolo ha il potere risolutivo
R
=
m N
= 2 · 10
4
e che
quindi
Dl
/
l
= 1 /
R
= 5 · 10
–5
, molto maggiore di
Dl
/
l
= 10
–7
: il reticolo può risolve-
re due righe vicine, ma non misurare la larghezza naturale; una riga cioè appare di sicu-
ro monocromatica.
















