
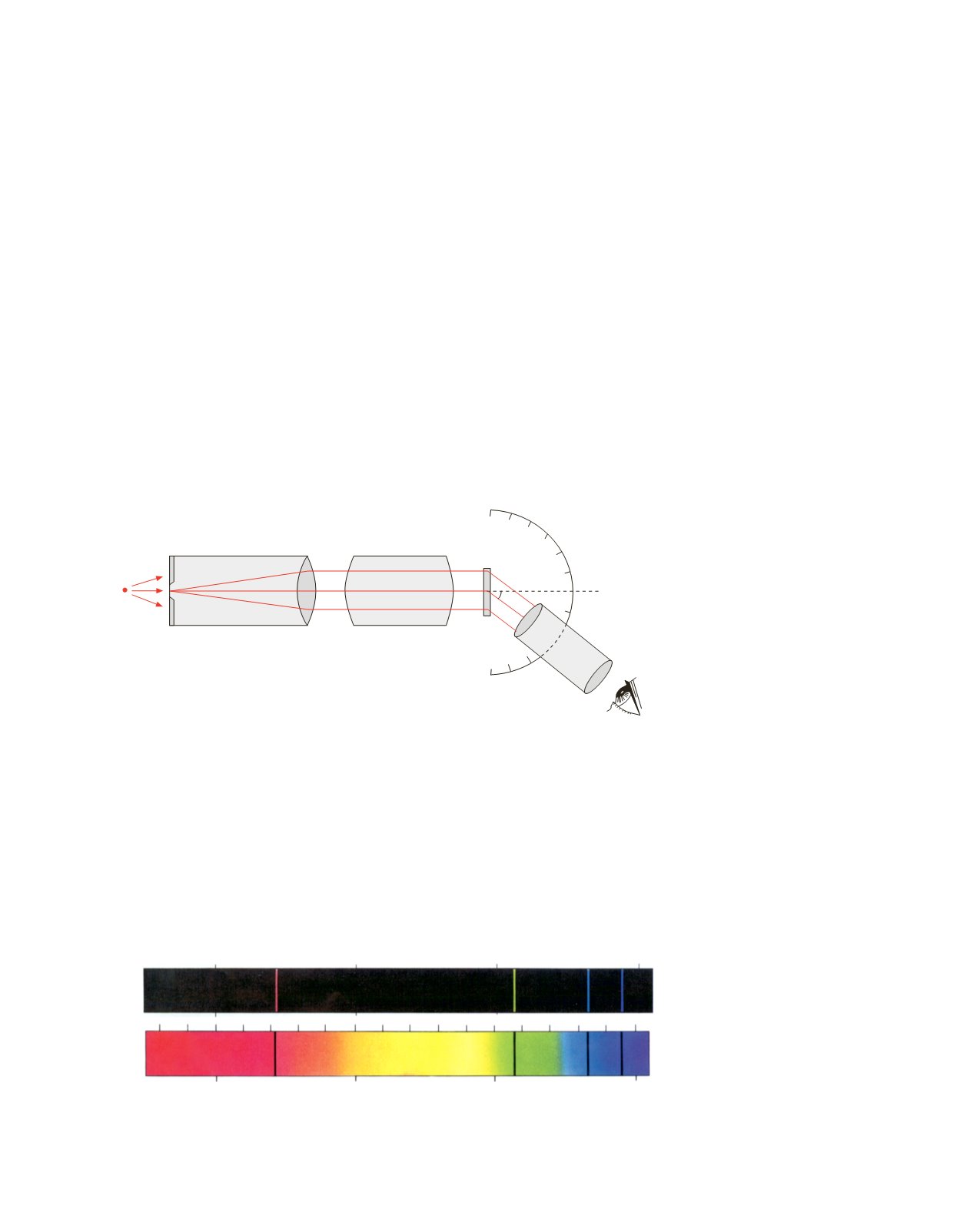
Spettroscopia con il reticolo di diffrazione
649
Gli spettri continui sono invece emessi da solidi e liquidi portati a temperatura
elevata; un esempio sono i filamenti delle comuni lampadine a incandescenza (vedi
figura 13.41). Le caratteristiche di questi spettri di emissione dipendono dalla tem-
peratura di equilibrio e anzi si può dire con buona approssimazione che ad una stes-
sa temperatura tutti i corpi hanno lo stesso spettro di emissione.
Il
deuterio
, isotopo dell’idrogeno con il nucleo formato da un protone e da un
neutrone invece che da un solo protone, venne scoperto nel 1932 analizzando con
uno spettroscopio a reticolo lo spettro di una lampada contenente idrogeno. Accanto
alla riga azzurra con
l
= 486.1 nm, tipica dell’idrogeno, venne osservata per la
prima volta una riga molto debole, separata soltanto di 0.13 nm, correttamente inter-
pretata come il segnale della presenza, in piccola percentuale, di una diversa specie
atomica. Il potere risolutivo necessario per questa misura è dell’ordine di 4 · 10
3
.
Spettri di assorbimento
Se esaminiamo con uno spettrometro a reticolo la luce emessa da un filamento
incandescente e puntiamo il telescopio nella regione angolare corrispondente alle
direzioni dello spettro del prim’ordine, osserviamo una striscia continua di colori
dal violetto al rosso. Supponiamo ora di interporre tra la lampada e il reticolo un
recipiente di vetro trasparente riempito ad esempio con vapori di sodio: lo spettro
continuo colorato appare solcato da due linee nere, in una posizione che corrispon-
de alle due lunghezze d’onda citate nell’esempio 16.9. Si dice che il sodio ha
assor-
bito
le due lunghezze d’onda e le due linee nere vengono chiamate
righe di assorbi-
mento
. Interponendo varie sostanze si osserva ogni volta una serie diversa di righe
di assorbimento che nel loro complesso costituiscono uno
spettro di assorbimento
.
Figura 16.30
C
q
F
sostanza
che assorbe
L
1
R
L
2
L
3
T
S
l
(nm)
700
600
500
400
l
(nm)
700
600
500
400
H
H
Figura 16.31
Spettri di assorbimento
















