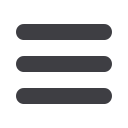

440
Parte Terza
Teorie educative e pratiche didattiche
www.
edises
.it
no sorgere l’idea di un quadrilatero. Gli uomini che, invece, vivono in ambienti
naturali, privi di spigoli, come quelli delle società tribali, non organizzano le
informazioni visive alla stregua dell’uomo occidentale, di conseguenza non uni-
scono punti disgiunti in figure geometriche.
Le
illusioni ottiche
rappresentano inganni percettivi, prodotti dalla mancata abi-
tudine a organizzare certi dati visivi. Gli esiti di
ricerche
condotte
su ciechi
hanno
confermato l’ipotesi gestaltista secondo cui la percezione è il risultato di un’attivi-
tà organizzatrice della mente, che ha inizio al momento della nascita e prosegue
durante le fasi evolutive, nell’interazione con l’ambiente. Alcuni soggetti nati non
vedenti sono stati sottoposti a operazione al fine di acquistare la vista, ma l’esito
dell’esperimento è risultato negativo: i soggetti, che non avevano iniziato l’attività
percettiva al momento della nascita, si sono ritrovati a registrare dati visivi privi di
forma, perciò di significato.
Bruner
ha ripreso gli esiti della ricerca gestaltista nella sua pedagogia, focaliz-
zando l’attenzione sul
ruolo
dell’
ambiente
nello
sviluppo cognitivo
. Inoltre, si è
avvalso dei risultati delle indagini condotte da Piaget e da Dewey, ma ne ha preso
in parte le distanze.
Per quanto riguarda
Dewey
, la
critica
principale di Bruner consiste nel negare la
piena fiducia che il suo compatriota aveva nel perpetuarsi della democrazia e nel
progresso tecnologico. L’avvento dei regimi totalitari aveva messo in discussione
l’idea di un’armonia definitivamente raggiunta tra individuo e società, mentre la
scomparsa delle differenze sociali che sarebbe dovuta seguire al progresso tecno-
logico si rivelava una chimera.
Secondo Bruner, data l’instabilità della realtà sociale, la
scuola
:
>
deve offrire
visioni del mondo molteplici e differenti
e spingere l’alunno ad
esplorarle;
>
deve introdurre
esperienze nuove
e non necessariamente in continuità con
quelle precedenti;
>
deve
organizzare in maniera programmatica
le proprie finalità educative e i pro-
pri obiettivi;
>
deve inoltre
educare alla socialità
, ma attraverso la formazione di organismi
collettivi, che favoriscano un’interazione regolata tra le parti.
Per quanto riguarda Piaget, Bruner, pur prendendo atto della validità degli esiti
della sua ricerca, ritiene che il pedagogista svizzero non abbia focalizzato abba-
stanza l’attenzione sull’ambiente e sui modi attraverso cui può condizionare lo
sviluppo delle età evolutive.
La
scuola
, in quanto ambiente di apprendimento, deve
promuovere un’azione
programmata
volta a
potenziare
lo
sviluppo delle età evolutive
, anziché limitarsi
ad assecondarlo. Inoltre, essa deve essere in grado di intervenire tempestivamen-
te e in maniera appropriata nei casi in cui lo sviluppo mentale sia frenato e non
agevolato dalle caratteristiche dell’ambiente sociale in cui ha luogo.
Le riflessioni di Bruner conducono a una
riforma delle finalità
e
degli obiettivi
educativi
. Lo psico
-
pedagogista statunitense torna a porre l’accento sui
contenuti
,
promuovendo interventi educativi volti ad
incentivare
le
eccellenze
e a offrire un
vasto repertorio di discipline a tutte le età.
















