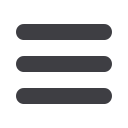

442
Parte Terza
Teorie educative e pratiche didattiche
www.
edises
.it
Di questo insieme di discipline la pedagogia continua a essere parte integrante e
dispositivo di controllo riflessivo
, distinguendosi attraverso un lungo e graduale
processo di ricerca e sistematizzazione di
un proprio statuto epistemologico
, attra-
verso la definizione di elementi peculiari come un oggetto di studio specifico, di un
lessico caratterizzante
, di una
propria metodologia
, di una propria
specifica voca-
zione teorico-pratica
.
La pedagogia si caratterizza come la
disciplina scientifica
che riflette criticamente
sui processi educativi e formativi, in un confronto circolare e mai interrotto tra teo-
ria e prassi e in una tensione sempre viva verso una meta (l’utopia), che è obiettivo
cui deve tendere la società.
Quello di definizione del proprio statuto epistemologico è stato, in realtà, un proces-
so graduale e in continuo divenire, che ha attraversato fino a oggi alcune tappe cru-
ciali e momenti di profonda revisione, come è naturale che accada per una scienza
che si connota per una forte progettualità sociale.
Particolarmente significativa e foriera di cambiamenti è stata la fase di autocritica, di
ripensamento e revisione della propria identità che la pedagogia ha attraversato nel
secondo Novecento e che si è protratta fino agli
anni Novanta
.
In questo periodo storico, la fine della Seconda guerra mondiale e dei totalitarismi
pone l’uomo occidentale, e in particolare il pedagogista, di fronte alla necessità da
un lato di spiegare gli orrori del Novecento e di elaborare una visione che spieghi,
concili e dia un senso ai tanti volti di un secolo così ricco di avvenimenti, dall’altro
di trovare una strada nuova affinché nel cammino della civiltà tali orrori non siano
più replicati.
La pedagogia, in quanto
scienza progettuale
e non semplicemente analitica, svol-
ge un ruolo privilegiato in questo compito di costruzione di una società che vuole
tendere
verso un modello nuovo
, e deve raccogliere, per farlo, i cocci dei modelli
educativi ottocenteschi che, fondandosi sulle idee-ideali di nazione e patria, hanno
lasciato via libera allo sviluppo dell’imperialismo, all’esplodere dei conflitti mondiali
e all’affermazione dei regimi totalitari.
Nella delicata fase storica del secondo dopoguerra si manifesta il concreto agire di
un’utopia sulla progettualità della società. La
nascita delle Nazioni Unite
, i primi
dibattiti sui
diritti universali dell’uomo e del bambino
sono la testimonianza di un’u-
topia che ancora oggi agisce come tale, ossia come non-luogo, come non-realizzato
verso cui tendere:
una convivenza interplanetaria pacifica, costruita e alimentata
con il contributo di tutte le culture
.
Utopia
che per conservare la propria forza co-
struttiva deve restare sempre limite verso cui tendere e mai considerarsi traguardo
raggiunto e compiuto.
Anche per la pedagogia, dunque, l’utopia è elemento necessario, modello, tensione,
spinta verso qualcosa di auspicabile, ed è qualcosa di dinamico, che muta con il
mutare dei tempi e della società, e cambia quando il progetto formativo realizzato
le si avvicina troppo: muta nel senso che sposta in avanti il traguardo per tendere a
qualcosa di sempre più elevato.
Per raggiungere un obiettivo elevato la società ha bisogno della scienza della for-
mazione, capace di offrire agli individui che la compongono (e che sono soggetti in
perpetua formazione), i percorsi per realizzare se stessi, le relazioni con gli altri, la
società stessa.
















