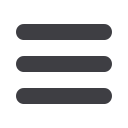

Capitolo 17
Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione e oltre
445
www.
edises
.it
definito
” e “
effetti con ridotta determinabilità
”. Esso è stato recuperato dalle scienze
umane per spiegare il mondo sociale contemporaneo e per dare una nuova lettura
della questione educativa.
L’esponente del paradigma della complessità applicato alla pedagogia è il filosofo e
sociologo francese
Edgar Morin
,
secondo il quale
la nostra
società
è caratterizzata
da
incertezza
e
imprevedibilità
.
Morin sostiene che i
fatti umani
si dividono tra
probabili
ed
improbabili
, anche se la
probabilità di un evento non ne garantisce la realizzazione
. Se pensiamo alla Storia,
non era probabile che Hitler prendesse il potere in Germania, eppure ciò è avvenuto,
è avvenuto cioè ciò che era improbabile.
Egli, inoltre, sostiene che l’
universo umano
è
contraddittorio
. Per comprendere
quest’affermazione, facciamo un chiarimento su cosa è il
principio di non contrad-
dizione
e su cosa è
il
principio del terzo escluso
, su cui si reggono logica e scienza
classica.
Secondo il
principio di non contraddizione
, non è possibile allo stesso tempo am-
mettere “A” e ammettere “non A”, in cui A è un enunciato generico. Se “A = piove”
allora “non A = non piove”. Secondo il principio di non contraddizione, se ammet-
tiamo che “A” sia vera, non è possibile ammettere che sia vera la sua proposizione
contraddittoria, cioè “non A”. Se “piove” non può essere vero allo stesso tempo che
“non piove”. In pratica
non è possibile
che
due proposizioni contraddittorie
siano
vere allo stesso tempo
.
Il
principio del terzo escluso
è un prolungamento del principio di non contraddi-
zione, in quanto chiarisce che
due proposizioni contraddittorie non possono essere
nemmeno false allo stesso tempo
. Insomma se “A” è vera, “non A” è falsa (principio
di non contraddizione); se “A” è falsa, “non A” è vera”,
tertium non datur
(principio del
terzo escluso).
Per secoli, la logica classica ed i principi di non contraddizione e del terzo escluso
sono stati applicati anche all’interpretazione del mondo psichico e sociale. Se “sono
triste” non è possibile che allo stesso tempo “non sono triste”. È questo il grosso erro-
re compiuto dall’uomo secondo Morin.
La logica classica serve a spiegare una parte del mondo inanimato (oggetto di studio
della fisica terrestre), che si distingue per la sua semplicità, non il mondo dell’uomo,
che si distingue per la sua complessità.
Il mondo dell’
uomo
è fatto di eventi in cui coesistono l’
aspetto biologico (specie),
quello
psichico (individuo)
e quello
sociale (cultura)
.
In questo mondo,
il contraddit-
torio di una verità profonda è un’altra verità profonda
.
Ma entriamo nei dettagli e presentiamo il pensiero di Morin, partendo dalle sue
riflessioni generali per arrivare alla questione dell’educazione. Secondo il filosofo
francese, la nuova scienza umana deve partire dai seguenti assunti:
>
la
verità umana
comporta l’
errore
;
>
l’
ordine umano
comporta il
disordine
;
>
la
risposta giusta
non può che essere
complessa
e
contraddittoria
.
Il
limite storico
della
cultura occidentale
consiste nel fatto che gli eventi sono sem-
pre stati parcellizzati e separati, adoperando i principi di non contraddizione e del
terzo escluso. Si pensi in proposito alla tendenza della psicologia a
separare “sani-
















