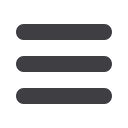
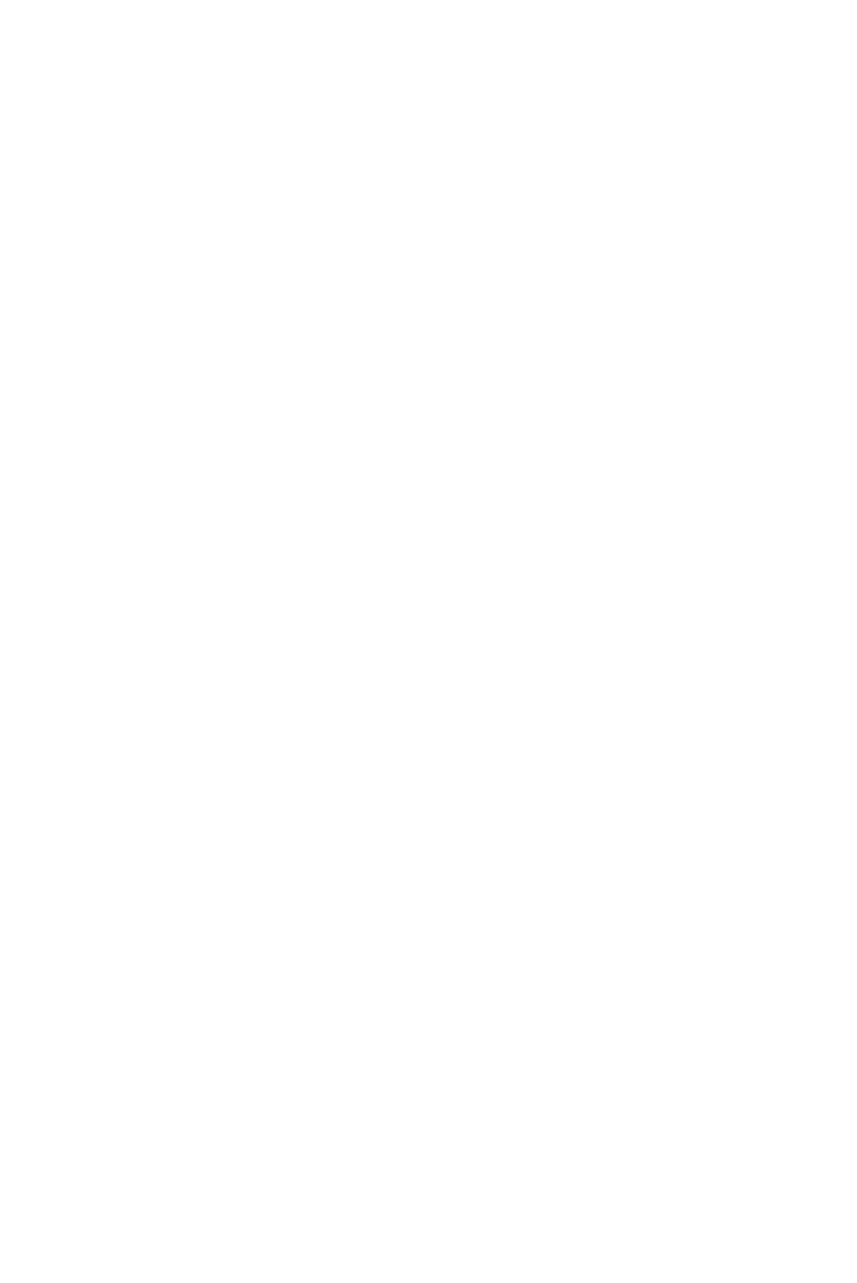
Capitolo
1
Verso la scuola di domani
15
goziare, argomentare, dare e recepire ordini e istruzioni...) per usare la lingua
correttamente.
1.3.5
L’autovalutazione e il concetto di errore
Fino a tempi recentissimi, la valutazione di un apprendente era competenza
esclusiva del docente, che la trasformava in votazioni a prove orali e scrit-
te con ampia discrezionalità circa i parametri e gli strumenti di valutazione
adottati. Il voto era il risultato di un semplice conteggio di errori e la valuta-
zione finale la media matematica dei singoli voti. Che facesse 60 errori o 25
il risultato era una decisa insufficienza, perché si valutava la quantità e non
la qualità e non si teneva conto della tipologia dell’errore e neppure del
criterio di misurazione: se in un test oggettivo formativo, diciamo di cono-
scenza del lessico, l’apprendente commette 25 errori su base 100, dimostra di
conoscere il 75% di quanto richiesto, una conoscenza media e sicuramente
più che positiva; se al contrario ne commette 60, siamo al 40%, un livello in-
feriore alla media. In passato, arbitrariamente, un docente fissava un numero
x di errori, sotto il quale la prova era ritenuta un insuccesso. Questo portava
lo studente a perdere fiducia in sé e nella scuola, e i continui insuccessi, che
non tenevano conto del progresso compiuto, lo demoralizzavano e demoti-
vavano. Oggi, tale modo di operare non è più possibile né accettabile. Nel
proporre un piano didattico basato sulla formulazione di obiettivi da rag-
giungere, descrittori correlati, con l’esplicitazione dei metodi adottabili, e
strategie di lavoro, il QCER ha voluto indicare la via per aiutare l’apprenden-
te nel suo cammino, per renderlo sempre più l’artefice dei suoi successi for-
mativi. Abbiamo già detto della centralità dello studente, delle sue esigenze
formative nell’ottica di una maggiore personalizzazione dell’apprendimento,
agendo sulla motivazione e sul suo interesse. Oggi la priorità è sviluppare
nell’apprendente la responsabilità del suo percorso formativo e l’autonomia,
rendendolo consapevole che può imparare e migliorare perché già possiede
delle abilità e delle conoscenze che vanno solo accresciute e canalizzate in
modo opportuno, grazie alla disponibilità di nuovi mezzi che, per la loro
caratteristica di trasparenza e oggettività, lo mettono in condizione di capire
cosa gli serva maggiormente. Questo sistema è applicabile anche alla scuola
primaria? In linea di principio la risposta è affermativa, perché il QCER è sta-
to pensato per tutti gli apprendenti, di qualsiasi livello di competenza lingui-
stica e di qualsiasi età (non è un caso che si parli di “apprendimento su tutto
l’arco della vita”). Certamente vi sono differenze sostanziali di cui bisogna
tenere conto. Innanzitutto, come si è già avuto modo di sottolineare, il ruolo
del docente è ancora predominante nella scuola primaria, soprattutto nei
primi tre anni, in cui l’alunno non ha ancora acquisito la maturità necessaria
per gestire il proprio apprendimento con una certa autonomia. L’esperienza
di ogni docente porta a considerare che nella maggior parte dei casi, soprat-
tutto nel bambino, l’errore non è frutto di cattiva volontà o trascuratezza, ma
deriva da interferenze con la lingua madre o con altre lingue note (si pensi


















