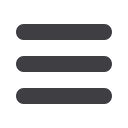

Capitolo
1
Verso la scuola di domani
13
ad A1. Ciò non esclude che si possa, con classi particolarmente motivate e con
una buona dotazione di risorse, raggiungere qualcosa di più, identificabile nel
sottolivello A1+ o anche il livello A2, nel caso di specifiche sperimentazioni
17
.
Ciò conferma il carattere flessibile del QCER. I livelli sono descritti in termini
molto generali, universali, non legati a un contesto, in modo che si adattino a
ogni situazione nei diversi ambiti sociali (chiamati
domini
), ma, ai fini di una
misurazione il più possibile aderente alla realtà, essi devono essere ritagliati e
riformulati “su misura” per il singolo utente. Poiché si riferiscono ad abilità, i
descrittori sono espressi in termini di “saper fare” (
can do
)
18
. Ribadiamo che
per essere comprensibili a tutti e per non dare adito a fraintendimenti, i de-
scrittori usano un linguaggio molto semplice, quanto a struttura e lessico. Ove
possibile i livelli di riferimento sono integrati da altre griglie che descrivono gli
aspetti
qualitativi
dell’uso della lingua. Ad esempio, con riferimento alla lingua
parlata, è a disposizione un’ulteriore griglia che descrive, per ogni livello, non
solo a che livello si sappia usare la lingua, ma “quanto bene” la si sappia usare
tenendo conto di altri aspetti quali: l’accuratezza, la scioltezza, l’estensione e
la ricchezza della lingua, la coerenza e la capacità di usare la lingua per inte-
ragire (non solo porre domande e saper rispondere, ma saper iniziare una
conversazione, intervenire in una già in corso, sospenderla e riprenderla....)
19
.
Veniamo ora al confronto fra la scala globale dei livelli e quella, emanazione
della prima, usata anche per l’auto-valutazione
20
. Confrontando i descrittori si
comprende immediatamente la coerenza interna al progetto: dall’universale si
scende sempre più verso il particolare. Ora vogliamo portare il lettore a notare
alcuni aspetti che li distinguono e indicano la loro complementarietà. Dalla
formulazione in termini generali di un descrittore, in modo tale che si addica a
qualunque apprendente, si procede a declinarlo in termini sempre più concre-
ti, affinché lo si possa applicare all’esperienza individuale del singolo appren-
dente. L’espressione riferita all’acquisizione di una abilità “
saper
fare/
can do
”
viene coniugata in “
so
fare/
I
can
do
”. L’autodidatta, l’apprendente adulto, il
docente, il docente in collaborazione con l’alunno hanno la possibilità anche
di costruire una propria griglia con descrittori da loro formulati
ad hoc
per
misurare il proprio progresso, una tipologia di prova o perfino una singola
per-
formance
. Potremmo dire che la scala globale serve all’apprendente e/o al do-
cente per definire la finalità dell’azione didattica, la griglia di auto-valutazione
17
Citiamo come esempio la sperimentazione
Bilingual Education, Italy
– Insegnamento
Bilingue, Italia (B.E.I-I.B.I) attivo in alcune scuole primarie e che presenta le seguenti
caratteristiche: a) i docenti devono essere in possesso di competenze di Livello B2; b) la
quantità minima di ore curricolari dedicate all’inglese è pari al 25% del tempo settimana-
le disponibile; c) qualsiasi materia può essere insegnata in inglese; d)le abilità di lettura
e scrittura in inglese (alfabetizzazione) iniziano sin dalla classe prima per consentire ai
bambini di acquisirle al meglio. Il progetto pilota si concluderà nell’a.s. 2014/15.
18
Cfr. QCER, capitolo 3.3, Tabella 1.
19
Cfr. QCER, capitolo 3.4, Tabella 3.
20
Si veda il paragrafo 1.3.2.


















