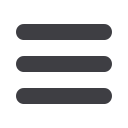

www.
edises
.it
20
Parte Prima
La didattica dell’italiano
linguistico anche in
sincronia
(cioè in un determinato punto dell’asse temporale). La
lingua, infatti, deve necessariamente adeguarsi a innumerevoli contesti culturali e
sociali e deve poter rispondere alle molteplici esigenze comunicative dell’individuo
inserito in una comunità in uno specifico momento storico. Si parla, in questo caso,
di variazione
interna
della lingua, campo d’indagine della
sociolinguistica
, che
studia
le relazioni degli idiomi con la società di cui sono espressione e con gli usi che ne
fanno i parlanti.
Quando delle forme linguistiche presentano la stessa (o simile) distribuzione sociale,
tendono cioè a occorrere insieme e in concomitanza di particolari caratteristiche del-
la società, dei suoi membri e dei contesti in cui questi agiscono, allora si parla di
varie-
tà linguistica
. Si tratta di un concetto fondamentale per la sociolinguistica che intende
la lingua come la somma delle varietà con cui si manifesta negli usi comunicativi
concreti in una specifica comunità.
In base al tipo di fattore con cui si correlano, le varietà linguistiche possono classifi-
carsi secondo diverse dimensioni di variazione: se si tiene conto dello spazio geografi-
co, cioè dei luoghi in cui una lingua viene parlata, si parla di
variazione diatopica
;
considerando lo spazio sociale, cioè le classi e gli strati della società, si parla di
varia-
zione diastratica
;
tenendo conto delle diverse situazioni comunicative, si parla di
va-
riazione diafasica
; distinguendo infine tra i mezzi o canali mediante i quali la comu-
nicazione avviene (tra cui anche lo scritto e il parlato), si parla di
variazione diamesica
.
La situazione linguistica italiana è un esempio davvero importante di
variazione dia-
topica
, che si manifesta principalmente nella fonetica e nel lessico. Lungo tutta la
Penisola, infatti, si distinguono quelli che vengono definiti
italiani regionali
caratteriz-
zati da peculiarità ben precise che li differenziano gli uni dagli altri: un esempio fone-
tico davvero noto in questo senso è la “gorgia toscana”, ma i “regionalismi” riguarda-
no tutti i livelli di analisi della lingua, ce ne sono, infatti, anche di morfologici,
semantici, sintattici e lessicali. Questi ultimi, in particolare, risultano senza dubbio tra
i casi più evidenti e individuano i cosiddetti “
geosinonimi
”, cioè dei termini diversi a
seconda della zona geografica in cui vengono usati, ma che designano tutti lo stesso
oggetto, come i termini
anguria
,
cocomero
e
melone
usati per indicare tutti lo stesso frut-
to (al nord, in Toscana e al sud).
Variazione diastratica
In merito alla variazione diastratica, quella cioè che tiene conto delle classi sociali, va
detto innanzitutto che tutte le varietà di questo tipo si muovono lungo un asse orien-
tato dal basso verso l’alto. I fenomeni più evidenti di variazione diastratica sono quel-
li che caratterizzano le varietà più “basse”, ovvero non di prestigio, e che dipendono
spesso da un’insufficiente conoscenza della lingua standard a causa dell’uso prevalen-
te del dialetto, vera lingua madre dei ceti con basso grado d’istruzione. Tali varietà,
dunque, si riscontrano generalmente nel parlato dei ceti definiti “popolari” e per
questo sono raggruppate nella definizione di
italiano popolare
. Anche per la variazio-
ne diastratica i fenomeni che distinguono le differenti varietà si concretizzano a tutti
i livelli di analisi della lingua. Tra questi i più noti e immediatamente riconoscibili, a
livello fonetico, sono la pronuncia tipicamente romana [
ˈ
bi
ː
ra] invece di
birra
, o evi-
dentemente siciliana [
ˈ
ma
ːʈɽ
e] invece di
madre
. Un esempio sul piano della sintassi,
invece, è il notissimo
se potrei, farei
, tipico dei napoletani abituati a parlare il dialetto e
















