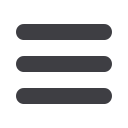
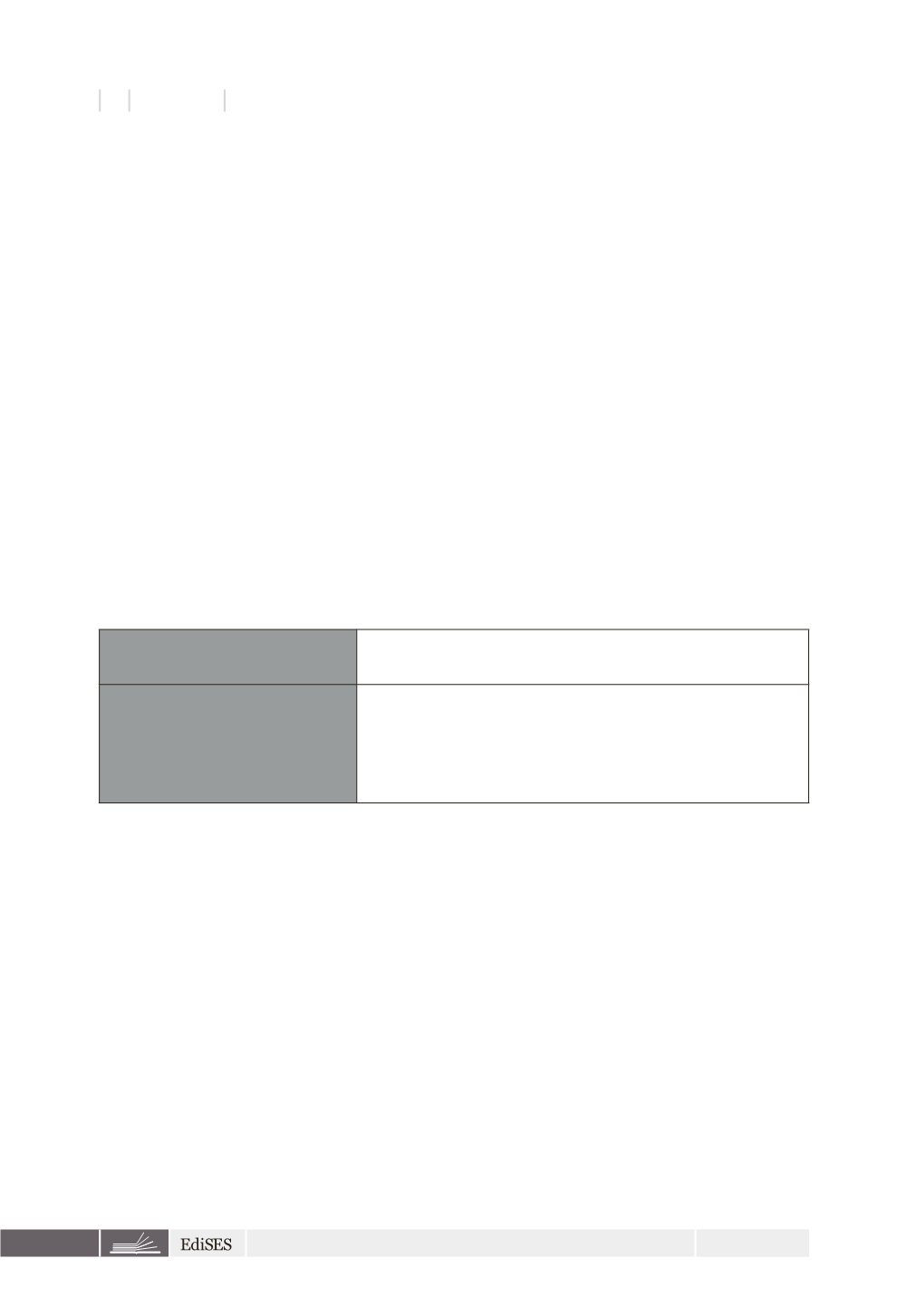
www.
edises
.it
18
Parte Prima
La didattica dell’italiano
ro e nei settori scientifico-disciplinari che il Ministero dell’Istruzione prescrive quale
requisito indispensabile per aspirare all’abilitazione all’insegnamento di una specifica
materia. Ne consegue che il docente di lettere è chiamato a una continua attività di
approfondimento di settori della cultura anche assai distanti tra loro, che richiedono
lo sviluppo di competenze e di metodologie differenti.
È opportuno, inoltre, fare una distinzione tra le scuole del primo ciclo, comprenden-
te la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, e gli istituti secondari di se-
condo grado. Nelle prime, infatti, sono state progressivamente introdotte metodolo-
gie basate su abilità e capacità, grazie anche a interventi legislativi mirati (i programmi
del 1979 e del 1985 e le
Indicazioni
Moratti e Fioroni). Nella scuola secondaria di se-
condo grado, invece, a causa di un vuoto normativo generalizzato e a sperimentazioni
mal riuscite, si assiste a una evidente supremazia della conoscenza sulla competenza e
a una vistosa spaccatura tra un triennio, in cui l’insegnamento dell’italiano è legato
alla lettura e all’interpretazione dei testi, e un biennio finale in cui si sviluppano le
capacità di produzione degli stessi. Ancora diversa la situazione dell’insegnamento
dell’italiano negli istituti professionali, nei quali è l’elemento linguistico a prevalere
su quello letterario, in virtù di una vicinanza al mondo del lavoro che induce i docen-
ti a strutturare quasi naturalmente un curricolo per competenze e abilità.
Nella tabella di seguito sono schematizzate le
differenze tra programmazione per
competenze e programmazione tradizionale
.
DIDATTICA TRADIZIONALE
Prevede un’organizzazione lineare e sequenziale, la lettura e
la memorizzazione. È l’insieme a comporre il programma.
DIDATTICA MODULARE
(PER COMPETENZE)
Prevede un’organizzazione per unità tematiche di
apprendimento, ognuna delle quali, compiuta in sé,
conduce a competenze certificabili. L’insieme costituisce
un curricolo. L’analisi è di tipo sincronico e procede per
associazioni.
Con l’introduzione delle competenze, in altri termini, non cambia tanto il contenuto
cognitivo, ma la sua finalità formativa, per cui la domanda giusta da porsi come do-
cente non è più “
I miei studenti hanno memorizzato la lezione
?”, quanto “
Quali competenze,
tra quelle indicate dagli assi culturali, la mia disciplina contribuisce a conseguire e sviluppare
?”.
Sebbene non manchino i sostenitori della didattica tradizionale, risulta difficile nega-
re i rilevanti
vantaggi della programmazione per competenze
, che possiamo di seguito
elencare:
>
>
sviluppo del cosiddetto
Decision Making
(DM) adattivo, ovvero la capacità dello stu-
dente di operare risolvendo problemi in situazioni complesse. Questo tipo di capaci-
tà rende il discente in grado di trovare una soluzione efficace tra le diverse possibili;
>
>
sviluppo dell’agire strategico, che abitua lo studente a fare previsioni le quali, com’è
stato ampiamente dimostrato nell’ambito delle scienze cognitive, sono il fine ulti-
mo dell’apprendimento e la modalità che consente la sopravvivenza della specie;
>
>
sviluppo della riflessività e del pensiero critico.
















