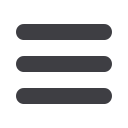

www.
edises
.it
14
Parte Prima
La didattica dell’italiano
presentato un arricchimento della valenza culturale della materia, attraverso l’attribu-
zione di nuove e più vive finalità didattiche.
L’insegnamento della lingua madre in Italia, dall’introduzione dell’obbligo scolastico
agli anni Settanta, è stato impartito seguendo rigidi modelli formali. Nemmeno la
presa di coscienza, nei decenni successivi, dell’evidente contrasto tra la lingua reale e
quella appresa sui banchi di scuola è riuscita a innovare in maniera sostanziale tale
approccio, ragion per cui l’introduzione delle competenze ha rappresentato un’evo-
luzione necessaria.
L’esigenza di svecchiare la pedagogia linguistica tradizionale attraverso un’educazio-
ne linguistica ancorata al tessuto sociale e al vissuto degli allievi si è manifestata con
forza prorompente già dal 1975, con la pubblicazione delle famose
Dieci tesi per l’edu-
cazione linguistica democratica
, opera di un gruppo di linguisti capeggiati dal professor
Tullio De Mauro. Partendo dal presupposto che la lingua rappresenti il perno centra-
le intorno al quale si sviluppano tutte le capacità dell’individuo, le
Dieci tesi
propongo-
no una pedagogia linguistica democratica, basata su una lingua più colloquiale e par-
lata, per l’insegnamento della quale è importante tener conto delle caratteristiche dei
destinatari, non più intesi, dunque, come recipienti vuoti da riempire, ma come sog-
getti titolari di abilità di interazione. L’opera ha avuto un’enorme risonanza nel setto-
re scolastico e istituzionale del nostro Paese, tanto che molti degli elementi innovativi
proposti sono stati mutuati nei successivi
Programmi per la scuola media
del 1979. In essi
viene, infatti, sottolineato l’aspetto multifunzionale del linguaggio e il ruolo che svol-
ge nello sviluppo delle capacità critiche dello studente; gli obiettivi assumono il carat-
tere di capacità trasversali necessarie per accedere ai diversi ambiti della conoscenza,
e per la prima volta si parla di apprendimento linguistico in termini di abilità di base:
ascoltare, parlare, leggere e scrivere.
È facile notare come questa moderna impostazione, successivamente aggiornata dalle
Indicazioni nazionali
del 2007 e poi del 2012, contenga
in nuce
molti elementi presenti
nella
Raccomandazione dell’Unione Europea
del 2006, a testimonianza del fatto che an-
che in Italia fosse avvertita l’esigenza di conferire all’insegnamento della lingua ma-
dre finalità più concrete e operative.
Per dirla con Elvira Zuin
1
: “
Le Raccomandazioni europee, assumendo il concetto di competen-
za come base per l’innovazione del sistema scolastico, appongono il marchio dell’ufficialità legi-
slativa a un’ipotesi pedagogica già condivisa in ambito scientifico e delineano gli obiettivi verso
i quali indirizzare l’azione educativa
”.
Con le competenze entrano finalmente dalla porta principale del sistema scolastico
italiano i concetti di trasversalità, pluridisciplinarità, unitarietà del sapere e centralità
dell’allievo.
2.2
Conoscenze, abilità e competenze: un opportuno distinguo
Prima di affrontare diffusamente il discorso della progettazione didattica basata sulle
competenze, occorre sgombrare il campo da qualsiasi equivoco terminologico, ope-
1
E. Zuin,
Il curricolo per competenze e l’italiano
, Iprase Trentino.
















