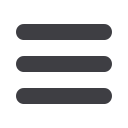

www.
edises
.it
24
Parte Prima
La didattica dell’italiano
sciuta anche a livello nazionale. L’interazione e il contatto tra dialetto e lingua stan-
dard sono, dunque, frequenti e producono effetti sul concreto modo di parlare degli
individui, condizione di cui l’insegnante d’italiano deve essere ben consapevole per
l’efficace insegnamento della lingua standard e per la correzione di alcuni errori ri-
correnti che spesso derivano proprio dall’influenza del dialetto.
2.4.2
Plurilinguismo e interculturalità nella scuola italiana
Ogni anno, a partire dal 1996, il Miur pubblica un rapporto, dal titolo
Alunni con cit-
tadinanza non italiana
, che descrive la realtà degli studenti stranieri nelle classi e si
pone come strumento fondamentale per la pianificazione delle politiche educative da
mettere in atto nell’adeguamento della didattica alle trasformazioni della scuola ita-
liana. Il dato che emerge dalla lettura del documento per il 2013-2014 è significativo:
gli alunni con cittadinanza non italiana sono passati dai 196.414 dell’anno scolastico
2001-2002 (0,8%) agli 802.844 del 2013-2014 (7,9%). Sebbene il rapporto riveli che
dal 2008-2009 si registra un progressivo rallentamento, dovuto probabilmente sia allo
stabilizzarsi del flusso migratorio verso l’Italia sia alle conseguenze della crisi finanzia-
ria, la presenza comunque rilevante di studenti di origine straniera chiama ad attuare
degli adeguamenti della didattica alle esigenze di alunni che devono, contempora-
neamente, acquisire le nozioni di una lingua diversa da quella materna e utilizzarla
per l’apprendimento specialistico di altre discipline. Allo stesso tempo, i nuovi model-
li didattici non devono penalizzare lo svolgimento dei programmi e l’apprendimento
generale del gruppo classe.
La composizione delle classi e le difficoltà del docente
La cittadinanza di origine più frequente tra gli studenti stranieri è quella rumena,
seguita dall’albanese e dalla marocchina, ma consistenti sono anche i gruppi dei cine-
si e dei filippini, in accrescimento insieme a quelli dei pakistani e degli egiziani.
A variare, tuttavia, non è solo l’origine degli studenti con cittadinanza non italiana,
ma anche la loro distribuzione sul territorio nazionale. In regioni in cui il fenomeno
dell’immigrazione è più rilevante, come la Lombardia (che con i suoi 197.202 alunni
stranieri detiene il primato delle presenze), l’Emilia Romagna, il Veneto, il Lazio e il
Piemonte, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana è maggiore e, conse-
guentemente, la percentuale di incidenza della loro presenza sul totale della popola-
zione scolastica è più alta. Le regioni in cui, infatti, il numero degli stranieri è minore
sono le meridionali, come Puglia, Basilicata, Sardegna e Campania, non a caso quelle
in cui l’immigrazione assume proporzioni più ridotte, sebbene vada registrato pro-
prio in queste regioni un incremento degli alunni stranieri che è doppio, a volte tri-
plo, rispetto alla media nazionale del 6,2%: per esempio il 20,5% in Basilicata e il 14,3
in Campania. A prescindere tuttavia dalle differenze lungo la Penisola, il docente di
italiano si trova a dover gestire una classe costituita da una prevalenza di allievi italiani
che hanno un’alta competenza della lingua di scolarizzazione (l’italiano appunto) e
da una minoranza più o meno significativa, ma mai irrilevante, di studenti stranieri
con un livello di competenza linguistica inferiore a quello dei madrelingua. Altra
considerazione che va fatta rispetto alla composizione delle classi riguarda una carat-
teristica specifica del gruppo straniero che, oltre a essere composto da studenti di
















