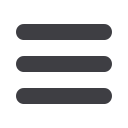

www.
edises
.it
28
Parte Prima
La didattica dell’italiano
studio di altre discipline. Tale metodologia si rivela molto produttiva, in quanto, spo-
stando l’attenzione dello studente su contenuti disciplinari specifici, lo distrae dall’o-
biettivo di imparare una lingua diversa. Essa, quindi, si basa sul presupposto che non
c’è mezzo migliore per approfondire la conoscenza e l’uso di una lingua che usarla
per apprendere.
Attraverso un percorso che dal più semplice porta al più complesso, le nuove metodo-
logie proposte dalla glottodidattica considerano fondamentale sia la dimensione indi-
viduale, in cui lo studente approccia da solo il manuale, sia quella collettiva, in cui
invece attraverso attività rivolte all’intera classe i singoli sono coinvolti nel confronto,
nella rielaborazione e nella comunicazione di quanto acquisito. Sfruttare la lingua
per veicolare dei contenuti diversi dalla lingua stessa, dunque, sembra la condizione
migliore per implementarne l’uso e le competenze. In quest’ottica la partecipazione
del singolo alle attività del gruppo classe si rivela fondamentale. Per lo studente stra-
niero – che alla difficoltà di acquisizione della lingua di studio aggiunge quella della
lingua di base – è essenziale fare uno studio individuale semplificato, nel lessico e
nella lingua in genere, e facilitato, mediante la proposta di compiti progressivamente
più complessi che facciano da guida nella rielaborazione dei contenuti. Allo stesso
tempo è altrettanto importante, per lo straniero come per l’italofono, svolgere attività
di gruppo sugli argomenti più idonei ad approfondire la lingua e allo stesso tempo a
favorire lo scambio interculturale. In questo ambito specifico, svolge un ruolo di gran-
de importanza il
peer tutoring
, cioè un’attività che prevede la suddivisione della classe
in coppie o in gruppi all’interno dei quali si sceglie un elemento che svolga il ruolo di
docente e spieghi al compagno/i il tema da trattare. Questo tipo di apprendimento è
molto produttivo perché coinvolge gli studenti a più livelli:
linguistico
, perché sono
chiamati a esercitare la lingua per farsi capire meglio e allo stesso tempo comprende-
re, avendo anche più tempo a disposizione che in un contesto di classe normale;
di
obiettivi educativi
, perché anche lo studente con maggiori difficoltà riesce a svolgere
compiti che da solo non riuscirebbe a portare a termine e, allo stesso tempo, a dare il
proprio contributo;
psicologico
, in quanto proprio il successo nello svolgimento del
compito e il contributo dato accrescono la sua autostima.
Non bisogna dimenticare, infine, che la scuola è oggi tenuta a formare cittadini italia-
ni che siano al medesimo tempo cittadini dell’Europa e del mondo; valorizzare le
differenti identità e radici culturali significa, pertanto, anche educare alla convivenza,
trasmettendo i valori fondanti della tradizione nazionale, arricchiti da una gamma di
espressioni ed esperienze molto più cospicua rispetto a ieri.
In conclusione, nella gestione della classe plurilingue, che sta progressivamente di-
ventando la “normalità” del sistema scolastico italiano, i contributi della glottodidatti-
ca e degli studi sull’insegnamento della L2 si rivelano fondamentali per la soluzione
del problema linguistico, che sempre più va tenuto al centro dell’attenzione e dalla
cui risoluzione i singoli studenti, così come l’intero gruppo classe, possono ricavare
dei seri miglioramenti in termini di apprendimento e di serenità di studio.
In questa prospettiva, il plurilinguismo diventa un’imprescindibile risorsa per un mi-
gliore apprendimento dell’italiano anche per gli studenti italiani
, perché, come si leg-
ge ancora nelle
Indicazioni
nazionali
del 2012, “
l’educazione plurilingue e interculturale
rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di
tutti e di ognuno ed è presupposto per l’inclusione sociale e per la partecipazione democratica
”.
















