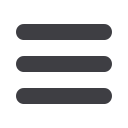

www.
edises
.it
26
Parte Prima
La didattica dell’italiano
ture, in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le
differenze di genere. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimolano in maniera vicende-
vole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli
altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente
insieme
”.
La gestione delle classi plurilingue
La letteratura in merito alla gestione delle classi plurilingue con stranieri e all’inse-
gnamento dell’italiano come lingua di studio mette in primo piano la valorizzazione
del singolo studente, che esorta l’insegnante ad accettare, dallo straniero, delle rispo-
ste anche quando queste non sono propriamente corrette per sottolinearne gli aspet-
ti da incoraggiare, quali la capacità di ragionamento o la comprensione del concetto
generale, ed evitare l’insorgere nell’alunno di un sentimento di frustrazione che può
trasformarsi in un vero e proprio blocco. In generale, l’attuale approccio comune alla
classe plurilingue prevede la differenziazione dei compiti, una comunicazione quanto
più possibile facilitata e facilitante, l’interazione negoziata dei significati, tutte strate-
gie atte a favorire l’apprendimento della lingua e, contemporaneamente, l’acquisizio-
ne dei principali contenuti.
I dati relativi al rendimento degli studenti non italiani, tuttavia, non sono incorag-
gianti e delineano un quadro generale in cui questi, frequentemente, manifestano un
ritardo rispetto ai loro coetanei madrelingua e una maggiore tendenza all’abbandono
degli studi: molti sono gli alunni stranieri che non riescono a superare l’anno e risul-
tano quindi ripetenti per il successivo, lungo tutto il percorso scolastico, ma principal-
mente nella scuola secondaria di secondo grado. Sebbene vada rilevato un progressi-
vo miglioramento rispetto al passato – dovuto probabilmente al fatto che sempre più
studenti stranieri, nati in Italia, cominciano qui il loro itinerario scolastico – il divario
esistente tra italofoni e non è ancora netto, il che invita alla ricerca di nuove metodo-
logie che tengano conto dell’esperienza fatta in questi anni e la integrino con ulterio-
ri riflessioni.
Una di queste potrebbe essere che non basta differenziare i compiti, facilitare la co-
municazione e valorizzare risposte non del tutto corrette, poiché gli studenti stranieri
avvertono la differenza di giudizio dell’insegnante, si accorgono cioè che ai compagni
italofoni viene richiesto di più e che quel “di più” rappresenta il livello “normale” da
raggiungere per soddisfare le aspettative del docente e di conseguenza del sistema
scuola. Una scuola aperta alle differenze, quindi, non significa solo considerare le
diversità sociali, culturali e linguistiche, ma anche far diventare la differenza stessa la
“normalità” della quale il singolo possa sentirsi parte anche seguendo dei percorsi
personalizzati per il raggiungimento di obiettivi fissati appositamente per lui e diversi
da quelli degli altri compagni. Un’altra riflessione utile riguarda la valutazione delle
strategie e delle politiche applicate, tenendo conto del fatto che non basta program-
marle e predisporle all’interno del contesto scuola, ma anche stabilirne l’effettiva ef-
ficacia.
Dopo una prima fase in cui l’Italia ha cercato di garantire il diritto all’istruzione agli
studenti stranieri senza la necessaria pianificazione, la cui conseguenza primaria è
stata l’inadeguatezza e l’impreparazione della classe docente nella gestione della clas-
se plurilingue e multiculturale, si è passati a una seconda in cui la buona volontà ini-
















