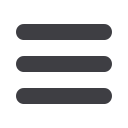

www.
edises
.it
Capitolo 2
La didattica modulare e le competenze
23
comunità, quindi non solo varietà della stessa lingua distinte lungo le quattro dimen-
sioni descritte, ma anche varietà di lingue diverse. Se una comunità possiede varietà
di più lingue diverse allora si definisce
bilingue
(se ce ne sono due) o
multilingue
(se
ce ne sono più di due). Le comunità – molto rare – il cui repertorio è formato da va-
rietà della stessa lingua si definiscono monolingue, ma tutte (monolingue e plurilin-
gue) possiedono una lingua ufficiale che ha una
varietà standard
, cioè riconosciuta
ufficialmente, codificata, dotata di grammatiche, dizionari e norme prescrittive. In
contrapposizione alla lingua standard ci sono normalmente – e in Italia è un caso
molto frequente – dei
dialetti
: “
Vale a dire varietà di lingua di uso prevalentemente orale, di
estensione areale e diffusione demografica inferiori rispetto alla lingua standard, poco codificate
ed espressione di una realtà e cultura regionale o locale
” (Berruto, Cerruti,
La linguistica. Un
corso introduttivo
).
Tale definizione descrive bene sia la condizione di idiomi che si sono differenziati, su
base diatopica, a partire da una lingua comune, com’è avvenuto per i dialetti del Nord
America derivanti dall’inglese, sia quella dei dialetti italiani che, invece, sono delle
lingue con una propria struttura e una propria storia. L’italiano standard, infatti, è
derivato dalla codificazione del volgare fiorentino e dalla sua adozione, in virtù di un
maggiore prestigio culturale ed economico, come lingua italiana, operazioni che han-
no conseguentemente assegnato il titolo di “dialetti” agli altri volgari romanzi – per-
ché derivanti dal latino – in uso nella Penisola, sebbene questi fossero di fatto delle
lingue vere e proprie.
Oltre ai dialetti, appartengono al repertorio linguistico di una comunità le
minoranze
linguistiche
, cioè delle lingue diverse dallo standard e non imparentate con esso che
sono però parlate da alcune minoranze sul territorio nazionale, come il tedesco in
Alto Adige. In Italia esistono, accanto al tedesco del Südtirol, altre due importanti
minoranze riconosciute ufficialmente: il francese parlato in Valle d’Aosta e lo sloveno
in provincia di Trieste e Gorizia. La legge 482 del 1999, tuttavia, ne riconosce anche
altre, tra cui un caso piuttosto significativo per diffusione e particolarità è l’arbëresh
(albanese) parlato in alcune zone dell’Italia meridionale.
Per quanto riguarda i
dialetti italiani
si può fare una distinzione tra:
>
>
dialetti settentrionali
, a loro volta distinti in quelli dell’area gallo-italica (piemonte-
se, ligure, lombardo, emiliano e romagnolo) e altri dell’area veneta;
>
>
dialetti toscani
;
>
>
dialetti centro-meridionali
, distinti in quelli dell’area mediana (parlati nelle Mar-
che, nel Lazio e in Umbria), altri dell’area alto-meridionale (parlati in Abruzzo, in
Molise, in Campania, in Puglia settentrionale, in Basilicata, in Calabria settentrio-
nale e centrale) e infine quelli dell’area meridionale estrema (parlati in Salento,
nella Calabria meridionale e in Sicilia). Come si può osservare, il sardo non rientra
nella classificazione dei dialetti, in quanto rappresenta di fatto una minoranza lin-
guistica parlata nelle sue diverse varietà da circa un milione di individui.
Conoscere la situazione dialettale italiana è di grande importanza per l’insegnante
d’italiano, in quanto i dialetti fanno parte del quotidiano e della vita familiare e collo-
quiale della maggior parte degli studenti. In molti casi, inoltre, sono testimonianza e
veicolo della cultura e delle tradizioni locali e in altri rappresentano delle vere e pro-
prie lingue in cui il territorio ha prodotto una propria tradizione letteraria ricono-
















