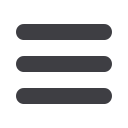

www.
edises
.it
Capitolo 2
La didattica modulare e le competenze
25
nazionalità diverse tra loro, presenta anche livelli differenti di competenza linguistica
dell’italiano (alcuni conoscono la lingua meglio di altri). Il docente di italiano, dun-
que, deve considerare contemporaneamente sia le esigenze di una maggioranza ma-
drelingua sia quelle di una minoranza con competenze linguistiche dell’italiano assai
diversificate, associate, inoltre, a differenti retroterra culturali e, nei casi dei neoarri-
vati (cioè di quegli studenti stranieri non nati in Italia, che quasi sempre hanno inizia-
to il percorso di studio nel Paese d’origine), a pregresse abitudini scolastiche.
Nel nostro Paese, quindi, l’apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio
antropologico caratterizzato da numerosi elementi: la persistenza, fortemente diversi-
ficata a seconda delle zone, della dialettofonia; la varietà delle lingue minoritarie; la
compresenza di più lingue di tutto il mondo; la presenza dell’italiano parlato e scritto
con livelli eterogenei di padronanza e con spiccate varianti regionali. Questi fattori
fanno sì che per molti studenti l’italiano rappresenti un secondo idioma. Una didatti-
ca volta alla progressiva padronanza dell’italiano implica, dunque, che l’apprendi-
mento della lingua avvenga a partire dalle competenze linguistiche e comunicative
che gli allievi hanno già maturato nel lessico nativo e guardi al loro sviluppo in funzio-
ne non solo del rendimento scolastico, ma come elemento fondamentale delle abilità
per la vita.
In particolare, in merito al plurilinguismo ormai tipico dell’Italia, anche nelle
Indica-
zioni nazionali
del 2012 si legge: “
Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella
scuola. L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconosci-
mento reciproco e dell’identità di ciascuno. A centocinquanta anni dall’Unità, l’Italiano è diven-
tato la lingua comune di chi nasce e cresce in Italia al di là della cittadinanza italiana o stra-
niera. La scuola raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di
pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze
(…)
. Questo comporta saper accet-
tare la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individua-
li vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza;
inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impedi-
scano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire
”.
La difficoltà principale dell’insegnante è soprattutto quella di doversi relazionare a
un pubblico diverso gestendo, simultaneamente, più piani d’interazione e attuando
strategie comunicative e didattiche adeguate ai gruppi e ai singoli. L’obiettivo da rag-
giungere, relativamente allo studente straniero, è quello di fornirgli, parallelamente
ai contenuti, i mezzi linguistici per rendere l’italiano la lingua dello studio e della
formazione, oltre che dell’interazione, all’interno della classe e con il docente. Poi-
ché, però, nella stessa classe ci sono anche gli italofoni e un programma da svolgere,
l’insegnante non può sacrificare l’aspetto dei contenuti e della specificità delle singo-
le materie ed è tenuto a procedere anche se gli studenti stranieri non riescono a tene-
re il passo.
Sempre secondo le
Indicazioni nazionali
del 2012: “
L’obiettivo è quello di valorizzare l’uni-
cità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. La presenza di bambini e adolescen-
ti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più essere considerato
episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Non basta riconoscere e conservare le
diversità preesistenti, nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamen-
te la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre cul-
















