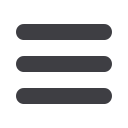

Capitolo 2
La metodologia della ricerca filosofica nelle diverse epoche storiche
9
www.
edises
.it
2.1
L’età antica
Nella cultura della Grecia arcaica, la “verità” è il frutto della rivelazione divina.
I poeti Omero ed Esiodo si dicono ispirati dalle Muse. Negli oracoli e nei culti
misterici è la divinità stessa (Apollo o Dionisio) a svelare la verità.
La riflessione sul problema della conoscenza nasce, però, con l’avvento del
pensiero filosofico, in particolare con Eraclito e Parmenide, ovvero con la con-
trapposizione tra la conoscenza sensibile (e l’opinione o
doxa
che ne è il pro-
dotto) e la conoscenza della ragione.
Eraclito (seconda metà del VI secolo a.C.), infatti, nega la validità della ricerca
della verità mediante l’esperienza e afferma che la “verità” ama nascondersi e
che si annuncia tramite “discorsi” che la velano, alludono ad essa, invitandoci
a guardare oltre l’apparenza. Il
logòs
, “legge oggettiva della realtà”, si rende
visibile solo agli occhi di una ragione intesa come sapienza che è alla portata di
pochi. Solo i sapienti, i migliori comprendono le contraddizioni della realtà e
solo a loro “eletti” le trasformazioni incessanti del mondo del divenire si mani-
festano come armonia, come
logòs
appunto.
Parmenide (VI-V sec. a.C.) sostiene che la verità è coincidenza tra pensiero ed
essere. La conoscenza sensibile afferma la molteplicità dell’esistere delle cose,
la ragione, invece, le intende come un tutto unico, un “essere”, eterno, ingene-
rato, immutabile. La
doxa
concepisce la realtà molteplice e in divenire, come
mescolanza di essere e non essere, ma chi si affida ad essa non sa che il “non
essere” “non è”, non è concepibile, non è pensabile. Solo la ragione può pen-
sare l’essere, la sola realtà effettiva, dato che il “non essere” è contraddittorio.
La riflessione sulla ricerca della verità continua con altri pensatori.
Empedocle (484-421 a.C.) afferma che la conoscenza si affida ai sensi, i proces-
si conoscitivi si realizzano grazie all’affinità fra gli “elementi” che costituiscono
gli organi sensoriali e quelli che compongono la realtà esterna: “il simile ri-
conosce il simile”, terra con terra, acqua con acqua, fuoco con fuoco.
Anassagora (496-428 a.C.) afferma il contrario: la conoscenza si ha quando il
“dissimile conosce il dissimile”, ad esempio quando si avverte in una cosa il cal-
do per contrasto con ciò che è freddo. Il processo conoscitivo non è dato solo
dalla sensazione, ma da una collaborazione tra esperienza, sapere e memoria.
La teoria della conoscenza della verità tramite ricerca empiristica è particolar-
mente presente nei sofisti, soprattutto in Protagora e Gorgia.
Protagora (486-411 a.C.) afferma che la conoscenza è sensazione e che per
questo l’uomo è misura di tutte le cose; nasce il “relativismo gnoseologico”, ov-
vero si combatte l’idea che esista una conoscenza valida per tutti, la verità muta
da individuo a individuo e in questo stesso da momento a momento. La verità
con Protagora si libera definitivamente dalla rivelazione divina, essa nasce nel
dibattito, nell’interazione tra gli uomini nella città: “vero” è ciò che è “utile” e
ciò che è “utile” o meglio più utile, più conveniente, agli uomini è altrettanto
più vero.
Gorgia (485-376 a.C.) critica la coincidenza tra pensiero ed essere affermata
da Parmenide, dimostrata dal fatto che possiamo pensare cose che nella realtà


















