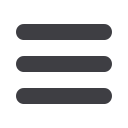

Capitolo 2
La metodologia della ricerca filosofica nelle diverse epoche storiche
13
www.
edises
.it
Diversa è l’impostazione elaborata dal filosofo francese R. Descartes (1596-
1650), che prende come modello il metodo geometrico deduttivo, basato sulla
sola ragione. Fondamento del sapere è la ragione, ma ciò che determina la dif-
ferenza tra gli uomini, il fatto che alcuni conoscano molte cose e altri meno, è
il metodo che essi usano. Cartesio suggerisce quattro regole da seguire per ben
condurre la ragione: evidenza, analisi, sintesi, enumerazione.
Quella dell’evidenza è la regola fondamentale, perché vero è solo ciò che alla
ragione si presenta come evidente, chiaro e distinto; l’analisi di problemi e
realtà complesse consiste nel ricondurli all’evidenza. La sintesi, di contro, li
ricompone in virtù di un ordine razionale; l’enumerazione verifica la validità
dei due processi di analisi e sintesi.
Cartesio avverte la necessità di individuare un nuovo fondamento del sapere e
ciò lo porta a dubitare delle comuni certezze; si spinge fino al dubbio iperboli-
co, ipotizzando l’esistenza di “un genio maligno che inganna gli esseri umani”
e che dà per certe cose che non lo sono, comprese le certezze della matematica.
Ma quello di Cartesio non è il dubbio scettico che portava a una “
epochè
”, a una
sospensione del giudizio di fronte all’apparire della realtà; il dubbio cartesiano
è “metodico”, porta cioè ad una certezza, quella dell’esistere, perché se dubito,
penso, se penso dunque esisto: “
dubito, cogito, ergo sum
”. Il “
cogito
” diventa così il
fondamento di ogni certezza e verità, legando in modo chiaro e distinto, “evi-
dente”, il pensiero e l’esistenza.
La prima conoscenza chiara e distinta ottenuta, ovvero che l’uomo in quanto
essere pensante è fondamento per la sua certezza stessa di esistere, conduce
Cartesio a dimostrare l’esistenza di Dio (che ha creato l’uomo essere pensan-
te) e che diviene così garante di tutte le nostre conoscenze chiare e distinte e
dunque anche del “
cogito
”.
Il razionalismo cartesiano non soddisfa però i suoi successori, come T. Hobbes
(1588-1679), che afferma il “materialismo metodologico”. Tutto ciò che esiste
per Hobbes è corpo ed è possibile conoscere solo ciò che è materiale e quindi
la conoscenza non può che fondarsi sull’esperienza. Anche B. Spinoza (1632-
1677), pur rimanendo legato al razionalismo, individua un livello superiore di
conoscenza, un nuovo metodo d’indagine: quello dell’intuizione che pensa
tutte le cose “
sub specie aeternitatis
”, ovvero sempre dal punto di vista e in relazio-
ne alla sostanza divina, da cui tutto è generato per necessità.
Ma il grande contestatore del razionalismo “geometrico” cartesiano è B. Pa-
scal (1623-1662), che giudica riduttivo e inadeguato un approccio razionale e
scientifico per indagare aspetti della realtà quali la condizione dell’uomo, il si-
gnificato della sua esistenza, il suo destino, le sue scelte morali e religiose; tutto
ciò è così complesso che non si può ridurre a questioni “geometriche”: per esse
non vale “
l’esprit de géométrie
”, ma “
l’esprit de finesse
”, non la ragione ma il cuore.
Il metodo empirico è anche dell’inglese J. Locke (1632-1704), il quale arriva
a indagare che cosa sia conoscibile realmente da parte dell’uomo. La ragione
scientifica che nella scienza aveva celebrato i suoi trionfi, inizia a riflettere sui
suoi limiti. La ragione non tutto può indagare, la conoscenza razionale è ali-
mentata da quella empirica. Compito del filosofo è scrutare il grado di affida-


















