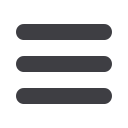

12
Parte Prima
Fondamenti epistemologici e metodologici
www.
edises
.it
Sarà Giovanni Duns Scoto (1265-1308) a ridimensionare il ruolo del metodo
empirico, in quanto ritiene che l’esperienza non produce evidenze o argomen-
tazioni valide, in contrapposizione alla conoscenza intelligibile che “astrae”
(coglie ciò che vi è di comune negli oggetti conosciuti) o “intuisce” la specifici-
tà e l’individualità di ogni cosa.
Ma torna preponderante nel pensiero di Guglielmo di Ockham (1280-1347)
la validità del metodo empirico; la realtà è costituita solo da individui e l’unica
conoscenza possibile è quella empirica, che ci mostra se una data cosa c’è o
non c’è, che rapporto ha con le altre, quale spazio occupa.
2.3
L’età moderna
Il pensiero moderno rielabora in modo radicale i problemi fondamentali della
gnoseologia e focalizza l’attenzione sul soggetto conoscente, fino ad arrivare
con la “rivoluzione copernicana” kantiana all’affermazione secondo cui è l’og-
getto che deve adeguarsi al soggetto.
La svolta in campo gnoseologico è più evidente a partire dal XVI secolo. In
questo periodo il problema del metodo intreccia strettamente la riflessione
filosofica con quella scientifica. Già dalla seconda metà del Cinquecento, la
rivoluzione copernicana scardina le basi dell’astronomia e della fisica aristote-
lica, accrescendo la domanda sia di nuovi strumenti conoscitivi che di metodi
d’indagine.
2.3.1
Il metodo induttivo
Francesco Bacone (1561-1626) è il primo filosofo-scienziato a formulare un
programma di rinnovamento radicale del metodo e delle finalità dell’indagine
scientifica. Bacone pensa che l’“
Organon
” (strumento logico di indagine) ari-
stotelico non sia più valido. Egli chiede innanzitutto una vigilanza critica sui
processi conoscitivi, che liberi lo scienziato da pregiudizi e immagini distorte
della realtà (
idòla
), dovuti ai limiti della natura umana e del linguaggio o all’in-
fluenza delle dottrine tradizionali.
In secondo luogo Bacone propone l’adozione di un metodo rigorosamente
induttivo; egli critica sia il metodo deduttivo, in cui domina il sillogismo ari-
stotelico (che non porta alla conoscenza di nuove verità), sia quello induttivo
adottato dal Rinascimento, giudicato scarsamente fondato e frettoloso, poiché
si limita ad acquisire i fatti osservati senza alcun vaglio critico ed effettua una
generalizzazione immediata dei fatti particolari.
Il metodo di Bacone, basato sia sull’esperienza e sull’osservazione (
videre
), sia
sul ragionamento e sul pensare (
cogitare
), procede gradualmente raccogliendo,
ordinando e sistemando i dati dell’esperienza, poi formula ipotesi da sottopor-
re a verifica, muovendosi “non come le formiche, che si limitano ad accumu-
lare i beni, né come i ragni, che traggono la tela da sé, ma come le api, che
elaborano il polline tratto dai fiori”.


















