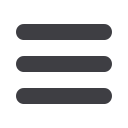

14
Parte Prima
Fondamenti epistemologici e metodologici
www.
edises
.it
bilità che i dati dell’esperienza possiedono, vedere fino a dove essi ci possono
realmente condurre. Il metodo di ricerca della verità empirica di Locke porta
alla conclusione che il nostro sapere si basa solo sulle idee acquisite dall’espe-
rienza o dall’intuizione, ma comunque si tratta sempre di conoscenze “proba-
bili” e mai certe.
Il metodo “empirico-probabilista” del filosofo inglese spinge G.W. Leibniz
(1646-1716) a negare qualsiasi validità all’indagine empirica e ad affermare che
“
nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu nisi ipse intellectus
” (nulla è nell’intel-
letto che non sia stato nel senso se non lo stesso intelletto). Ciò mette in crisi
l’indagine empirica, perché l’intelletto per Leibniz non si limita a rielaborare i
dati forniti dall’esperienza, ma giunge a concetti universali e necessari su cui si
fonda la conoscenza, facendo riferimento a principi originari, innati, presenti
nella mente umana. Ecco perché il filosofo distingue tra “verità di ragione”
(quelle della matematica, della logica, della metafisica)
a priori
, cioè indipen-
denti dall’esperienza, e “verità di fatto”
a posteriori
, che riguardano l’esistenza
delle cose che si basano sul “principio di ragion sufficiente” per connettere
soggetti e predicati diversi (ad esempio capire perché Cesare abbia passato il
Rubicone, senza che il predicato “Rubicone” fosse implicito nel soggetto “Cesa-
re”). Solo Dio può trasformare le verità di fatto in ragione, ma come all’uomo
non è dato conoscere e indagare.
Anche un filosofo italiano, G. Vico (1668-1744), va alla ricerca di un metodo
per indagare la verità e lo trova nella “storia”, nel suo ripetersi ciclico, nelle sue
funzioni conoscitive (senso, fantasia, ragione) da cui dipendono le diverse fasi
della storia stessa (età degli dei, degli eroi, degli uomini). La ragione è il punto
di arrivo dello sviluppo storico, non nella dimensione geometrica cartesiana,
ma storica, capace di cogliere lo svolgimento degli eventi storico-sociali e dello
sviluppo delle nazioni. Unico metodo per indagare la realtà è quello che si
affida alla formula “
verum et factum convertuntur
”(il vero e il fatto si convertono
l’uno nell’altro e si conosce solo ciò che si fa).
2.4
L’età dei Lumi
L’Illuminismo nel 1700 riafferma la centralità del metodo di indagine affidato
alla ragione, ma non a quella seicentesca; la ragione illuministica è analitica,
critica, dubbiosa sul fatto che l’uomo possa giungere a cogliere l’essenza delle
cose. Essa è strumento critico di indagine anche per la società, per la politica,
per la religione, per la morale.
L’empirismo inglese di Locke ancora si farà sentire e influenzerà il pensiero
di G. Berkeley (1685-1753), che arriverà a concludere che “
esse est percipi
” (nes-
suna realtà può avere esistenza al di fuori di una mente che la pensa) e tutto
ciò che percepiamo è particolare e mai generale, fino a negare la realtà della
materia (immaterialismo).
Diverso è l’approccio dell’empirismo di D. Hume (1711-1776), che sembra
rivestirsi di uno scetticismo moderato, ovvero della pretesa di circoscrivere i


















