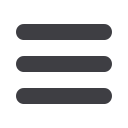

10
Parte Prima
Fondamenti epistemologici e metodologici
www.
edises
.it
non esistono come le chimere. Secondo Gorgia non tutto è relativo e i contrasti
fra opinioni diverse tra uomini si risolvono solo se un’opinione prevale, perché
più forte, più convincente, sulle altre.
Democrito (460-370 a.C.) distingue tra conoscenza sensibile e conoscenza
razionale. Le percezioni sensibili sono il prodotto dell’aggregazione di “ato-
mi” (dal greco
atomos
= non divisibile), che provengono dalle cose e generano
un’immagine che si imprime sui nostri organi di senso. Solo la ragione cono-
sce gli atomi. Questa distinzione ne genera un’altra: ciò che è soggettivo nella
conoscenza (qualità delle cose) e ciò che è oggettivo (proprietà geometriche
degli atomi), visibili solo dalla ragione. La conoscenza, pertanto, non può es-
sere solo empirica, ma scaturisce dall’interazione tra il soggetto che conosce e
l’oggetto conosciuto.
Socrate (470-399 a.C.) rifiuta il relativismo dei sofisti e si pone alla ricerca della
verità attraverso il “dialogo” che aiuta a partorire (arte della
maieutica
) la verità
da dentro se stessi. Il fondamento della conoscenza per il filosofo è dentro
l’uomo: “conosci te stesso” è il motto e il principio ispiratore della ricerca so-
cratica. Il centro dell’uomo è l’anima razionale, non la sensibilità, cui compete
la ricerca di ciò che è universale. Il “dialogo” è il luogo in cui attuare questa
ricerca, una ricerca da riavviare continuamente senza mai accontentarsi delle
conoscenze acquisite.
Anche Platone (428-348 a.C.), discepolo di Socrate, rifiuta il relativismo sofi-
stico, che accusa essere contraddittorio e respinge la teoria di una conoscenza
affidata ai soli sensi. La conoscenza, per essere universalmente valida, deve fon-
darsi su qualcosa di oggettivo, eterno, immateriale, su quelle “idee” che sono
l’essenza della realtà. La conoscenza è conoscenza di idee a cui si giunge me-
diante il ricordo, la “reminiscenza” (
Menone
). Può essere rappresentata da una
linea divisa in quattro parti: le prime due costituiscono la conoscenza sensibile
(impressione sensibile e percezione), le altre due quella intelligibile (scienza
e filosofia). Il passaggio da una linea all’altra che permette di cogliere la vera
essenza delle cose è la “dialettica”.
Aristotele (384-322 a.C.) descrive invece il processo conoscitivo come un per-
corso che dall’esperienza sensibile giunge fino alla conoscenza razionale. Si
parte dalla conoscenza sensibile, dalle immagini, sulle quali opera l’intelletto,
che astrae la forma, l’essenza di esse e si passa all’“atto”, ovvero alla possibilità
di intendere davvero la forma delle cose stesse. Aristotele dedica grande atten-
zione ai procedimenti del pensiero. Egli ne individua due: quello “induttivo”,
che muove da premesse particolari e giunge a conclusioni di valore generale,
ovvero all’universale, alla forma; e quello “deduttivo”, che muove, al contrario,
da premesse generali per ricavare poi conclusioni aventi caratteristiche speci-
fiche.
Il primato della conoscenza sensoriale, negato da Platone e Aristotele, ritorna
nella filosofia ellenistica. Per Epicuro e per lo Stoicismo la sola sensazione è
manifestazione della realtà ed è sempre vera, in quanto immagine mentale di
un’impressione prodotta in noi da una cosa reale. Contro la fiducia epicurea e
stoica verso le rappresentazioni evidenti, lo scetticismo sosterrà che di nessuna


















