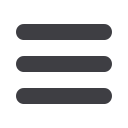

Capitolo 2
La metodologia della ricerca filosofica nelle diverse epoche storiche
11
www.
edises
.it
rappresentazione si può essere certi e di conseguenza bisogna negare l’assenso
e sospendere il giudizio (
epoché
). Anche se qualcuno come Carneade (219-129
a.C.) dirà di affidarsi a quelle rappresentazioni che appaiono più probabili e,
nello stesso periodo, Plotino ripenserà alcuni temi della ricerca filosofica plato-
nica in prospettiva religiosa, come “viaggio dell’anima verso l’Uno”.
2.2
L’età medievale
Plotino apre la strada alla ricerca filosofica cristiana. Il pensiero di Agostino
(354-430) può essere interpretato come un itinerario dell’anima verso Dio.
Punto di avvio della riflessione agostiniana è la critica allo Scetticismo. Se lo
scettico dubita di tutto, non può negare però un fondamento di certezza, quel-
lo che per ingannarsi deve necessariamente esistere (
si fallor sum)
: “se mi ingan-
no, sono”, sostiene Agostino; di tutto posso dubitare, ma non di me che dubito
e se c’è qualcosa di vero, di cui non si può dubitare, allora deve esistere la
verità. Essa va cercata “dentro” l’uomo, è un viaggio alla scoperta interiore di se
stesso che porta l’uomo a cogliere la verità (
“in interiore homine habitat Veritas”
):
l’uomo è illuminato da Dio, affinché possa vedere le Idee, modelli delle cose
presenti nel Verbo divino.
Una questione posta da S. Boezio (480-526) animerà a lungo il dibattito della
filosofia cristiana: il problema degli “universali”, ovvero quale realtà corri-
sponde ai termini universali presenti nei nostri enunciati? Termini come “ani-
male”, “uomo”, ecc. esistono realmente nella mente di Dio o sono solo segni
convenzionali, puri nomi? I realisti (come Anselmo d’Aosta, 1033-1109), so-
stenitori dell’esistenza reale degli universali nella mente di Dio, e i nomina-
listi (come Roscellino, 1050-1120), secondo cui gli universali sono solo
flatus
vocis
, cioè solo segni convenzionali, applicano entrambi un metodo di ricerca
“paradigmatico” della realtà. Tale metodo trova una sua ulteriore applicazio-
ne nel grande filosofo P. Abelardo (1079-1142) che negherà l’esistenza reale
degli universali e affermerà il loro essere “
vox
” riferita a più cose o a qualità
di cose.
Per quel che concerne il ruolo della ragione e dell’esperienza sensibile, nel
XIII secolo si affermano due tendenze, rappresentate da Ruggero Bacone e
Tommaso d’Aquino, che attribuiscono entrambe un ruolo rilevante all’espe-
rienza, riconoscendole però significati diversi.
Ruggero Bacone (1214-1292) distingue l’esperienza “esterna”, che permette la
conoscenza del mondo delle cose, dall’esperienza “interna” che, tramite un’il-
luminazione di tipo mistico, mette in contatto con Dio.
Tommaso d’Aquino (1221-1274) rifiuta l’innatismo platonico e agostiniano e
pone l’esperienza sensibile, perché “
nihil est in intellectu quod prius non fuerit in
sensu
”(niente vi è nell’intelletto che prima non vi sia stato nel senso). La verità
è un adeguarsi dell’intelletto alla realtà (
adaequatio rei et intellectus
): torna così
la concezione della conoscenza come processo in cui il soggetto si fa simile a
ciò che conosce.


















