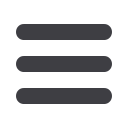

Lo sviluppo professionale dei docenti
4
molti relatori hanno tenuto a precisare, tutti questi studiosi sono definiti-
vamente giunti a ritenere che vi sia una causazione reciproca tra azione e
struttura e, pertanto, le due dimensioni si condizionerebbero a vicenda.
In linea con tali approcci, il fattore distintivo dell’agentività è dato dall’in-
tenzionalità, dalla propria percezione di efficacia, dalla capacità di formu-
lare possibilità per l’azione, di considerare attivamente tali opportunità e
di esercitare la scelta, coinvolgendo dispositivi simbolici e materiali che in-
fluenzano il comportamento umano e che, a loro volta, ne sono influenzati.
Quindi, agentività non più come capacità degli attori, bensì come “com-
petenza” acquisibile nel gioco delle interazioni con i contesti a cui, con-
seguentemente, è attribuito un ruolo fondamentale nel rendere i soggetti
competenti o meno nell’esercizio di tale competenza. In questo scenario di
reciproche influenze, infatti, la competenza assume una funzione
interpre-
tativa
rispetto alla dimensione contestuale a cui attribuire senso (Pellerey,
2011), mobilitando la percezione delle proprie capacità, gli atteggiamenti,
le credenze, il “controllo comportamentale percepito” come elementi pre-
dittivi dell’intenzione ad agire (Ajzen, 1988).
Confortati, dunque, anche dalla teoria transazionale di John Dewey (1960),
dalla teoria socio-cognitiva di Albert Bandura (1986), dall’interazionismo
simbolico di George Herbert Mead (1934), successivamente ripreso da Er-
ving Goffman (2005), nonché dagli studi neuroscientifici sui meccanismi
di percezione e di azione che sottolineano il carattere “incarnato” e “si-
tuato” della cognizione, ci si è soffermati a ragionare di
teacher agency
per
evidenziare il gioco delle mutue influenze tra culture, strutture e agire dei
soggetti coinvolti nei processi formativi ed educativi.
L’approccio interdisciplinare e internazionale al tema oggetto delle due
giornate di studio ha restituito appieno la molteplicità dei modi di inten-
dere l’agentività
,
la cui complessità renderebbe improduttivo qualsiasi ten-
tativo riduzionista di collocarla nell’alveo di uno specifico settore discipli-
nare e/o in un confine geografico ristretto, soprattutto quando essa si con-
nette al tema dell’inclusione scolastica, alle sue varie concettualizzazioni e
alle forme che ha assunto in differenti Paesi.
A tale proposito, è importante sottolineare che, già sul finire del secolo
scorso, Dyson (1999) parlava di
Inclusions
piuttosto che di
Inclusion
, sotto-
lineando la natura storico-culturale di tale costrutto (Vaughn & Schumm,
1995; Hornby, 1999), resa evidente anche dalle sue plurime definizioni che
si moltiplicano in ragione della varietà di interpretazioni in riferimento a
differenti modelli teorici e culturali.
Su queste premesse si è sviluppata l’idea di un progetto che ha assunto pro-
gressivamente concretezza nel dialogo con i colleghi di università straniere
nell’ottica di realizzare una rete di accordi interuniversitari nel corso delle
Conferenze promosse dalla
European Educational Research Association
e che si
















