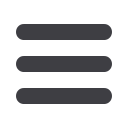

3
Introduzione
di
Paola Aiello, Università degli Studi di Salerno
La proposta di ragionare di agentività e di sviluppo professionale dei do-
centi, nel corso delle Giornate di Studio salernitane, è nata dalla convin-
zione che, per ripensare la scuola alla luce del recente dettato normativo,
occorra, tra l’altro, un’approfondita riflessione critica sul ruolo degli inse-
gnanti nel generale processo di cambiamento, prefigurando modelli edu-
cativi e strategie di azione responsabili e consapevoli dei mutati scenari di
senso della complessa società contemporanea.
Perché l’agentività (
agency
nella traduzione inglese)?
L’agentività è stato il pretesto, in quanto lemma e concetto che si connette
all’agire umano, in cui si intrecciano capacità di giudizio e di discrezio-
nalità delle scelte nel perseguire l’intenzionalità di un progetto educativo,
grazie alle risorse messe a disposizione dal contesto e in un gioco di
affor-
dances
e di vincoli sociali e culturali.
Puntare all’agentività del docente suggerisce, infatti, non solo di guardare
alla dimensione strutturale in cui si realizza l’agire educativo-didattico, alle
culture che modellano le pratiche, alle attività e alla capacità individuale,
bensì di recuperare il potenziale dell’azione professionale (individuale e col-
lettivo) dei docenti e di considerare come quest’ultimo possa tradursi in atto.
Dunque, agentività in una prospettiva ecologica (Emirbayer & Mische,
1998) e, pertanto, non come “attribuzione ontologica” all’insegnante, ma,
piuttosto, come fattore del più ampio sistema di relazioni in cui si rende
possibile l’agire educativo e didattico.
Quest’ultima posizione, che risolve definitivamente l’antinomia azione-
struttura in uno spazio interumano, dove assumono senso il dialogo e l’a-
gire, ha enfatizzato l’importanza sia della capacità individuale che delle
dimensioni contestuali nel dar forma all’agentività. Pertanto, sono stati va-
licati i confini rigidi di orientamenti culturali che per lungo tempo hanno
contrapposto “azione” e “struttura”, considerandole due entità separate e
autonome e attribuendo all’una o all’altra categoria concettuale diversi li-
velli di importanza nel plasmare la realtà sociale.
Il dibattito è stato particolarmente vivo e ha assunto valore nelle elabora-
zioni teoriche di ambito sociologico della seconda metà del secolo scorso,
Pierre Bourdieu (1977 – con la teorizzazione del concetto di “habitus”),
Anthony Giddens (1984 con la
Theory of structuration
), Margareth Archer
(1995 – con la
Realist social theory
e con le
Relational theories of agency
); come
















