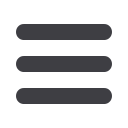

www.
edises
.it
Musicoterapia e didattica
181
In generale, l’ascolto della musica produce tre tipi di effetti:
1. sulla regione sinistra di Wernicke, e quindi sull’attività lingui-
stica e logica;
2. sulla corteccia presilviana, e quindi su alcune attività motorie,
come ad esempio il movimento della mano per i musicisti, ma
anche di tutto il corpo per i ballerini;
3. sulle regioni e sulle funzioni della corteccia limbica (sentimen-
ti elementari) e di qui all’ipotalamo, con risultato misurabile
sulle funzioni dell’omeostasi (pressione arteriosa) e del con-
trollo dell’immunità.
È possibile affermare, quindi, che l’ascolto e la memorizzazione
della musica comportano:
>
>
una
facilitazione all’apprendimento
, in particolare all’apprendi-
mento delle lingue, al rinforzo della memoria “ripetitiva” (can-
zoni piuttosto che poesie) e allo sviluppo dell’attività motoria
armonica;
>
>
un
coinvolgimento a livello emotivo
a cui vanno correlati effetti
sul comportamento, che sarà aggressivo nel caso si tratti di mu-
sica “dionisiaca” o sociale se “apollinea”;
>
>
un
effetto distensivo gratificante e analgesico
, mediato dalle en-
dorfine;
>
>
un
effetto neurovegetativo mediato dal vago
;
>
>
un
effetto ormonale
(vasopressina, ossitocina).
1.1.3
L’apprendimento attivo della musica
Nel gioco dell’apprendimento una funzione molto rilevante è svol-
ta dai
neuroni specchio
. Essi entrano in funzione quando si osserva
una determinata azione e rispondono selettivamente agli atti com-
piuti dall’individuo che stiamo osservando. Entrano in azione,
però, anche quando ripetiamo quell’azione che abbiamo prece-
dentemente osservato o quando, nella nostra mente, immaginia-
mo di ripeterla. Il sistema dei neuroni specchio, allora, può essere
collocato alla base della comprensione del significato delle azioni
delle persone con cui interagiamo, ma anche
alla base dell’ap-
prendimento per imitazione
, che riguarda sia l’attività motoria
fine (mano-bocca) che le sensazioni di disgusto-rifiuto-approvazio-
ne e di dolore-sofferenza.
















