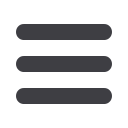

www.
edises
.it
180
Appendice
cervello assolutamente specializzata in tale operazione, come av-
viene invece per il linguaggio parlato, piuttosto entrambi gli emi-
sferi giocano in questo senso un ruolo fondamentale. Sebbene,
poi, questo sia oggetto di controversie, è possibile affermare che
sicuramente in questa attività di decodifica il
planum temporale
de-
stro è più coinvolto di quello sinistro. Tali considerazioni sono sup-
portate da una serie di osservazioni cliniche da cui è emerso che
musicisti divenuti afasici in seguito a lesioni ischemiche all’emisfe-
ro di sinistra hanno conservato perfettamente tutte le funzioni
musicali, mentre al contrario un direttore di coro è divenuto total-
mente amusico (stonato) a causa di una lesione ischemica localiz-
zata all’emisfero destro. Il blocco dell’emisfero destro non causa
problemi alla capacità di parlare, ma inibisce completamente quel-
la di cantare.
Il coinvolgimento delle due aree associative (destra e sinistra) nel-
la decodifica del linguaggio musicale è diverso a seconda del tipo
di musica (che può essere familiare o esotica, facile o difficile) e
del tipo di ascolto (ingenuo o esperto, attivo o passivo). Questo
perché tra linguaggio parlato e linguaggio musicale esiste una na-
turale e complessa interazione: nel linguaggio parlato vi è una
componente musicale, esaltata grazie alla poesia, e nel canto (che
è naturalmente poetico) il messaggio musicale è arricchito e rin-
forzato dalle parole.
Il viaggio dell’ascolto non si ferma all’area acustica primaria e as-
sociativa e questo lo possiamo vedere non solo grazie allo studio
degli effetti periferici neurovegetativi (pressione arteriosa, con-
centrazione di sodio nel sudore) ma anche grazie alla valutazione
obiettiva dei comportamenti associati all’ascolto. L’osservazione è
particolarmente interessante e si differenzia a seconda che l’ascol-
tatore sia “ingenuo” (cioè non educato alla musica) o “educato”
all’ascolto. Anche il tipo di musica ascoltata favorisce questo o quel
comportamento, a seconda che essa sia tonale o atonale, occiden-
tale o orientale, dissonante o consonante. In ogni caso, possiamo
dire che una musica a noi familiare attiva principalmente le aree
corticali non uditive di sinistra (parietali e motorie); una musica
non familiare, invece, attiva le aree corticali non uditive di destra
(prefrontali e parietali). I musicisti, infine, sviluppano capacità co-
gnitive e motorie evocate dalla musica superiori a quelle degli
ascoltatori passivi, e cioè coloro che subiscono solo l’ascolto musi-
cale.
















