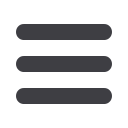
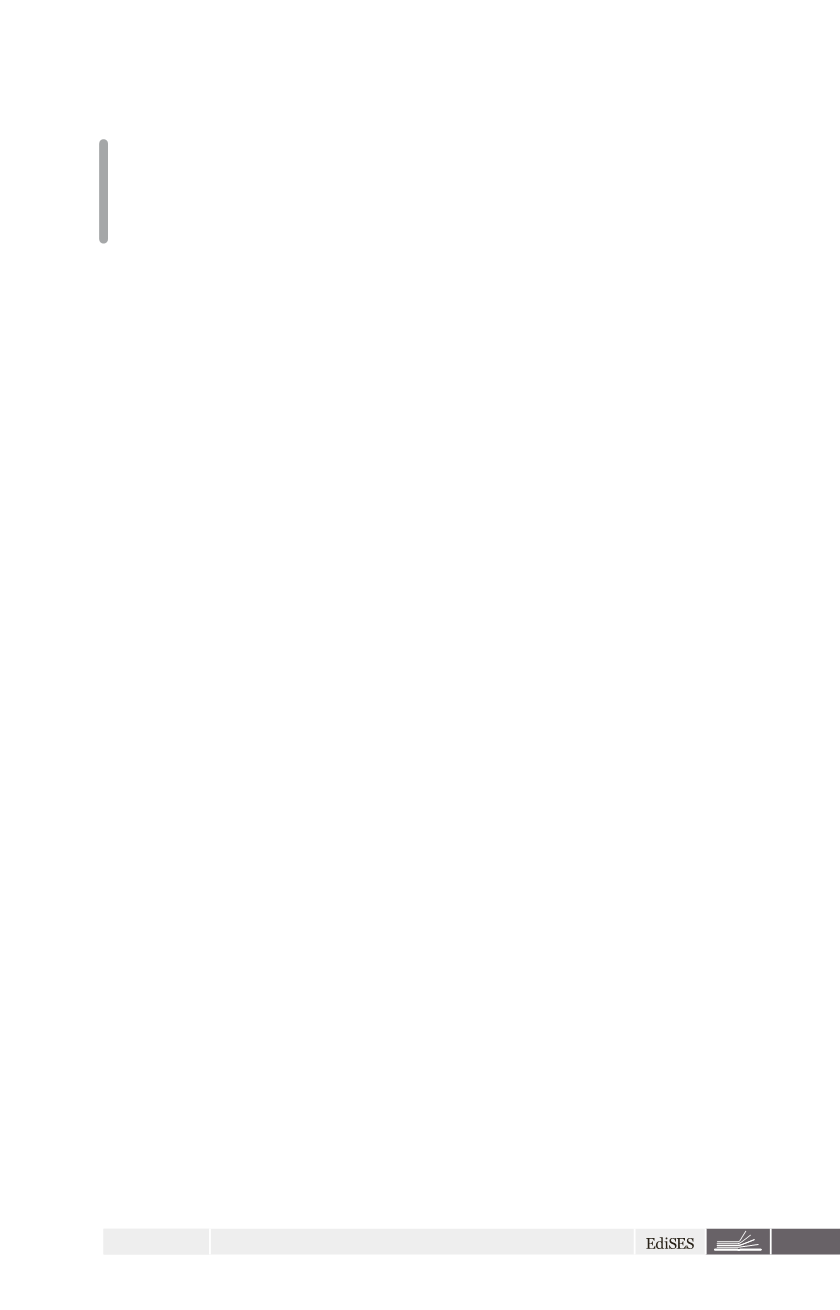
www.
edises
.it
Musicoterapia e didattica
di Claudia De Simone
1.1
Musica: aspetti comunicativi e neurofisiologici
Prima di addentrarci nella valenza terapeutica dell’ascolto e del
fare musica, si illustreranno dal punto di vista neurologico le rispo-
ste che il nostro cervello restituisce in seguito allo stimolo musica-
le. Tale introduzione sarà utile a capire come mai la pratica della
musicoterapia si adatti perfettamente ai bisogni di tutti gli alunni
presenti nelle nostre classi e non solo ai diversamente abili.
1.1.1
Il linguaggio musica
Innanzitutto, è necessario precisare che
la musica è un linguaggio
ben codificato
: ha un suo sistema di scrittura, delle leggi che lo re-
golano, dei tempi da rispettare e una sua forma. In quanto linguag-
gio, il suo fine ultimo è quello di veicolare un significato. I singoli
suoni che vengono emessi e ricevuti dall’uomo arrivano alla cortec-
cia cerebrale, vengono letti e decodificati. Tale decodifica produce
effetti di tipo emotivo (sia emozione estetica che primordiale, come
aggressione, eccitazione, paura, rilassamento), motorio (danza) e
cognitivo (lettura testuale).
Fin dalla sua nascita, la
neuroscienza
si è concentrata sul processo
che consente l’elaborazione degli stimoli sonori e la loro trasfor-
mazione in messaggio coerente e significativo e alle conseguenze
biologiche, per lo più inconsapevoli, che l’interpretazione di que-
sto messaggio comporta per l’ascoltatore. C’è da dire, però, che
mentre per il linguaggio parlato tali conseguenze sono più facil-
mente individuabili, nel caso del linguaggio veicolato dalle arti
(musica, pittura, scultura) il percorso non è poi tanto semplice.
Il linguaggio verbale, infatti, è indirizzato alla parte consapevole del
nostro cervello che si esprime con la parola, la quale, quindi, fa da
mediatrice tra noi e gli altri. Il linguaggio musicale è finalizzato,
















