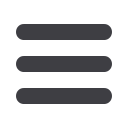

Capitolo 3
]ůœůÂä÷ÂŬÂŬů¦Ę÷¦òÂŬĺÂœŬſĘŬĺĺœÂʶ÷ĒÂĘůģŬÂØÙ¦¦Â
685
www.
edises
.it
duo all’interno dell’ambiente di gruppo avverte una sensazione, in forza della quale
attiva una reazione, che può divenire un momento di apprendimento, di crescita, di
mutamento. Tutto ruota attorno al rapporto fra le dinamiche, le interpretazioni e i
bisogni del gruppo. Si genera in tal modo un clima sociale, in grado di modicare
il comportamento dei singoli, quando, negli stessi, si attiva la sensazione di condi-
videre il medesimo “destino”; ne nasce, pertanto, un arricchimento reciproco, che
scaturisce dall’assumere un atteggiamento
democrative
, ottenuto cioè dal rapporto
democratico fra i componenti, dall’utilizzo e dal rispetto di norme sociali e di regole
dettate dal gruppo.
Teoria del contatto di Gordon Allport
: secondo cui, grazie alle interazioni fra i com-
ponenti del gruppo, si attivano contatti e relazioni positive.
Teoria dell’apprendimento centrato sulla persona di Carl Ramson Rogers
: dove il
“mettersi nei panni dell’altro”, senza dimenticare di essere se stessi, genera empatia
e accettazione non giudicante, atteggiamenti che permettono di accettare l’altro,
benché presenti valori e comportamenti diversi dai nostri.
Teoria di Lev S. Vygotskij
: relativa alla zona di sviluppo prossimale, può rivolgersi a
diversi contesti e forme di organizzazione dei soggetti, dalla scuola per i bambini al
gruppo di lavoro per gli adulti. Il processo di apprendimento non è considerato come
un’attività individuale, ma è possibile solo grazie all’interazione e al confronto con
gli altri, a qualsiasi livello. L’approccio di Vygotskij si discosta da quello piagetiano,
secondo cui lo sviluppo cognitivo del bambino deve attraversare diversi stadi prima
che il soggetto possa maturare e formare le proprie conoscenze.
Teorie del costruttivismo sociale
: a partire dalle conoscenze già possedute da cia-
scuno nel gruppo, le nuove conoscenze si costruiscono e si sviluppano in modo so-
ciale, attraverso un’osservazione ragionata di eventi e una rielaborazione comune.
Pertanto, la costruzione di nuova conoscenza è il frutto di un processo dinamico
generato dalla competizione intellettuale.
Teorie motivazionali:
se un individuo può ottenere singolarmente risultati positivi,
tanto più l’interazione e l’interdipendenza fra soggetti determinano risultati e con-
clusioni superiori rispetto a quelli conseguiti dal singolo; infatti, per un soggetto sono
altamente motivanti elementi come l’incontro, lo scambio e la relazione con gli altri,
perché permettono di ampliare e valorizzare la conoscenza di se stessi, delle proprie
capacità e, di conseguenza, di accrescere il desiderio di apprendimento ricavandone
un’enorme graticazione. In sintonia con il gruppo d’appartenenza, ogni esito positi-
vo del singolo determina un successo anche per il
team
; grazie a un comportamento in-
trinsecamente motivato, cioè interiorizzato, si innesca l’atteggiamento “protosociale”,
che soddisfa il bisogno individuale sia di stare con gli altri sia di conseguire il successo,
vale a dire il riconoscimento sociale che consegue all’applicazione, all’impegno, al
sacricio personale, che il singolo è disposto a mettere in campo nei processi inter-
personali e nella motivazione ad apprendere. I membri del gruppo cercano di aiutarsi
e di incoraggiarsi per raggiungere gli obiettivi, perché il risultato del gruppo vale più
della somma dei singoli elementi e, se vince uno, vincono tutti.
Tipico
esempio di modello collaborativo
è quello che si realizza sul web mediante le
piattaforme digitali
, in cui i partecipanti ai
focus group
possono mettersi in contatto
e “collaborare” per approfondire un argomento, fornire ed elaborare dati, discute-
















