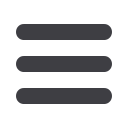
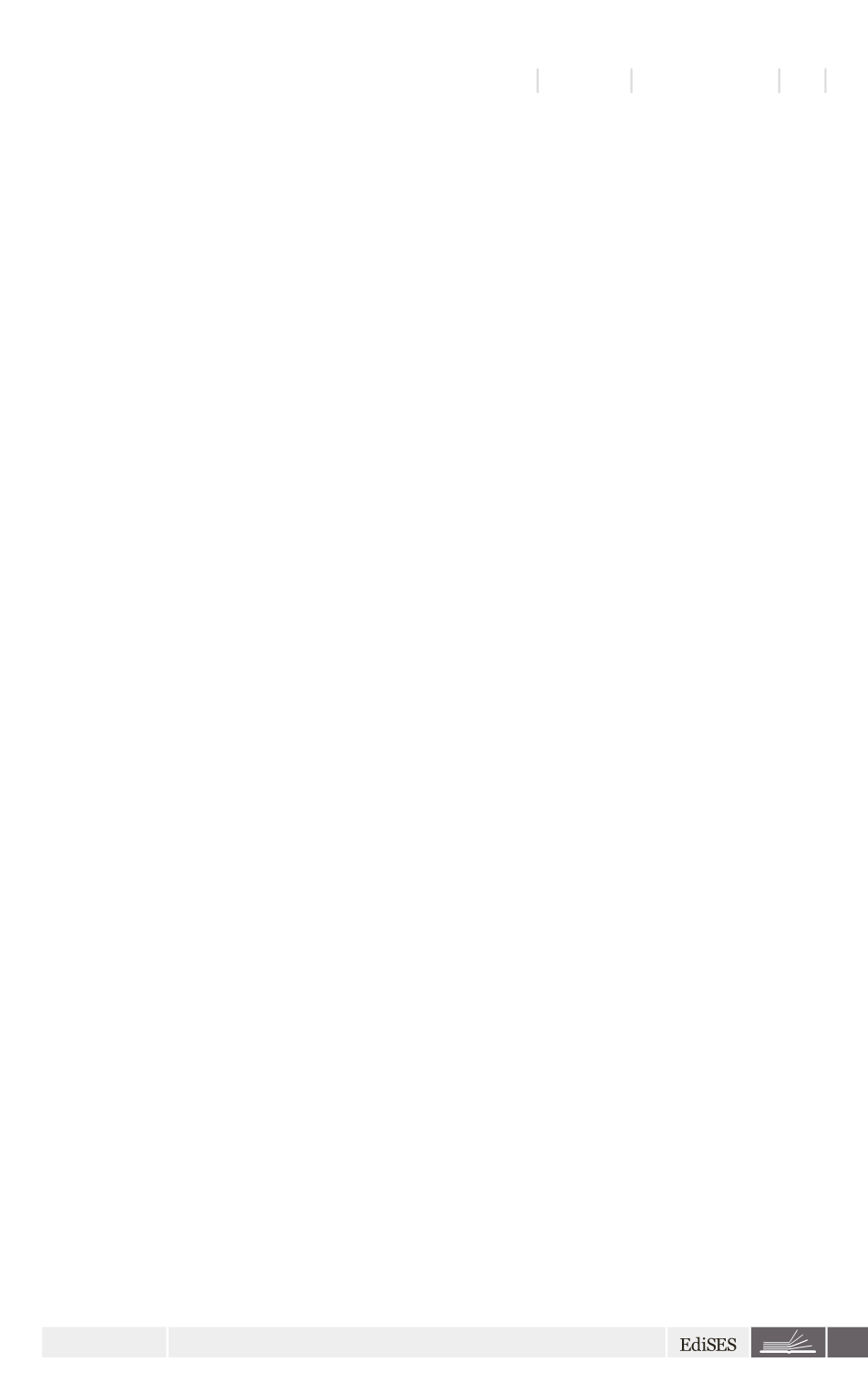
Capitolo 11
La scuola inclusiva
253
www.
edises
.it
Sempre nelle parole di Dario Ianes, la scuola italiana ha fatto suo il principio del-
l’“educazione per tutti”, che sta alla base del modello educativo inclusivo, espresso
per la prima volta nella Dichiarazione di Salamanca del 1994, ma lo sta traducendo
in atto per gradi. Il primo passo si è avuto con la legge n. 170 del 2010, rivolta agli
alunni con DSA. Con la Direttiva del MIUR del 27/12/2012, l’educazione inclusiva
viene estesa ad altre categorie di BES, con particolare riferimento ai DDAI e agli
alunni stranieri. Inne, con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 la normativa in
materia di inclusione scolastica è stata riordinata e semplicata. Di fatto, quindi, la
via italiana dell’inclusione si sta attuando attraverso un processo graduale nalizzato
ad includere tutti. Ianes sottolinea il
rischio di microesclusione
, che è sempre in
agguato e che esiste a prescindere dall’esistenza o meno di leggi inclusive. Si parla di
microesclusioni associate ai fenomeni di bullismo, di quelle rivolte ai/alle ragazzi/e
omosessuali, agli stranieri, ma anche delle microesclusioni attivate dai docenti stessi
che, non avendo le competenze per intervenire adeguatamente nella gestione dei
BES, tendono ad isolare gli alunni difcili. Inutile dire, continua Ianes, che il rischio
di esclusione può essere combattuto soltanto se il corpo docente tutto si fa carico del
riconoscimento di situazioni di problematicità e si attrezza con le dovute competenze
psico-pedagogiche. In termini pratici, in classe diventa fondamentale adattare a tutti
i materiali e i testi, avvalersi di strategie di insegnamento/apprendimento incentrate
sul
cooperative learning
, sul
tutoring
, sulla didattica laboratoriale e sull’uso inclusivo
delle nuove tecnologie. L’istituzione di un
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
(GLI) non
deve servire semplicemente a raccogliere le varie programmazioni inclusive prodotte
dai consigli di classe nella forma del PDP (Piano Didattico Personalizzato) e del PEI
(Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con sostegno, per costruire il
Piano
Annuale dell’Inclusione
(PAI), ma deve essere nalizzata all’attivazione di procui con-
tatti con il CTS (Centro Territoriale di Supporto), nell’ottica del confronto e di una
crescita formativa unanime e globale. Ultimo ostacolo, ma non in ordine di impor-
tanza, alla realizzazione di una scuola inclusiva resta l’elevata numerosità delle classi,
che di fatto impedisce la presa in carico da parte dei docenti di relazioni educative
centrate sugli alunni.
11.1.3
Relazione tra Bisogni Educativi Speciali e “ostacoli
all’apprendimento e alla partecipazione”
L’
Index for inclusion
(United Kingdom, 2002) propone il superamento del concetto di
Bisogni Educativi Speciali e la sua sostituzione con il concetto di ostacoli all’appren-
dimento e alla partecipazione.
Secondo il documento anglosassone, la denizione di “Bisogni Educativi Speciali”
deriva dal paradigma bio-medico che considera i limiti dell’apprendimento un de-
cit dell’individuo.
Il modello bio-psico-sociale, a cui fa riferimento l’
Index for inclusion
, invece, inter-
preta la difcoltà anche come il risultato dell’interazione tra soggetto e contesto. In
sostanza, secondo questa visione, modicando opportunamente il contesto è possi-
bile ridurre in maniera considerevole le difcoltà di apprendimento, le quali non
sono più insite soltanto nel soggetto che apprende, ma anche derivanti dal contesto
















