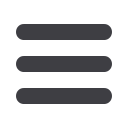

254
Parte Prima
Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
www.
edises
.it
in cui egli apprende. È questa la ragione per la quale non si parla né di decit né
di difcoltà né di disturbo di apprendimento, ma piuttosto di
“ostacoli”
. I termini
“decit”, “difcoltà”, “disturbo” sono accomunati dal fatto di indicare limiti innati
del soggetto, mentre il termine “ostacolo” esprime di per sé un qualcosa che si pone
al di fuori del soggetto, perciò nel contesto, e che gli impedisce di attivare opportu-
namente il processo di apprendimento. In sostanza, i contesti in cui “normalmente”
si insegna sono calibrati sui bisogni educativi della maggioranza e non sui bisogni
delle minoranze.
La dizione “Bisogni Educativi Speciali” viene adoperata per la prima volta nel rap-
porto Warnock in Inghilterra nel 1978, con lo scopo di abolire il termine “handicap”.
Nel 2000, l’UNESCO raccomanda di sostituirla con la dizione “Educazione per tutti”
(
Education for all
), in quanto essa non aveva di fatto contribuito ad evitare sterili sepa-
razioni tra alunni “normodotati” e alunni “non normodotati”.
L’
Index for inclusion
, in linea con le indicazioni dell’UNESCO del 2000, propone
l’introduzione dell’espressione “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”,
con il ne di modicare le modalità di gestione delle difcoltà ad apprendere e i
soggetti in esse coinvolti. L’obiettivo consiste, da un lato, nel rendere responsabile
e attivare l’intera comunità educante, dall’altro, nell’attivare percorsi individualiz-
zati, che tengano conto dei
disagi di ogni natura, anche temporanei
, di tutti gli
studenti. In quest’ottica, la dicotomia tra disabili e normodotati decade, come pure
la distinzione tra insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, e ciò spiega la
ragione per cui l’
Index for inclusion
si aggancia all’“Educazione per tutti” promossa
dall’UNESCO, inserendosi nella transizione culturale che segna il passaggio dalla
pedagogia dell’integrazione alla buona pedagogia inclusiva (
Good Inclusive Educa-
tion
). Questo passaggio determina un cambiamento della formazione globale degli
insegnanti curricolari e degli insegnanti di sostegno, in quanto entrambe le cate-
gorie professionali sono chiamate ad occuparsi delle esigenze di tutti, a collaborare
in rete, in modo integrato e ad acquisire le competenze necessarie per intervenire
adeguatamente.
Cambia, in sostanza, l’angolo di prospettiva dal quale si guarda alle difcoltà di ap-
prendimento. Non si parla più di bisogni, ma di
diritti
, o meglio, del bisogno di avere
assicurati i diritti di crescere, di imparare, di essere amati dalla famiglia e dalla co-
munità, di essere ben accetti dal contesto di appartenenza. Sta alla comunità educan-
te trovare i mezzi per
assicurare a tutti i diritti riconosciuti a livello internazionale
.
In quest’ottica, i bisogni dei bambini e dei ragazzi con difcoltà di apprendimento
non sono speciali, ma sono gli stessi di tutti i bambini e i ragazzi del mondo. Ciò che
cambia sono le modalità per assicurarglieli.
I diritti fondamentali dei bambini inglobano bisogni primari e non (alimentarsi,
curarsi, nutrirsi, giocare, ecc.) e le libertà.
Le posizioni dell’
Index for inclusion
sono state in parte recepite dal sistema d’istruzio-
ne italiano, che attualmente si muove nella direzione:
>
della professionalizzazione di tutti i docenti cosiddetti “curricolari”;
>
dell’estensione di percorsi individualizzati a tutti;
>
del superamento della didattica speciale a vantaggio di quella inclusiva.
















