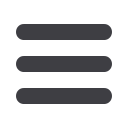
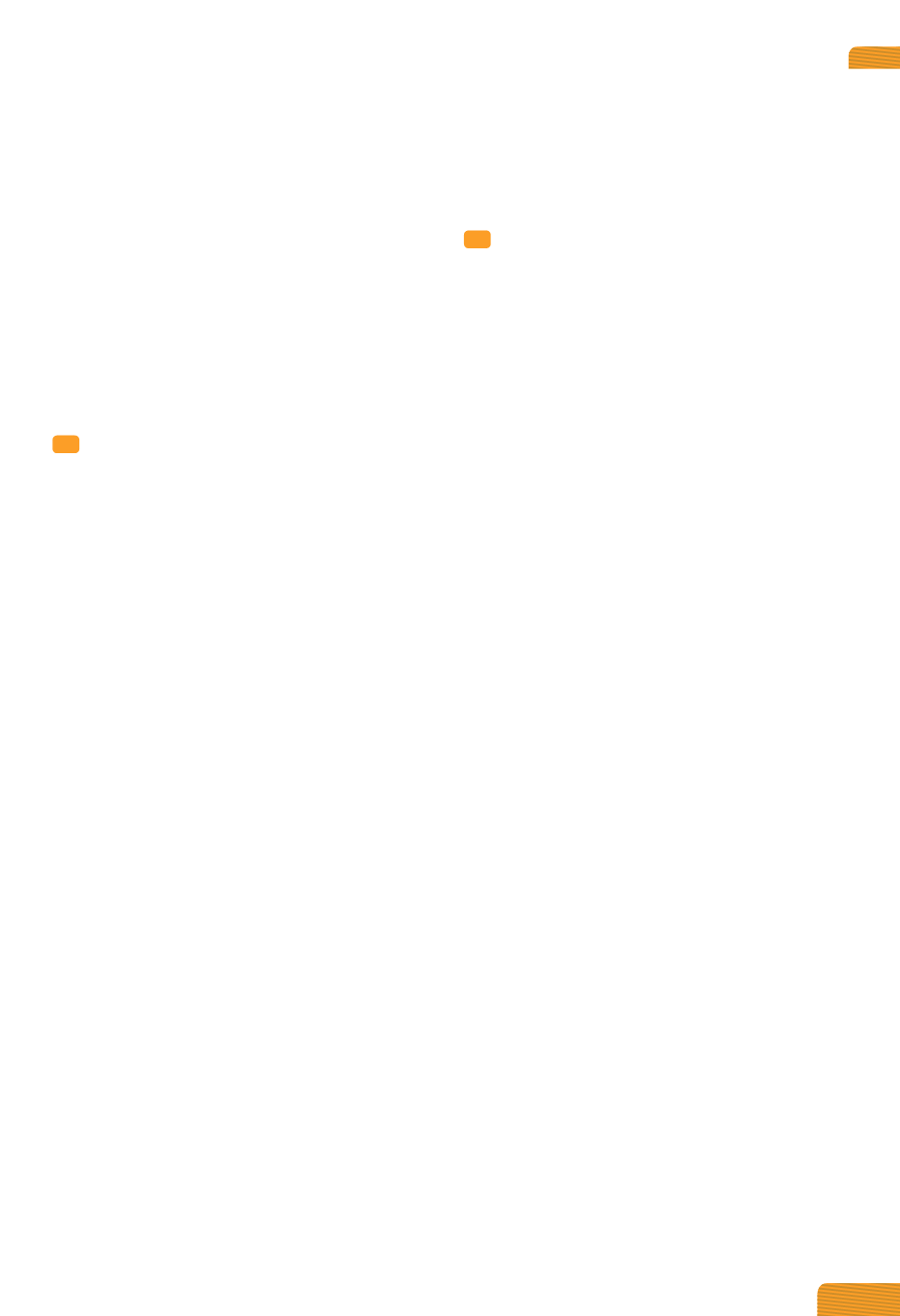
4.1
Trasmissione sinaptica
73
hanno reso possibili i suoi studi n dallamessa a punto
dei primi metodi di indagine morfologici ed elettro-
siologici. In particolare, gli studi eettuati durante
la seconda metà del XX secolo sulla giunzione neuro-
muscolare di rana hanno chiarito importanti aspetti
della trasmissione sinaptica chimica del sistema ner-
voso periferico e costituiscono ancora oggi le basi per lo
studio delle sinapsi più complesse del sistema nervoso
centrale, solo recentemente accessibili sperimental-
mente grazie alla disponibilità di tecniche ottiche ed
elettrosiologiche più sosticate. I meccanismi cellu-
lari riferiti alla sinapsi neuromuscolare illustrati nei
paragra successivi sono quindi da considerarsi validi,
in linea generale, per tutti i tipi di sinapsi chimiche
dirette.
MISURA DEL POTENZIALE
POSTSINAPTICO E SUE PROPRIETÀ
ELETTRICHE
Come si è detto, la giunzione neuromuscolare è una
sinapsi eccitatoria. Pertanto, la liberazione del neuro-
trasmettitore ACh genera un potenziale postsinaptico
misurabile come una depolarizzazione transiente della
membrana postsinaptica, tipicamente di ampiezza pari
a 50-70 mV e della durata di qualche ms.
A Paul Fatt e Bernard Katz va il merito di aver caratte-
rizzato le basi ioniche del potenziale postsinaptico della
giunzione neuromuscolare, o
potenziale di placca
. I
due ricercatori per primi misurarono il potenziale di
placca mediante registrazioni elettrosiologiche intra-
cellulari dopo aver trattato il muscolo con dosi variabili
di curaro. Il curaro è una miscela di tossine d’origine
vegetale (estraibile dalla corteccia di liane appartenenti
al genere
Strychnos
e da
Chondrodendron tometosum
).
Esso inibisce la trasmissione del segnale nella giunzione
neuromuscolare bloccando i recettori-canali per l’ACh
presenti sulla supercie delle bre muscolari (gli indi-
geni dell’America Latina lo impiegano per avvelenare le
punte delle frecce che usano per cacciare le prede che,
paralizzate, muoiono per blocco respiratorio).
Utilizzando basse concentrazioni di curaro, Fatt e
Katz riuscirono a diminuire l’ampiezza del potenziale
postsinaptico al di sotto della soglia di generazione
del potenziale d’azione e poterono quindi registrare il
potenziale postsinaptico che è normalmente masche-
rato dal potenziale d’azione generato dalla cellula
muscolare scheletrica. Posizionando l’elettrodo in
regioni via via più lontane dalla regione in cui il moto-
neurone è a contatto con la bra muscolare, essi osser-
varono anche che il potenziale locale raggiungeva il
picco massimo a livello della regione giunzionale della
bra muscolare per poi decadere man mano che ci si
allontanava da tale zona. In questo modo dimostra-
rono che il potenziale postsinaptico è un potenziale
locale che si propaga elettrotonicamente in modo pas-
sivo (
Fig. 4.11
). Sulla base di queste osservazioni, i due
ricercatori furono i primi a ipotizzare che il potenziale
postsinaptico è originato da un "usso di cariche loca-
lizzato nella regione giunzionale.
IPOTESI DEL RILASCIO QUANTALE DEL
NEUROTRASMETTITORE
Questa teoria fu proposta da Paul Fatt e da Bernard
Katz ancora una volta sulla base dei risultati ottenuti
registrando l’attività elettrica della cellula musco-
lare scheletrica di rana. In condizioni di riposo, i due
scienziati osservarono che la membrana della cellula
muscolare presentava piccole depolarizzazioni sponta-
nee di ampiezza costante (circa 0,5-1mV;
Fig. 4.12
). Tali
depolarizzazioni scomparivano in presenza di curaro
e avevano un andamento temporale simile a quello del
potenziale postsinaptico (
end-plate potential, epp
). Per
la ridotta ampiezza e per le proprietà farmacologiche e
cinetiche, Fatt e Katz chiamarono gli eventi spontanei
potenziali di placca inminiatura
(miniature end-plate
potentials, mepps)
. A questa prima osservazione spe-
rimentale se ne aggiunsero altre. Inducendo la libera-
zione di neurotrasmettitore dalla terminazione nervosa,
José del Castillo, Bernard Katz e Ricardo Miledi osser-
varono una progressiva diminuzione dell’ampiezza del
potenziale postsinaptico se la concentrazione del Ca
2+
extracellulare veniva diminuita (Ca
2+
-dipendenza della
trasmissione sinaptica) e che, in tali condizioni speri-
mentali, gli eventi postsinaptici apprezzabili più piccoli
erano proprio i mepps, i potenziali di placca in minia-
tura. Inoltre, si osservò che la variazione in ampiezza
del potenziale postsinaptico evocato era graduale e che
ogni variazione era sempre unmultiplo intero dell’am-
piezza dei mepps (
Fig. 4.13
). Oltre a questi risultati, le
prime osservazioni della giunzione neuromuscolare
con il microscopio elettronico permisero di dimostrare
la presenza di gruppi di vescicole a livello della termina-
zione nervosa. Del Castillo, Katz e Miledi formularono
quindi l’ipotesi che la liberazione di ACh nella fessura
sinaptica corrispondeva alla liberazione contempora-
nea di pacchetti di denite quantità di neurotrasmet-
titore, i
quanti
, e che un “quanto” corrispondeva alla
quantità di neurotrasmettitore contenuta in una singola
vescicola sinaptica.
La teoria del rilascio quantale (o vescicolare) del
neurotrasmettitore nella giunzione neuromuscolare
è accettata tuttora. Si ritiene che l’arrivo di un poten-
ziale d’azione è causa dell’esocitosi contemporanea di
circa 100-200 vescicole sinaptiche o quanti e che ogni
quanto contiene circa 5000-7000 molecole di neuro-
trasmettitore.
La trasmissione di tipo quantale è stata dimostrata
anche per lamaggior parte delle altre sinapsi chimiche.
















