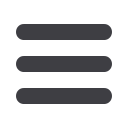
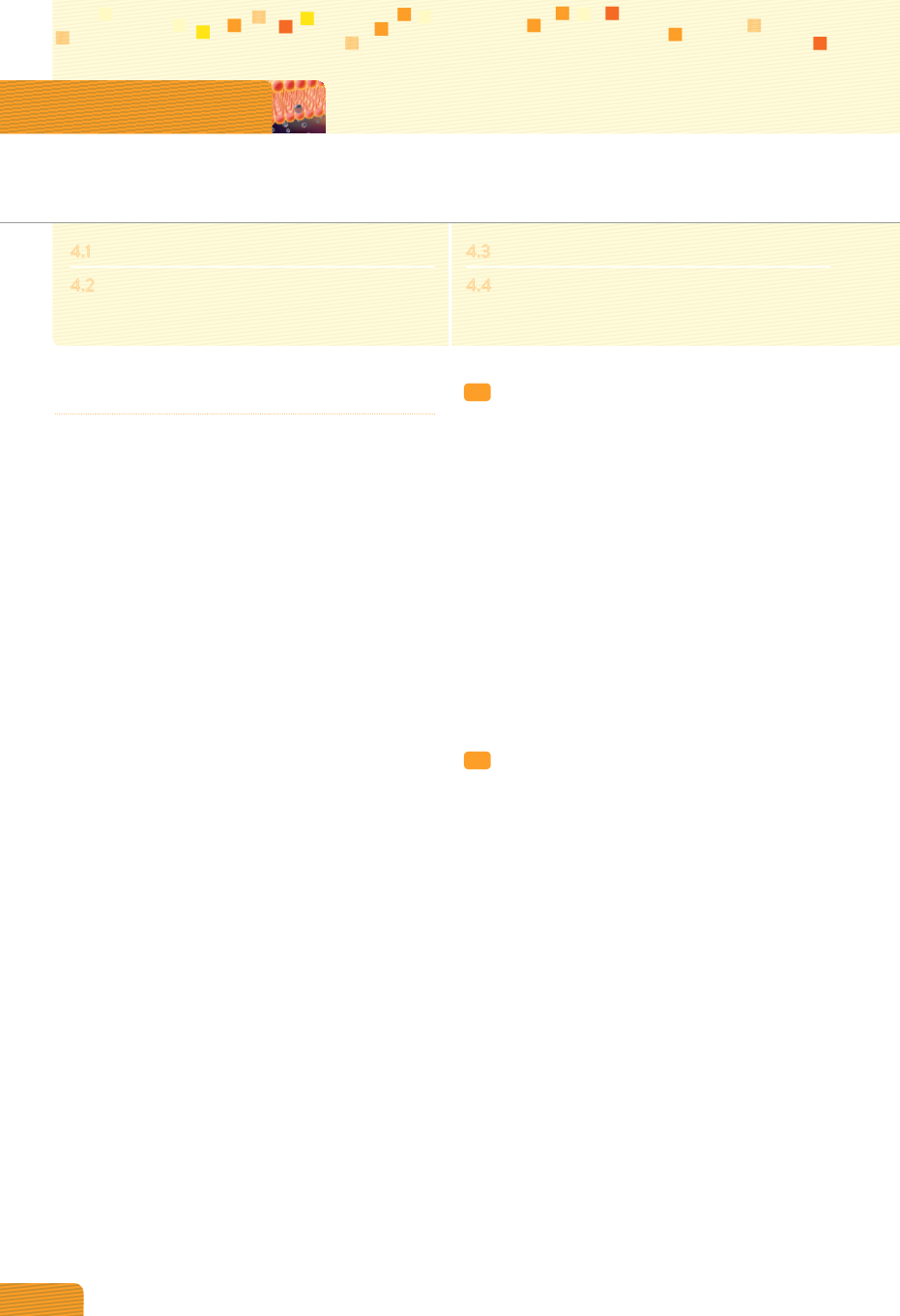
64
4.1
Trasmissione sinaptica
4.2
Meccanismi molecolari del rilascio di
neurotrasmettitore
4.3
Neurotrasmettitori
4.4
Integrazione sinaptica
Trasmissione sinaptica
4.1
Trasmissione sinaptica
Nei capitoli precedenti abbiamo descritto come le cellule
eccitabili generano i segnali elettrici caratteristici del
sistema nervoso (i potenziali d’azione) e in che modo
essi si propagano lungo le bre nervose (la conduzione
assonale). In questo capitolo descriveremo le modalità
di comunicazione tra le cellule eccitabili e i meccanismi
molecolari che rendono possibile il passaggio del segnale
elettrico da una cellula eccitabile a un’altra. Sebbene
tali meccanismi siano oggetto di studio da lungo tempo,
i dettagli molecolari non sono ancora completamente
conosciuti. La loro caratterizzazione rimane tuttora uno
degli obiettivi principali della siologia cellulare che è
alla base di fenomeni importanti quali la percezione, il
movimento, l’apprendimento e la memoria.
Il trasferimento dei segnali elettrici tra cellule ecci-
tabili ha luogo in regioni specializzate dette
sinapsi
.
La cellula che invia il segnale e la cellula che lo riceve
sono denite rispettivamente
cellula presinaptica
e
cellula postsinaptica
. Lo spazio che sicamente separa
le due cellule comunicanti è lo
spazio intersinaptico
o
fessura sinaptica
.
Nella sinapsi, l’efficienza di trasferimento del
segnale è garantita sia dalla stretta vicinanza tra cellula
presinaptica e cellula postsinaptica (la fessura sinaptica
varia da 2-4 a 30-50 nm) sia dall’ampia supercie che le
due cellule utilizzano per la comunicazione.
Sulla base della strategia di comunicazione, le
sinapsi sono suddivise in due categorie:
sinapsi elet-
triche
e
sinapsi chimiche
. Nelle
sinapsi elettriche,
il
potenziale d’azione (o il potenziale graduato) passa
direttamente dalla cellula presinaptica alla cellula post-
sinaptica. Nelle
sinapsi chimiche,
il potenziale d’azione
generato dalla cellula presinaptica causa l’esocitosi di
vescicole sinaptiche
e la liberazione di un
messaggero
chimico
nella fessura sinaptica, il
mediatore sinaptico
o
neurotrasmettitore
. Il neurotrasmettitore si lega a
una molecola recettoriale (
recettore di membrana
)
che dà poi origine a un segnale elettrico nella cellula
postsinaptica (
Fig. 4.1
).
SINAPSI ELETTRICHE
Sebbene più frequenti negli invertebrati, le sinapsi elet-
triche sono presenti anche nei vertebrati. Nell’uomo, la
comunicazione intercellulare avvienemediante sinapsi
elettriche in particolari regioni del sistema nervoso cen-
trale, nel tessutomuscolare liscio e cardiaco e nei tessuti
neuroendocrini.
Nella sinapsi elettrica, le cellule sono separate da
una fessura sinaptica così stretta da poter essere consi-
derata come uno spazio virtuale (circa 2-4 nm). Inoltre,
tra le cellule presinaptica e postsinaptica esiste una vera
e propria continuità elettrica garantita dalle
giunzioni
comunicanti
(
gap junction
). Per questo motivo, nella
sinapsi elettrica la trasmissione avviene attraverso un
meccanismo molto simile a quello della propagazione
del potenziale d’azione lungo le bre nervose.
GIUNZIONI COMUNICANTI:
CONNESSONI E CONNESSINE
Le giunzioni comunicanti sono delle regioni di mem-
brana contenenti particolari canali acquosi detti
connessoni
. Nella giunzione comunicante a ogni
connessone della cellula presinaptica corrisponde un
connessone giustapposto della cellula postsinaptica.
Ogni connessone è costituito da 6 subunità proteiche
chiamate
connessine
che, disposte in circolo, delimi-
tano un poro acquoso centrale. Le connessine sono una
famiglia di proteine il cui pesomolecolare varia tra 26 e
56 kDa. La nomenclatura utilizzata le individua proprio
per peso molecolare (ad esempio la connessina 43 è la
connessina di 43 kDa). Esse sono diversamente espresse
nelle varie specie e nei vari tessuti. Talvolta diversi tipi
di connessine possono coesistere nella stessa cellula.
Sebbene il loro pesomolecolare sia diverso, esse hanno
struttura e caratteristiche biosiche simili: sono com-
poste da 4 segmenti transmembranali e terminali NH
2
e COOH intracellulari (
Fig. 4.2
).
A prescindere dai diversi tipi di connessine presenti,
il poro acquoso del connessone ha un diametro di circa
CAPITOLO
4
















