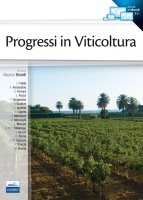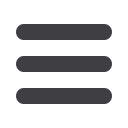
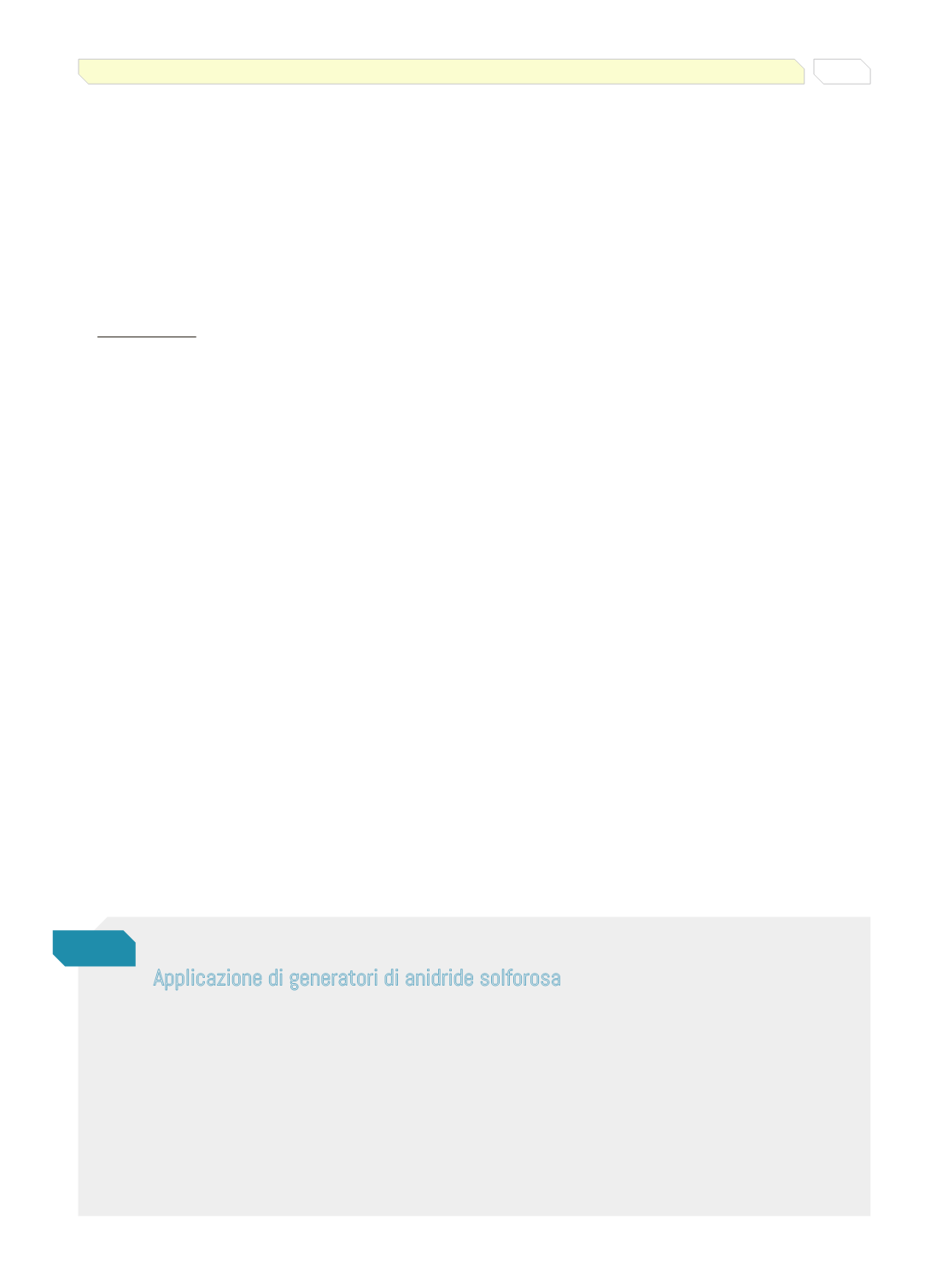
235
Malattie biotiche ed abiotiche nella fase post-raccolta dell’uva da tavola
con temperature di poco superiori a 0°C, fino a oltre 30°C. Il micelio è ancora attivo alla temperatura di 0°C, ma anche
di qualche grado inferiore. La sporulazione e l’infezione hanno luogo solo in presenza di elevata umidità. I conidi del
patogeno possono dare origine all’infezione in qualsiasi punto della bacca, anche se il sito preferenziale è la zona prossima
al peduncolo (
Figura 11.14
); sottoponendo le bacche a un congelamento rapido e superficiale, si mettono in evidenza le
infezioni latenti (Sanzani
et al
., 2012). Sono più suscettibili le uve a grappolo serrato e quelle con bacche a buccia sottile,
come pure i grappoli provenienti da vigneti coperti con teli di plastica per il ritardo della raccolta e, pertanto, lungamente
esposti a elevata umidità, rugiada e basse temperature. Solitamente, la malattia non interessa le uve da tavola precoci o le
varietà coperte per l’anticipo di maturazione. Lesioni di natura abiotica (ad es. grandine) o biotica (ad es. attacchi di tigno-
la, oidio, etc.) verificatesi in campo favoriscono lo sviluppo della malattia in post-raccolta. Grazie all’azione di enzimi de-
gradativi, il patogeno può dare origine all’infezione mediante penetrazione diretta e passare alle bacche contigue (“nidi”).
Misure di lotta
.
L’uva è un prodotto di difficile manipolazione in post-raccolta, poiché l’allontanamento della pruina
costituisce un difetto estetico che incide negativamente sul valore commerciale. Gli interventi di lotta in post-raccolta,
quindi, non possono essere basati sull’uso di trattamenti liquidi, bensì su sostanze gassose, ove ammesse. Il prodotto per
eccellenza per proteggere l’uva in post-raccolta dagli attacchi di
B. cinerea
è l’anidride solforosa (SO
2
) che, peraltro, ha
un uso problematico (presenza di residui, induzione di allergie nell’uomo). Pertanto, assumono fondamentale importanza
gli interventi pre-raccolta. In sintesi, questi si basano sull’impiego di antibotritici specifici applicati in particolari fasi di
sviluppo dei grappoli, tenendo in considerazione specifici parametri climatico-ambientali. L’efficacia dei fungicidi è molto
condizionata dal fenomeno, ormai comune, dello sviluppo di popolazioni resistenti del fungo (De Miccolis Angelini
et al
.,
2016), che presuppone un’attenta diversificazione dei principi attivi impiegati. È, in ogni caso, sempre opportuno adottare
tutti quegli accorgimenti che riducono la suscettibilità e le occasioni di infezione, come, non eccedere con le concimazioni
azotate e con l’irrigazione; praticare la sfogliatura per permettere una migliore copertura dei grappoli con i prodotti fitosa-
nitari e ridurre il ristagno di umidità; limitare l’attacco di fitofagi e lo sviluppo di altre malattie, come l’oidio, che possono
aprire importanti vie di penetrazione sia per la muffa grigia, sia per altri patogeni (ad es. agenti del marciume acido); ridurre
le occasioni di ferite provocate dalle operazioni di raccolta e confezionamento (per questo motivo e per non rovinare la
pruina, spesso queste operazioni vengono effettuate direttamente in campo). Da non sottovalutare, inoltre, la resistenza
varietale la quale, oltre a essere legata agli aspetti morfologici e anatomici del grappolo, dipende anche dallo spessore
della buccia. Immediatamente dopo la raccolta è molto importante effettuare la pre-refrigerazione, necessaria per limitare
la disidratazione, rallentare l’attività metabolica e bloccare o ridurre lo sviluppo di tutti i marciumi, compresa la muffa
grigia. L’anidride solforosa, con il suo effetto microbistatico o microbicida, in relazione ai tempi e alle dosi di applicazione,
riesce a proteggere efficacemente le bacche dalle nuove infezioni di
B. cinerea
e a limitare in qualche modo le infezioni
latenti ed incipienti, permettendo la conservazione e il trasporto a lunga distanza. Le limitazioni nell’uso della SO
2
e i pos-
sibili effetti allergici verso alcune categorie di consumatori hanno incentivato molto la ricerca di mezzi alternativi di lotta
(Ippolito
et al
., 2010). Questi annoverano l’uso dell’AC (atmosfera controllata), dell’ozono, di vapori di alcool o di acido
acetico e peracetico, di sali quali carbonati e bicarbonati di sodio e di potassio, di cloruro e chelati di calcio, di antagonisti
microbici, etc. (Nigro
et al
., 2006). Alcuni di questi mezzi, che non hanno bisogno di particolari autorizzazioni, trovano
già applicazione in un contesto di protezione integrata. È un fatto, comunque, che nessuno di essi riesce a proteggere l’uva
frigoconservata dalle infezioni con la stessa efficacia dell’SO
2
[
Approfondimento 1
].
❯
❯
APPROFONDIMENTO 1
Applicazione di generatori di anidride solforosa
L’anidride solforosa (SO
2
) è un gas dotato di un’elevata
attività antimicrobica. In relazione alle dosi e ai tempi di
esposizione, tutti i microrganismi presenti sulla superfi-
cie dei frutti trattati possono essere completamente devi-
talizzati. Pertanto, è efficace nella prevenzione sia delle
nuove infezioni, sia nella diffusione delle infezioni per
contatto (“nidi”), mentre le infezioni già in atto non sono
ben controllate. In Italia l’uso di anidride solforosa per la
conservazione e il trasporto dell’uva da tavola era con-
sentito fino al 1996. Successivamente, fino al 2008, il suo
uso è stato proibito. Con il decreto del 27 febbraio 2008
concernente la disciplina sugli additivi alimentari, il suo
uso è stato riammesso, con un residuo massimo ammesso
di 11 ppm. Tuttavia, non in tutti i Paesi in cui l’uva viene
esportata ne è consentito l’impiego, per cui il suo utilizzo
deve preventivamente essere concordato con il cliente,
in considerazione delle diverse normative locali vigenti.
L’applicazione della SO
2
mediante fumigazione è risul-
tata poco pratica, mentre trova il favore degli operatori
l’applicazione di generatori di anidride solforosa da me-