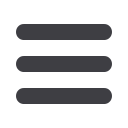
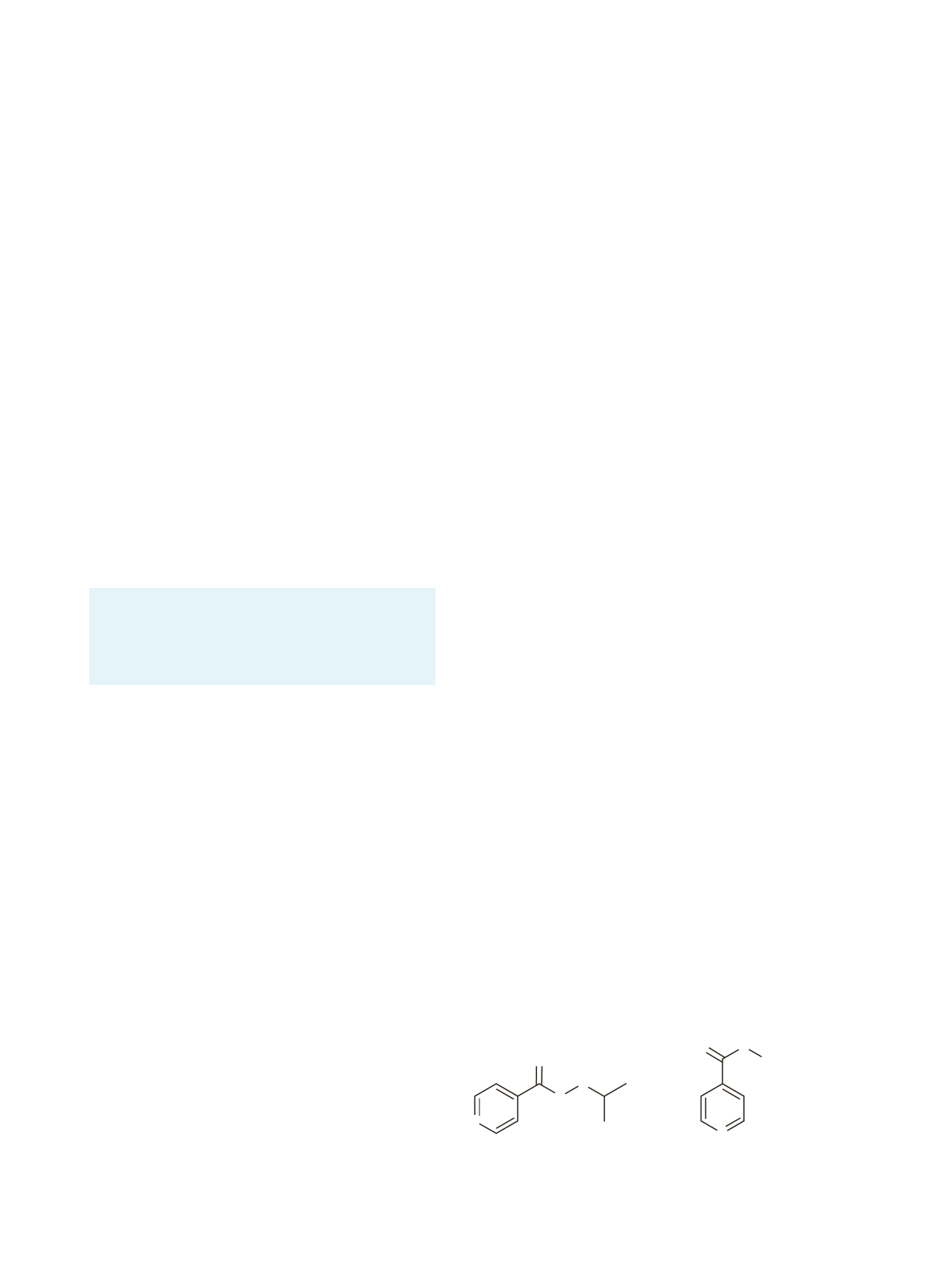
776
Capitolo 29
Farmaci antidepressivi
bete di tipo 1) e, almeno in linea di principio (e in alcu-
ni casi anche in pratica), è possibile identificare il gene
responsabile dell’alterazione e tentare di correggerlo
attraverso farmaci. La complessità della manifestazione
neuropsichiatrica rende problematico pensare di iden-
tificare il ‘gene della depressione’ e, sebbene molti dati
indichino la convergenza di alcuni sistemi, ad esempio
quello delle ammine biogene, l’approccio riduzioni-
sta è ragionevolmente inefficace a spiegare (e a fornire
strumenti per correggere) la complessità della malattia.
Così, vedremo più avanti che i farmaci più usati contro
la depressione sono gli inibitori selettivi della ricaptazio-
ne della serotonina. Ebbene, sarebbe più corretto, ed an-
che clinicamente più utile, chiamare questi farmaci non
‘farmaci antidepressivi’, ma ristabilenti il tono serotoni-
nergico. La correzione dei livelli di serotonina in molti
casi correla positivamente con la risoluzione di alcuni
sintomi legati alla sindrome depressiva, ma il numero di
pazienti che non rispondono alla terapia è sempre alto e,
da un punto di vista opposto, il potenziale terapeutico di
questi farmaci va oltre la depressione maggiore.
Così come per altre malattie neuropsichiatriche, l’im-
piego clinico di farmaci, anche molto efficaci, ha prece-
duto di molto la comprensione delle basi meccanicisti-
che della patologia. Anzi, è stata proprio l’osservazione
che certi farmaci, con un dato meccanismo d’azione,
sono efficaci contro la depressione a permettere di for-
mulare teorie sulla eziopatogenesi. Si tratta di un altro
esempio di approccio ‘farmacocentrico’.
29.3.1
Primi farmaci per la depressione:
inibitori delle MAO
Nei primi anni 1950, farmaci a struttura idrazidica fu-
rono introdotti nel trattamento della tubercolosi (tra
questi, l’isoniazide è ancora il farmaco di prima linea per
il trattamento dell’infezione). In uno studio iniziato nel
1952, fu osservato per serendipità che due idrazidi anti-
tubercolari, l’
isoniazide
e l’
iproniazide
, avevano effetti
diversi a livello del sistema nervoso centrale, essendo
l’iproniazide uno stimolante centrale significativamente
migliore. In realtà quest’effetto fu subito caratterizzato
come effetto collaterale. I pazienti affetti da tubercolosi
trattati con iproniazide mostrarono una ripresa di vita-
lità inaspettata, con un deciso miglioramento del tono
dell’umore (Fig. 29.1).
In particolare, durante le fasi maniacali o di eccita-
mento la persona mostra una disinibizione eccessiva
che porta, in genere, ad assumere comportamenti so-
cialmente inappropriati. Il soggetto in fase maniacale è
euforico e si considera invincibile, sovrastimando ec-
cessivamente le proprie capacità personali. Questo può,
a volte, condurre ad azioni impulsive che mettono fre-
quentemente a rischio la propria sicurezza personale o
quella di soggetti vicini. La sensazione di avere enormi
potenzialità personali può aggravarsi fino a divenire de-
lirio di onnipotenza. Questo quadro di sovrastima por-
ta in definitiva ad uno stato di costante fallimento, in
quanto il soggetto non è in grado di portare a termine
nessuno dei progetti che ha ideato. Il comportamento
è completamente disorganizzato e inconcludente, con
azioni senza alcuna finalità e logica apparente.
In altri casi, invece, la fase maniacale è caratterizza-
ta non da euforia, ma da disforia, con una sensazione di
subire gravi ingiustizie. Questo quadro disforico si ac-
compagna usualmente a irritabilità, scatti d’ira e intolle-
ranza. La sindrome di persecuzione è propria di questa
fase, che può assumere veri e propri connotati deliranti.
29.3
Substrato biologico della
depressione e approccio
farmacocentrico
La classificazione dei disturbi dell’umore riportata nei
paragrafi precedenti deriva dalla necessità prettamen-
te clinica di elaborare un linguaggio condiviso che ser-
va alle necessità descrittive dei segni clinici e a definire
protocolli accettati per la somministrazione delle cure.
Ad esempio, la diagnosi di depressione maggiore che
abbiamo sopra riportato richiede l’osservazione della
persistenza di un certo numero di sintomi. Questa clas-
sificazione non richiede, in realtà, la presenza necessa-
ria di una base biologica comune, ma in ogni caso che la
depressione sia una malattia biologica del cervello (ma
anche di altri organi) è nozione generalmente accettata.
La traiettoria, nel corso della vita, del decorso clinico del-
la depressione maggiore indica chiaramente l’esistenza
di un substrato biologico. Ad esempio, la comparsa per
molti pazienti di fasi ricorrenti di depressione, con seve-
rità dei sintomi sempre peggiore, intervallate da periodi
di remissione sempre più brevi e meno frequenti, sugge-
risce un progressivo rafforzamento delle basi biologiche,
qualunque siano, nel tempo.
La depressione, come altri disordini psichiatrici, si
differenzia da altre malattie e patologie in quanto la ma-
nifestazione clinica si osserva al livello più elevato della
scala biologica, ossia a livello di complessi sintomi com-
portamentali. Altre patologie si manifestano principal-
mente con alterazioni a livello d’organo o tessuto (ad es.,
il cancro) oppure a livello di omeostasi ormonale (dia-
O
O
N
N
NH
2
N
H
H
N
H
N
Iproniazide
Isoniazide
FIGURA 29.1
Iproniazide e isoniazide, prototipi di farmaci
antitubercolari ad attività antidepressiva.
















