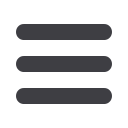
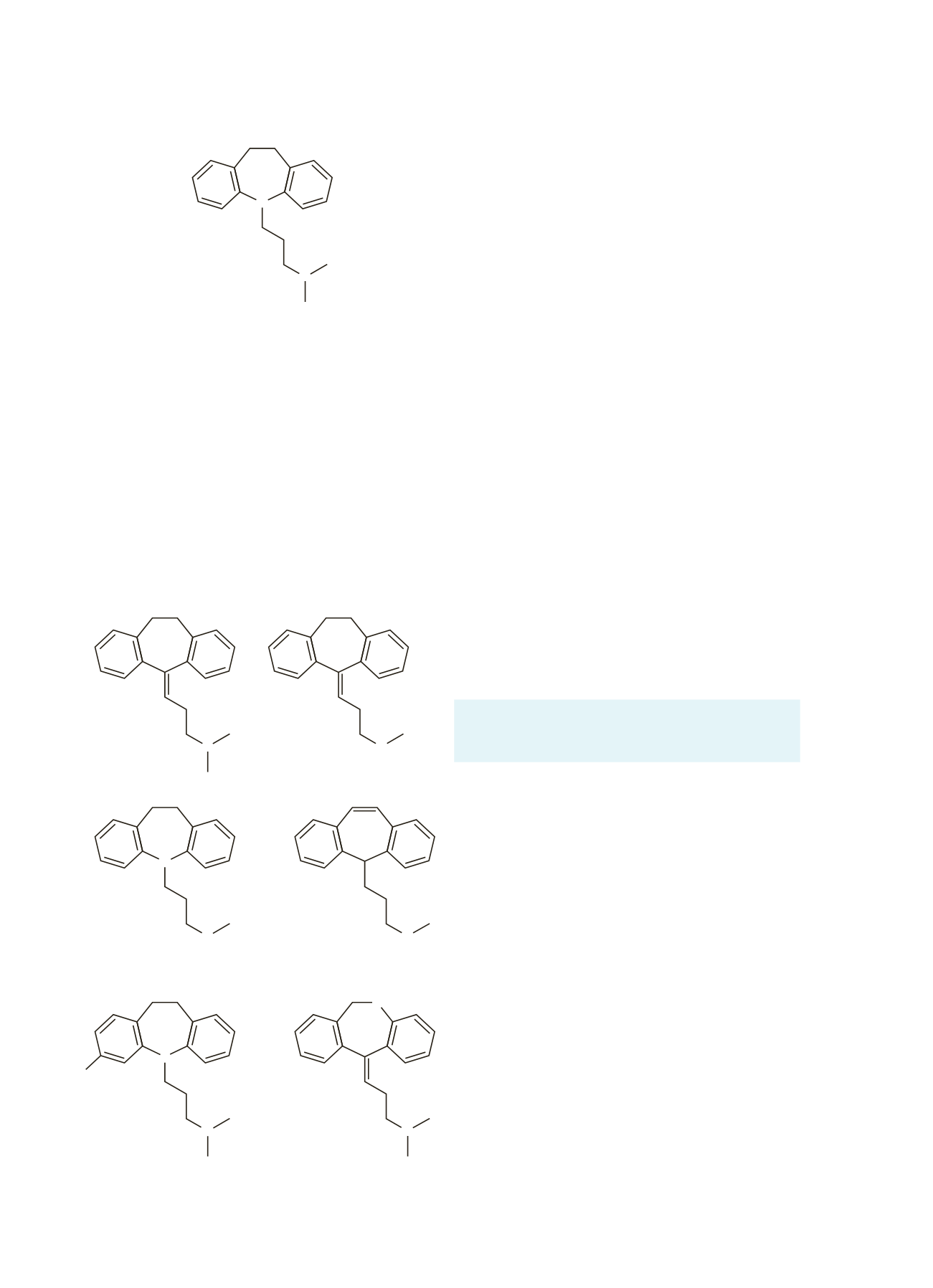
778
Capitolo 29
Farmaci antidepressivi
zienti precedentemente trattati con clorpromazina cui
venne somministrata imipramina ebbero un peggiora-
mento dei sintomi. Fu con stupore, però, che si realizzò
che, somministrata a tre pazienti con disturbo depressi-
vo maggiore, l’imipramina migliorava significativamen-
te la loro sintomatologia. Questi risultati furono rapi-
damente replicati su altri e più ampi panel di pazienti;
l’imipramina fu così introdotta nell’uso clinico come
antidepressivo e da allora è nota come il primo antide-
pressivo triciclico (Fig. 29.4).
Nonostante il grande successo dell’imipramina, per
trovare il secondo antidepressivo triciclico di uso clinico
occorre attendere il 1961, quando fu introdotta l’
ami-
triptilina
. Poi, nel corso degli anni 1960, numerosi altri
triciclici furono sviluppati ed applicati clinicamente. Tra
questi, citiamo la
nortriptilina
, la
desipramina
, la
pro-
triptilina
, la
clomipramina
e la
doxepina
(Fig. 29.5).
Alcuni commenti su similarità e differenze tra antide-
pressivi triciclici e antipsicotici triciclici (vedi Capitolo
25) sono riportati nel Riquadro 29.2.
Da un punto di vista del meccanismo d’azione, espe-
rimenti chiave condotti a metà degli anni 1960 indica-
rono abbastanza chiaramente che il trattamento con
imipramina produceva una riduzione della ricaptazione
della noradrenalina nei terminali sinaptici e questa os-
servazione gettò le basi di quella che divenne l’ipotesi
del deficit di catecolammine nell’eziologia della depres-
sione.
29.4
Teoria monoamminergica
della depressione
29.4.1
Ipotesi noradrenergica
Le ossevazioni che l’iproniazide (un MAO-inibitore)
blocca la degradazione sinaptica di
noradrenalina
, che
l’imipramina (e gli altri antidepressivi triciclici) blocca la
ricaptazione di noradrenalina e che la reserpina (che in-
duce depressione nell’animale modello) provoca deple-
zione di noradrenalina nelle vescicole presinaptiche con-
vergono nel suggerire che la depressione (o per lo meno
molti tipi di depressione) è legata ad una ridotta attività
noradrenergica. Inoltre, il litio, utile nel disordine bipo-
lare, diminuisce i livelli di noradrenalina, coerentemente
con la sua attività antimaniacale.
29.4.2
Ipotesi serotoninergica
Negli stessi anni in cui si imponeva la teoria noradre-
nergica, molti studi convergevano su un possibile ruo-
lo di un altro neurotrasmettitore monamminergico, la
serotonina
. Inizialmente, la teoria si impose senza un
chiaro correlato biologico a livello del SNC e fu basata
su osservazioni relative, ad esempio, al miglioramento
della terapia con MAO-inibitori associati a triptofano (il
di una fenotiazina, nota poi come
clorpromazina
e di-
scussa nel Capitolo 25. L’attività della clorpromazina
suggerì rapidamente la riconsiderazione di molte mole-
cole a potenziale attività antistaminica (l’originale target
delle fenotiazine) per le loro proprietà psicoattive. Nel
1956 venne saggiata per le sue attività antipsicotiche una
molecola, identificata con la sigla
G-22355
, che aveva
la stessa catena laterale della clorpromazina, ma in cui
l’atomo di zolfo del sistema fenotiazinico era sostituito
da un ponte etilenico.
Questa molecola, nota ora con il nome
imipramina
,
non ebbe nessun risultato come neurolettico, anzi i pa-
FIGURA 29.5
Alcuni degli antidepressivi triciclici più
diffusi nell’uso clinico.
N
N
FIGURA 29.4
Imipramina, il primo antidepressivo triciclico.
Amitriptilina
Desipramina
Protriptilina
Clomipramina
Doxepina
Nortriptilina
N
N
N
N
O
CI
N
H
N
H
N
N
H
















