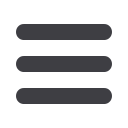
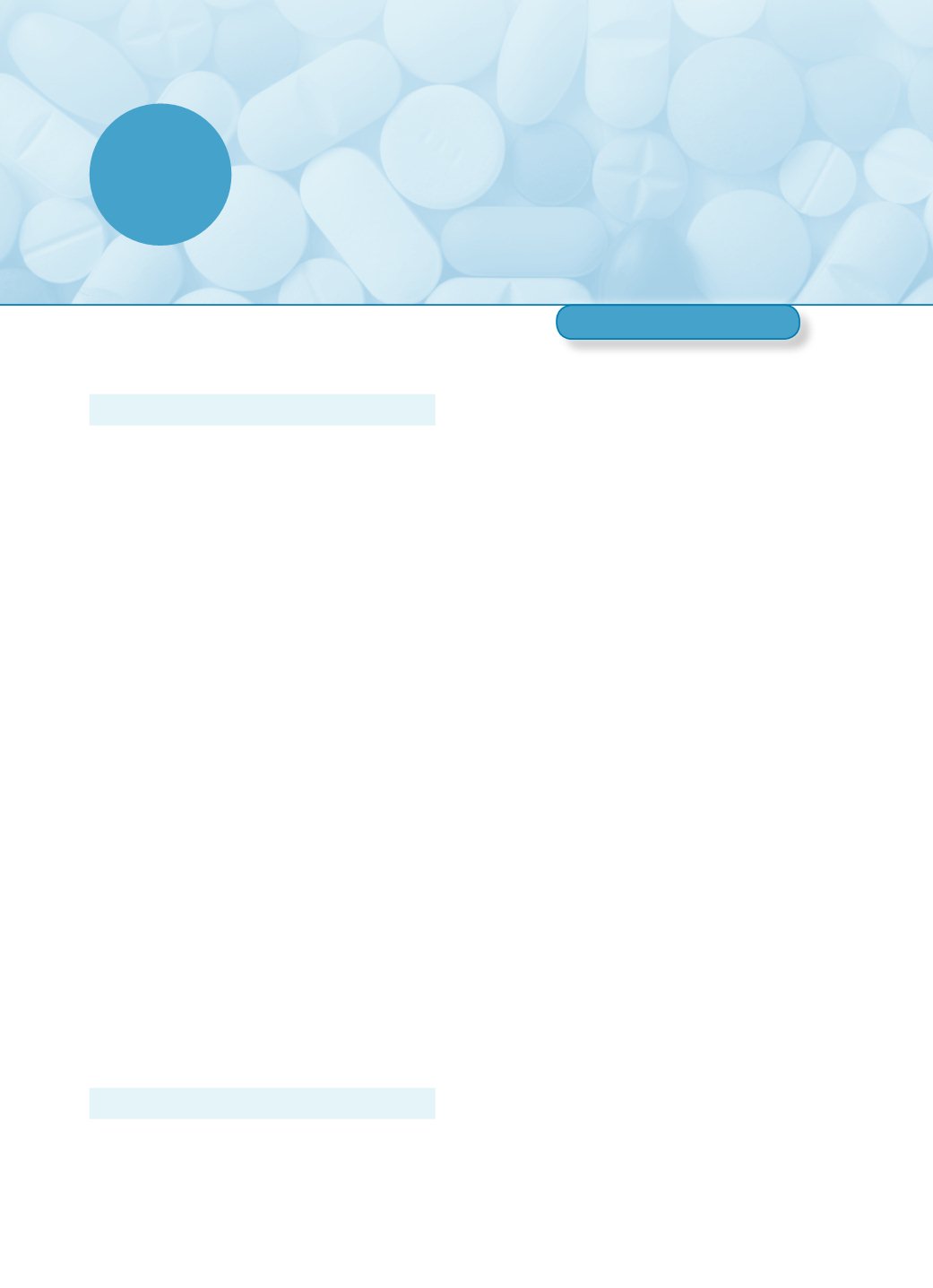
29
Farmaci
antidepressivi
29.1
Introduzione
Ogni persona è dotata di un insieme di caratteristiche
emotive che vengono definite ‘
umore
’. Il tono dell’umore
caratterizza ciascuno di noi, diventa abitudine caratteria-
le ed entra a far parte della definizione del temperamento
di una persona. Così, è nozione comune classificare le
persone come tristi, allegre, dotate di atteggiamento po-
sitivo, di atteggiamento negativo, empatiche, e così via. Il
tono dell’umore sembra essere, quindi, una caratteristica
innata e permanente di ogni individuo, determinata ge-
neticamente e plasmata dall’ambiente in cui l’individuo
cresce e vive.
È anche consapevolezza comune che l’umore di cia-
scuno di noi possa variare, in maniera anche significa-
tiva e drammatica, in occasione di particolari accadi-
menti. Un lutto grave, una delusione sentimentale, un
insuccesso professionale possono comunemente far
precipitare l’individuo in uno stato di prostrazione e di
visione pessimistica e senza speranza del proprio futu-
ro, così come un avvenimento lieto, un successo senti-
mentale o professionale facilmente inducono uno stato
di euforia e di apertura ottimistica verso gli avveni-
menti futuri. In entrambi i casi, queste ‘oscillazioni’ del
tono dell’umore hanno una causa esterna generalmente
ben attribuibile e, con il passar del tempo, l’umore del-
la persona si ristabilisce nel correlato emotivo di fondo
che la caratterizza. L’individuo che ha subito un grave
lutto passa da una situazione di profonda prostrazio-
ne (‘non ce la posso fare’) ad un’accettazione (l’elabo-
razione) che lo riporta nelle condizioni antecedenti.
Vi sono dei casi, però, in cui il tono dell’umore è mo-
dificato non a causa di oscillazioni fisiologiche, ma in
maniera patologica. In questo caso si parla di disturbi
dell’umore.
29.2
Disturbi dell’umore
I
disturbi dell’umore
, a seconda della loro classificazio-
ne, hanno un’incidenza che va dal 3% al 25%. In partico-
lare, il cosiddetto ‘disturbo depressivo maggiore’, con
un’incidenza del 9-20%, è tale da esser considerato
la patologia psichiatrica più diffusa in assoluto. I due
principali e più diffusi disturbi dell’umore sono il distur-
bo depressivo maggiore (depressione grave) e il disturbo
bipolare I. Oltre a questi, sono classificabili altri tipi di
disturbi dell’umore, che citeremo brevemente nel Riqua-
dro 29.1.
29.2.1
Disturbo depressivo maggiore
Con il termine
disturbo depressivo maggiore
si intende
un quadro clinico di modifica dell’umore caratterizzato
da una serie di episodi depressivi maggiori intervallati
da periodi di relativo benessere, e comunque non da
episodi maniacali. Il disturbo depressivo maggiore, per
esser definito tale e per distinguerlo dalle fasi depressive
secondarie ad accadimenti negativi, deve compromet-
tere l’adattamento sociale ed emotivo del soggetto. Gli
episodi depressivi che concorrono a formare il disturbo
depressivo maggiore devono avere una durata non in-
feriore alle due settimane (e generalmente non superio-
re ai 18 mesi) e sono caratterizzati, in termini generali,
da un marcato abbassamento del tono dell’umore, di
intensità tale da compromettere le funzioni lavorative,
affettive e sociali del soggetto. Più in dettaglio, l’episo-
dio depressivo maggiore è caratterizzato dalla presenza
contemporanea e continuativa di almeno cinque dei se-
guenti sintomi:
•
umore depresso continuativamente;
•
anedonia:
il soggetto mostra una marcata perdita di
interesse per gran parte delle attività giornaliere, in-
cluse quelle che normalmente sono fonte di piacere e
soddisfazione;
•
alterazione del peso corporeo ed alterazione dell’ap-
petito. Possono verificarsi sia significativa perdita di
peso che significativo aumento di peso;
•
alterazione del ritmo del sonno. Può verificarsi sia in-
sonnia che ipersonnia. Generalmente, il soggetto con
episodio depressivo maggiore ha esperienza di risve-
glio molto precoce;
•
alterazione dei riflessi psicomotori. Possono verificar-
si sia agitazione che rallentamento psicomotorio;
a cura di
G. Costantino
















