
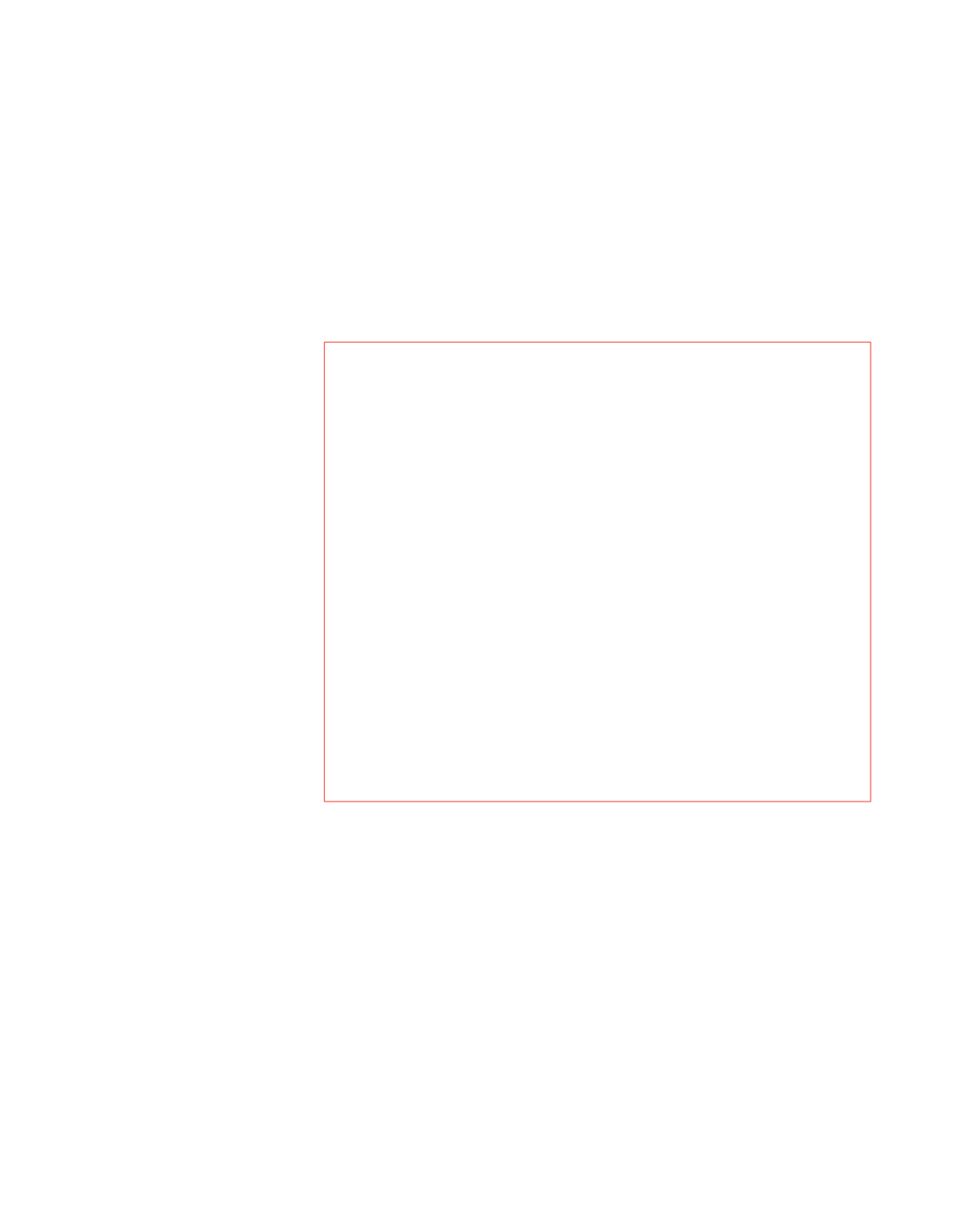
658
Diffrazione
gramma. La luce diffusa da ciascun punto dell’oggetto si sovrappone sulla pellicola fotogra-
fica all’onda di riferimento formando l’ologramma relativo. La figura di interferenza è un po'
più complicata da descrivere analiticamente, anche se la struttura rimane sostanzialmente la
stessa. Quando l’ologramma viene illuminato con lo stesso fascio laser si osservano ancora
due immagini: una virtuale nella posizione occupata dall’oggetto durante la registrazione e
una reale in posizione simmetrica. La differenza di cammino
AB
+
BC
–
AC
può essere
dell’ordine del metro per cui l’utilizzo del laser come sorgente di onde coerenti è essenziale.
Applicazioni dell’olografia si hanno nel campo della microscopia, per osservare confor-
mazioni tridimensionali di piccoli oggetti come le cellule, e nel campo della medicina, dove
ad esempio l’ologramma dell’occhio permette di osservare contemporaneamente retina e cri-
stallino. Sono possibili ologrammi anche con gli ultrasuoni, esistendo attualmente sorgenti
altamente coerenti e rivelatori adatti; gli ologrammi ultrasonici permettono di osservare parti
di organi interni del corpo umano.
16.10 Diffrazione dei raggi
X
I raggi
X
occupano la banda di radiazioni elettromagnetiche con lunghezze d’onda infe-
riori a 10
–9
m; essi vengono prodotti dal frenamento in un materiale pesante di elettroni acce-
lerati da d.d.p. superiori a qualche migliaio di volt oppure quando un elettrone compie una
transizione verso uno dei livelli energetici più interni di un atomo, come abbiamo accennato
nel paragrafo 13.12.
In un normale reticolo di diffrazione ottico i raggi
X
non vengono praticamente diffratti;
ad esempio, con
l
= 10
–10
m e
d
= 10
–6
m il massimo del prim’ordine si forma all’angolo
q
=
l
/
d
= 10
–4
rad = 5.7 · 10
–3
gradi, troppo vicino al massimo di ordine zero per essere osservato.
Invece un reticolo spaziale naturale adatto a produrre la diffrazione dei raggi
X
è un reticolo
cristallino, in cui gli atomi sono disposti secondo strutture regolari con distanze reciproche
molto piccole.
In un cristallo di salgemma gli ioni Na
+
e Cl
–
formano un reticolo cubico di lato
a
.
Ciascuno ione è al centro di una cella cubica di lato
a
e il volume di ogni cella elementare è
a
3
. Unamole di NaCl ha unamassa di
A
= 58.45 kg e contiene 2
N
A
= 2 · 6.022 · 10
26
ioni, occu-
pando quindi un volume
V
= 2
N
A
a
3
. La densità del salgemma è
r
= 2.17 · 10
3
kg/m
3
per cui
Esempio 16.13
Per il dispositivo schematizzato in figura 16.46 calcolare l’ologramma di un punto
materiale distante
x
0
= 50 cm dalla lastra; la luce laser di riferimento ha lunghezza
d’onda
l
= 0.633 mm.
Soluzione
La differenza di fase, come abbiamo dimostrato, è
kz
2
p
z
2
d
=
k
(
r
–
x
0
) = –––– = ––––
2
x
0
l
x
0
e i massimi di interferenza si hanno per
d
= 2
m
p
⇒
z
max
= 2
m
l
x
0
= 0.80
m
mm .
L’ologramma sviluppato è costituito da una serie di corone circolari concentriche anne-
rite di raggi
z
= 0.80, 1.13, 1.39, 1.60, … mm ;
il primo minimo si forma per
z
= 0.56 mm e all’interno di questo si trova il dischetto
centrale scuro.
Il massimo con
m
= 100, che è l’ordine di grandezza del numero di corone circolari
effettivamente realizzabili, dato che esse si infittiscono al crescere di
m
, ha
z
= 8 mm:
l’approssimazione
z
<<
x
0
è ancora ampiamente verificata.
















